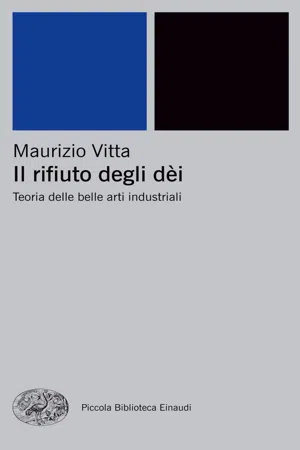![]()
Capitolo secondo
Il rifiuto degli dèi
1. Lo sdegno di Venere.
Perché si fa ancora fatica ad accettare le arti industriali come «arte», ovvero come luoghi di elaborazione formale, produzione di senso, liberazione di sogni e fantasie? In principio fu il marchio della manualità, dell’artigianato, dell’utilità, dell’arte popolare, a segnare tutte le attività sospette di appesantire il puro diletto della creazione con competenze inquinanti: l’orrore per la materia, il lavoro, la corporeità, la funzionalità, ha tenuto a lungo lontane dalle arti liberali perfino l’architettura, accolta infine tra quelle che furono definite «arti maggiori» per ribadire una superiorità gerarchica rispetto alla minuta creatività legata alla produzione di beni. Su di esse incombe, dai tempi piú antichi, il peso di un peccato originale, quello della copula fra ideazione e tecnologia, tra utilità e forma, tra contemplazione e consumo, che la modernità ha aggravato di altre colpe, come quella di attentare alla sacralità della vita per sostituirla con un artefatto (automa, macchina) capace di mimare intelligenza e comportamenti, o quella di concedersi alle masse per semplice profitto, in una sorta di inaccettabile prostituzione.
Questo rifiuto – mai del tutto netto, del resto, e non di rado contrastato – ha una storia, la cui provvisoria conclusione affonda nel vivo della nostra cultura contemporanea. C’è un inizio, naturalmente, che però non è propriamente un cominciamento, ma la sanzione di una vicenda precedente e l’avvio di una fase successiva. Lo troviamo nel De nuptiis Philologiae et Mercurii, un’operetta enciclopedica e didattica scritta nel v secolo da Marziano Capella. Di questo autore si sa solo che fu avvocato a Cartagine, ma è bastato quel suo testo – probabilmente non dissimile da tanti altri dell’epoca, ricordato solo perché sfuggito al naufragio della cultura classica nei secoli barbarici e tenuto come preziosa reliquia di un sapere giudicato magistrale – per assicurargli una posizione preminente. Nel De nuptiis Marziano non solo condensò, sotto i veli di una elegante allegoria, tutte le conoscenze ancora vive nel suo tempo, ma le classificò impersonandole nelle varie discipline, disegnando cosí uno schema enciclopedico che fu preso come modello per i secoli successivi. La struttura narrativa è semplice e nota. Mercurio si unisce in matrimonio con Filologia, e come dono di nozze offre alla sposa le arti del suo tempo, presentandole durante il banchetto nuziale al cospetto di tutti gli dèi. Dinanzi al consesso celeste sfilano cosí, nell’ordine, Grammatica, Dialettica, Retorica, Aritmetica, Geometria, Astronomia e Musica, ciascuna delle quali si presenta con l’atteggiamento e l’iconografia che le sono propri, ed espone minutamente le cognizioni che le appartengono. La sfilata si trasforma quindi in una rappresentazione della cultura dell’epoca, con i vari personaggi che ne incarnano i valori e i contenuti; e fu per l’appunto questo il modello fatto proprio dalla cultura successiva. Come si sa, fin dall’Alto Medioevo il sistema dell’istruzione fu imperniato sulle sette arti, suddivise tra quelle del «trivio» (grammatica, dialettica e retorica) e quelle del «quadrivio» (aritmetica, geometria, astronomia e musica), ossia per l’appunto le sette donate da Mercurio a Filologia.
Nella cultura romana, però, le arti erano nove, giacché comprendevano anche Architettura e Medicina, come aveva già secoli prima attestato Varrone. Ma delle ultime due non c’è traccia nei programmi d’istruzione dell’Europa medievale e moderna, e la spiegazione la troviamo proprio nel racconto di Capella: quando nel libro IX viene il turno di queste due arti, Venere, annoiata dalla lunga e dotta esposizione cui ha dovuto finora assistere, manifesta tutta la sua sdegnata insofferenza, del resto condivisa dagli altri numi. La situazione, alquanto imbarazzante, è abilmente risolta da Apollo: visto che Architettura e Medicina, egli dice, «hanno cura delle cose mortali e sollecitudine per le terrene, e non hanno nulla a che vedere con il cielo e con gli dèi del cielo, non sarà inopportuno che, se saranno respinte con fastidio, taceranno nel senato celeste, destinate a essere interrogate con maggior precisione dalla vergine stessa», ovvero da Filologia.
A prevalere, nel De nuptiis, fu il clima culturale dell’epoca, ancora intriso del pensiero medioplatonico dell’età imperiale e dell’insegnamento di Plotino, con il valore assoluto assegnato alla pura speculazione e il tradizionale dispregio per tutto quanto avesse a che fare con il lavoro e la materia. Ciò non era naturalmente privo di contraddizioni, rintracciabili nel pensiero di Socrate, in alcune riflessioni di Platone e Aristotele, e in qualche accenno dello stesso Plotino, dove non è difficile cogliere la consapevolezza del rapporto paritario tra forma e funzione, o la natura insieme teorica e pratica del progetto di oggetti o di strutture. Ma nel complesso l’esclusione dell’architettura e della medicina dalle «arti liberali», destinate a formare la classe degli intellettuali, divenne definitiva: ogni conoscenza che avesse a che fare con il lavoro, la tecnica, la corporeità, la materia, l’utilità, sarebbe stata da allora in poi rifiutata in quanto impura, contaminata dalla realtà di un mondo terreno da tenere lontano.
Basterà però una lettura piú attenta per scoprire nel testo di Capella prospettive piú intriganti. Architettura e Medicina, le due arti escluse dal divino consesso, sono invitate da Apollo a farsi esaminare a parte dalla sposa. Ma chi era Filologia per la cultura dell’epoca? Questa figura, che per Marziano «ebbe nascita terrena, ma l’intento di tendere alle stelle», era ritenuta la personificazione della ragione umana, dell’anima razionale, impegnata nell’analisi rigorosa di tutte le discipline e portatrice di un sapere superiore perfino a quello degli dèi. Ciò indurrebbe dunque a pensare che l’architettura e la medicina siano state, senza saperlo, le prime discipline che la cultura occidentale ha riconosciuto come moderne, in quanto sottoposte unicamente al vaglio di una razionalità che non aveva alcunché di trascendente, ma si fondava su una logica del tutto terrena. L’una era arte dello spazio, l’altra arte del corpo: in esse la vita rifluiva nella sua sostanza mondana, nella verità dell’esistenza terrena, nella sua profonda sostanza umana. Nel momento stesso in cui una insindacabile condanna le allontanava dalla sfera del sacro e del divino, si installavano da protagoniste nel mondo della storia e delle cose: erano le arti del futuro, destinate, come la loro madrina, ad avere radici nel mondo per tendere alle stelle.
Nell’opera di Marziano Capella si consumò cosí il dramma della cultura occidentale, il divorzio insanabile tra un pensiero che cercava la propria legittimazione solo nella purezza assoluta delle sue manifestazioni e la vita del mondo che procedeva invece lungo gli impervi e fangosi sentieri della quotidianità. Le arti, sublimate in un consesso che le fondeva nel vago concetto unitario di Arte, si soffusero di una luce ultraterrena, di un’aura la cui luminosità avrebbe marcato a lungo la loro presenza tra gli umani. In pari tempo, però, la ferrigna esistenza delle persone e delle cose, la trama inesauribile della vita, il flusso dirompente della storia moltiplicavano il sapere disseminandolo in una miriade di competenze, umili e dignitose, ispirate a una prassi feconda di conoscenze e di realizzazioni sempre piú grandiose, finché queste due grandi visioni del mondo non si confrontarono alla pari nelle arti industriali moderne in un conflitto ancora non del tutto risolto.
2. Una cultura industriale.
La distinzione tra arti liberali e arti meccaniche si snoda in un lungo percorso, punteggiato da dubbi e contraddizioni, ma costantemente ispirato a un’intuizione di Platone, che nel Politico ammise, nel caso dell’architettura, il valore puramente teorico e conoscitivo dell’«arte del calcolo», per cui l’architetto, che non opera direttamente, ma dirige gli esecutori materiali dell’opera, mette a disposizione della costruzione non la manualità, bensí la conoscenza. Il giudizio, che adombrava una prima e vaga idea di «progetto», fu ripreso da Aristotele, Cicerone e Plotino, e riaffiorò durante il XIV secolo nella polemica tra francesi e italiani intorno alla costruzione del Duomo di Milano. In seguito Daniele Barbaro avrebbe precisato il concetto parlando di una «artificiosa generazione» nella quale «si ricerca il discorso e la fabrica unitamente», e cosí anticipando le analoghe osservazioni di Bacone e di Leibniz; e nel XVII secolo il trionfo di una ragione attenta a interpretare concettualmente la realtà delle cose si sarebbe incarnato nel corpo della macchina industriale, celebrata dalla proliferazione dei theatra machinarum e dalle tavole dell’Encyclopédie.
La condanna delle «arti servili» si dissolse però davvero solo nella pragmatica razionalità dell’economia industriale. Adam Smith risolse rapidamente il problema illuminandolo con l’elementare logica della divisione del lavoro, che non dava luogo a distinzioni sociali, ma riconduceva tutto al grado di complessità delle varie incombenze. Nella medesima prospettiva, la «gerarchia positiva della civiltà moderna», suddivisa da Auguste Comte in tre ordini fondamentali, il buono, il bello e il vero, restava sottomessa alla meccanizzazione della produzione. Fu tuttavia un pensatore solitario e appartato come Giacomo Leopardi a battezzare il suo tempo come «l’età della macchina»: ciò che lo colpiva non era tanto il gran numero delle nuove invenzioni industriali, quanto il fatto che «oramai non gli uomini ma le macchine, si può dire, trattano le cose umane e fanno le opere della vita».
Dalle ceneri dell’antica condanna delle arti meccaniche nasceva nel frattempo una nuova figura di protagonista, quella dell’ingegnere, preparato, alacre, infaticabile e soprattutto garantito da una indiscussa legittimazione sociale. Nel 1818 veniva fondato in Gran Bretagna l’Institution of Civil Engineers, cui veniva affidata «l’arte di indirizzare le grandi fonti di energia in Natura a uso e convenienza dell’Uomo». L’ingegneria, espressione di un sapere tecnologico sempre piú dotato di autonomia culturale, si presentava come il prodotto naturale di una scienza che aveva ormai abbandonato l’antica ricerca del perché dei fenomeni, per concentrarsi piuttosto sul come essi si presentano e sui modi per riprodurli a piacere. Ma alle radici dell’incastellatura istituzionale della nuova professione – scuole politecniche, associazioni di categoria, ordini professionali, un crescente prestigio sociale – fermentava il grasso terreno dell’economia capitalistica, che vedeva nella fabbrica e nella produzione industriale la garanzia di un nuovo ordine planetario. Al di là della macchina, si imponeva il culto del prodotto; ma nel prodotto era inciso il freddo calcolo capitalistico, legato agli investimenti, alla politica di mercato, al profitto, alla metamorfosi d’ogni cosa in merce.
Cosí la tecnologia apparve sempre piú legata a una cultura industriale di matrice economica, segnata da squilibri di classe e da un pragmatismo pronto a disciogliere perfino l’aura mitica delle arti tradizionali. La nota osservazione di Marx e Engels – «La borghesia ha spogliato della loro aureola [Heiligenschein] tutte le attività che fino ad allora erano venerate e considerate con pio timore» – comprende in sé, implicitamente, un giudizio sulle belle arti. Da lí alla Perte d’auréole di Baudelaire il passo fu breve. L’architettura in ferro e poi in cemento armato, il disegno industriale, la fotografia, e piú tardi il cinema, presero a plasmare il mondo in forme nuove, messe a disposizione da una tecnica sempre piú duttile e raffinata, che modificò radicalmente il processo creativo ponendolo al cospetto della razionalità produttiva industriale e delle sue seducenti potenzialità. Dinanzi a questo nuovo e confuso panorama – impasto di produzione meccanica, riproducibilità tecnica, serialità, consumo di massa, progettualità – le adesioni si alternarono alle critiche e alle ribellioni. Da un lato affiorò lentamente una razionalità che prometteva creazioni moderne assai piú rappresentative di quelle antiche; dall’altro il timore della fredda impersonalità tecnologica, della dipendenza nei confronti delle macchine, del cedimento agli avidi interessi economici del capitalismo invitava a rifuggire da quelle chimere. Tra il richiamo di stampo socialistico di William Morris a una originalità ricondotta alle sue matrici artigianali, l’estenuato estetismo di John Ruskin, con la sua nostalgia vittoriana per l’antica manualità, e la rivolta contro la dipendenza umana dalle macchine proclamata da Thomas Carlyle correva un filo sottile: era la difesa del pezzo unico contro l’uniformità del prodotto industriale, la rivendicazione della libertà dell’artista rispetto alle regole di mercato, il culto del valore incalcolabile di una creatività lontana dalla concorrenza, dalla diffusione standardizzata, dalla dipendenza dagli interessi industriali. Ma il mutamento era troppo radicale per poter essere arginato col semplice rifiuto (il disprezzo per il gusto borghese idealizzato per un verso dalla Bohème e dalla Scapigliatura, e per un altro dal Decadentismo) o con l’alternativa artigianale. In effetti, già a metà del XIX secolo esso era penetrato in ogni aspetto dell’esistenza quotidiana, e non ultimo negli inviolabili recinti dell’arte. I preraffaelliti inglesi potevano proclamare l’assoluta purezza della loro pittura, ma si servivano largamente della fotografia per elaborare le loro opere; l’architettura in ferro era relegata tra le semplici opere di servizio, ma si imponeva ovunque per l’arditezza e la funzionalità delle sue soluzioni; la forma delle cose reclamava sempre di piú un disegno capace di conferire bellezza ai prodotti industriali piú imponenti (treni, transatlantici) come a quelli piú modesti (gli oggetti d’uso), la cui fruizione di massa fu considerata addirittura indice di democratizzazione (i designer del Liberty sostenevano di voler portare la bellezza in tutte le case). Perfino le belle arti dovettero scendere a patti con le nuove condizioni: la Statua della Libertà, ideata da Bartholdi come simbolo della moderna democrazia, fu progettata come un oggetto tecnico (la complessa armatura in acciaio e rame progettata da Gustave Eiffel) e come un prodotto industriale (la scomposizione dell’opera in quasi duemila pezzi studiati per il trasporto via mare e l’assemblaggio in opera).
Permaneva l’antica diffidenza per le arti meccaniche, ma si ammetteva l’impiego delle nuove tecniche in opere ispirate alla tradizione. Le stazioni ferroviarie mantennero rigorosamente separate le strutture in ferro e vetro, destinate alla movimentazione dei convogli, da quelle di facciata disegnate secondo il lambiccato gusto storicistico ed eclettico dell’epoca, mentre altrove le intelaiature metalliche furono adattate ai linguaggi del passato, ipotizzando una sorta di classicismo strutturale (Henri Labrouste) o razionalizzato (Jean-Nicolas-Louis Durand), fino ad arrivare al gotico moderno di Eugène Viollet-le-Duc. Nel frattempo il mercato dei nuovi oggetti prodotti industrialmente si faceva sempre piú ampio, e la fotografia si imponeva per i suoi bassi costi e la facilità d’impiego dei nuovi apparecchi («Voi schiacciate il bottone, noi facciamo il resto», proclamava la Kodak, che nel 1895 vendeva i suoi pezzi per pochi spiccioli).
La contraddizione fu nitidamente espressa da un inascoltato Samuel Butler, il quale alla fine del XIX secolo disegnò una società immaginaria che aveva eliminato le macchine dal suo orizzonte, relegandole nei musei come reperti storici non privi di un loro valore estetico, ma che ne aveva sottolineato la pura funzione strumentale, al servizio degli umani, in un progressivo sviluppo che le avrebbe viste evolversi esattamente come gli organismi studiati da Charles Darwin. Ciò che piú conta, però, è che in Butler c’era già la consapevolezza che la presenza dei nuovi mezzi tecnici avrebbe modificato la stessa struttura antropologica dell’essere umano: «Queste cose hanno contribuito a farci come siamo», avvertí con molto anticipo sui tempi. D’ora in avanti, gli dèi avrebbero avuto bisogno di altri interlocutori.
3. Arte e industria nel XX secolo.
L’arte e la tecnica si erano incrociate nel XIX secolo, ma solo per specchiarsi l’una nell’altra. Nel XX, il loro confronto si condensò nel binomio «arte e industria», che divenne la parola d’ordine del disegno industriale inaugurato dal Bauhaus. All’inizio del Novecento la realtà industriale si era evoluta in cultura, e aveva trovato nel mito della «macchina» la sua rappresentazione piú vivida, evidente ormai nelle piú minute pieghe dell’esistenza quotidiana. Già un quadro, Il romanzo di una cucitrice (1908), di Umberto Boccioni, aveva fatto affiorare un nuovo panorama domestico: nel dipinto, una scena di genere – una giovane donna seduta accanto a una finestra luminosa di fiori e di verde, intenta a leggere un libriccino, con il vestito che l’ammanta come un bianco velo – è completata, in un inatteso contrappunto, dalla presenza di una macchina per cucire, oggetto tecnico nuovissimo, che spezza l’atmosfera di idillio tipica di queste tradizionali raffigurazioni. La modernità era penetrata nella normalità dell’esistenza attraverso la novità dei suoi oggetti tecnici, tanto che la pittura era stata costretta ad accoglierla nel proprio spazio ancor prima che il manifesto futurista la rivelasse. In seguito, la cultura progettuale avrebbe assunto la realtà industriale come criterio di razionalità, indispensabile per far fronte alle urgenze della società di massa. L’architettura indicò, con Le Corbusier, il suo modello nelle fabbriche di aeroplani; Ricciotto Canudo parlò del cinema come della «settima arte», mentre Pirandello osservava con interesse la riduzione dell’artista a «una mano che gira la manovella»; nella neonata Urss il Proletkult guardò con diffidenza gli influssi futuristi sull’arte proletaria, ma incoraggiò gli artisti a utilizzare le nuove tecniche, dalla fotografia alla stereografia, al cinema, alla registrazione. L’arte assisteva cosí alla propria moltiplicazione: alle sue manifestazioni tradizionali, altre se ne aggiungevano, suscitando entusiasmi, perplessità, avversioni o ferventi adesioni.
Ignorata dal pensiero accademico, la cultura industriale penetrò irresistibilmente nel profondo dell’esperienza quotidiana modellandola in nuove forme. Il dandy baudelairiano finí con l’indossare dannunzianamente la tuta da aviatore, fino a ridursi alla sua versione borghese offerta dall’aeropittura del Secondo Futurismo. Il cinema, dal canto suo, si impose come modello narrativo e dispiegò tutte le sue potenzialità affabulatrici nella proliferazione dei generi, mentre il disegno industriale si affermava in un prorompente cosmopolitismo tecnologico – la radio, il telefono, l’automobile, gli apparecchi domestici tecnicizzati, standardizzati e diffusi nella stessa forma in tutto il pianeta – come annuncio di un gusto nuovo e, ciò che piú conta, di un nuovo modo di concepire il mondo e di viverlo. John Dewey colse questo passaggio quando osservò che «i sobborghi industriali contribuiscono a creare quella piú larga esperienza per cui particolari prodotti si adattano in modo tale da assumere una qualità estetica», al punto che l’essere umano moderno, immerso in una «esperienza satura di questi valori» troverà negli «oggetti che hanno un’interna organizzazione funzionale» un senso della forma capace di confrontarsi con quella dell’arte.
La modernità realizzata a partire dagli anni Trenta del Novecento ...