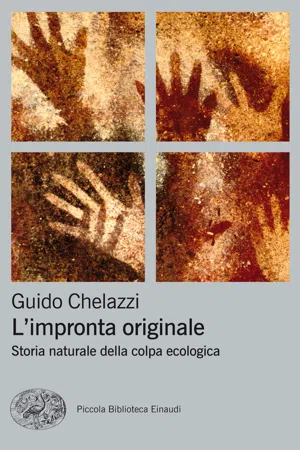![]()
Fin dove risale la memoria storica l’uomo ha sempre vissuto se stesso e le proprie condizioni di esistenza come un enigma; egli è per se stesso un tema inesauribile, grazie alla sua capacità di contrapporsi (in quanto «soggetto») al mondo in cui vive (gli «oggetti»). Questa presa di distanza dal mondo è la premessa necessaria per impadronirsene, e quindi anche la premessa delle eccezionali attitudini dell’uomo.
Questa frase è contenuta in uno dei foglietti ritagliati dall’enciclopedia che il signor Geiser, smemorato protagonista di Der Mensch erscheint im Holozän di Max Frisch, appiccica alle pareti di casa mentre fuori diluvia e tutto frana in una remota valle della Svizzera. Affiorando alla sua memoria in dissoluzione un lontano paesaggio dell’Islanda emette una vaga profezia nichilista: «Probabilmente saranno i pesci a sopravviverci, e gli uccelli». E dopo aver vaneggiato di ere geologiche e di minerali, di ghiacciai e di salamandre, e aver riempito la casa di citazioni enciclopediche, lo stadio finale del suo distacco dalla realtà lo porta a concludere:
Tutti i foglietti, che siano sulla parete o sul tappeto, possono scomparire. Che significa Olocene! La natura non ha bisogno di nomi.
Olocene è il nome che gli scienziati riuniti a Bologna per il Convegno internazionale di Geologia del 1885 decisero di adottare per designare l’ultima epoca del Quaternario. Benché la maggior parte della vicenda di Homo sapiens si sia svolta nel corso della parte finale del Pleistocene, la sua vera identità di specie fuori dagli schemi ecologici convenzionali si è rivelata soprattutto nell’Olocene. Se comprimessimo l’intera storia della Terra in un giorno, la presenza umana risalirebbe all’ultimo minuto e l’Olocene agli ultimissimi istanti. Eppure è nel corso di questa epoca, iniziata poco piú di 10 000 anni fa, che secondo una visione corrente gli ecosistemi del pianeta, regolati per i precedenti milioni di anni da fattori sostanzialmente climatici, sono passati sotto un dispotico dominio umano. Di questo gli scienziati ne hanno coscienza almeno da quando il geologo e biologo russo Vladimir Vernadsky nel 1926 ha sottolineato come, oltre a trasformare la superficie terrestre, l’uomo abbia addirittura modificato i grandi cicli biogeochimici di elementi fondamentali quali il carbonio o l’azoto. La visione corrente è quella ben rappresentata da alcuni dei piú influenti ecologi – riuniti dalla carismatica figura di Peter M. Vitousek – che quasi dodicimila anni dopo l’inizio dell’Olocene hanno consegnato alla comunità scientifica e all’opinione pubblica una riflessione-statodell’arte dal titolo Human domination of Earth’s ecosystems, dove si elencano tutte le principali sfaccettature dell’enorme impronta ecologica dell’uomo contemporaneo. Un esperimento planetario realmente inedito e dall’esito molto incerto è in corso e noi, insieme al resto del pianeta, ne siamo i protagonisti e le cavie. L’esperimento potrebbe aver già portato a dover staccare dalla parete il foglietto con scritto «Olocene» e a sostituirlo con un nuovo nome: «Antropocene».
1. Folla planetaria.
Crescete e moltiplicatevi! Abbiamo preso alla lettera l’autorevole raccomandazione. Dalla fine del Pleistocene e per tutto l’Olocene la riproduzione è stata, insieme alla mobilità, il motore della diffusione di Homo sapiens nelle aree disabitate del pianeta o in quelle unilateralmente dichiarate tali a spese di chi ci abitava prima di lui. Il lavoro di costruzione delle nicchie antropiche iniziato alla fine del Paleolitico e proseguito nel Neolitico, nell’Età del Bronzo e oltre, si è basato largamente sull’applicazione di questo principio e i suoi risultati hanno favorito a loro volta, retroattivamente, la crescita demografica dell’uomo. Nel corso della storia dei popoli la riproduzione è stata spesso il mezzo con cui si sono imposti agli altri i propri geni, le proprie ideologie, i propri modelli economici, insomma la propria civiltà. Questo principio continua a essere in auge anche oggi che il sapiens world club ha ormai festeggiato lo sfondamento della soglia dei sette miliardi di membri. La demografia storica ci racconta i numeri degli ultimi due millenni: nel primo anno dell’era volgare la popolazione mondiale ammontava a poco meno di 190 milioni di individui (le stime indicano una forbice tra 170 e 330 milioni), che divennero quasi 300 nel Mille, superarono quota 600 nel 1700, mentre all’inizio del XX secolo erano 1,65 miliardi per poi raggiungere 2,5 miliardi nel 1950 e 6,2 miliardi nel 2000. Negli ultimi venti secoli la densità globale di Homo sapiens è quindi cresciuta da 1,4 a 45,8 abitanti per chilometro quadrato. Questa impetuosa crescita non è stata costante né ugualmente distribuita, ma si è realizzata in modo diverso nelle differenti aree della Terra. Nel segmento storico I-XVII secolo la crescita demografica annua è stata dello 0,07 per cento in Europa e in Asia, dello 0,1 in Africa e dello 0,03 in America settentrionale. Tra il 1700 e il 2000 i valori sono stati 0,56 per cento in Europa, 0,75 in Asia, 0,78 in Africa, 1,87 in America settentrionale e 1,26 per cento in America meridionale. I maggiori incrementi hanno coinciso con le fasi di sviluppo socioeconomico delle diverse popolazioni, come nel caso della metallurgia del bronzo nel Vicino Oriente e in Europa, la Rivoluzione industriale del XVIII secolo, e la globalizzazione del secondo dopoguerra, mentre le stasi o le regressioni demografiche sono state determinate dalle crisi politiche e dalla stagnazione economica, dal declino degli imperi e dalle grandi epidemie. Qualche volta hanno influito le variazioni climatiche che si sono registrate anche nell’Olocene, sebbene con intensità minore delle ultime fasi del Pleistocene, ma altre volte l’uomo si è rovinato da solo mangiandosi le risorse senza pensare alle conseguenze future. Mediamente però, con alterne vicende, la popolazione globale di Homo sapiens ha subito una crescita senza precedenti e questo costituisce una parte notevole del problema ecologico attuale.
Come è cominciata questa storia demografica? Quanti erano gli uomini del Paleolitico Inferiore e Medio, quando ancora il mondo non aveva conosciuto Homo sapiens, e cosa è avvenuto all’inizio della nostra vicenda, tra Paleolitico Medio e Superiore? E dopo, come si è arrivati attraverso l’Olocene ai numeri della demografia storica e contemporanea? Queste domande sono rilevanti per comprendere come si sia determinata la tirannide ecologica della nostra specie, perché l’impatto antropico globale sul pianeta è cresciuto sí con il peso specifico di ciascuna impronta, ma anche con l’aumentare del loro numero!
I paleodemografi si sono ingegnati in molti modi per tentare di ricostruire i numeri degli uomini sulla Terra nel lontano passato, quando non esistevano anagrafe e censimenti. Un metodo si basa sull’idea che esista una relazione tra la quantità di tracce archeologiche di un determinato periodo e il numero di uomini che nello stesso intervallo di tempo abitavano una determinata regione. Per tradurre la frequenza dei reperti nella stima della densità di popolazione occorre però risolvere una serie di problemi, il principale dei quali deriva dagli errori tafonomici, cioè dal fatto che le tracce si perdono con il passare del tempo e che tracce diverse presentano una persistenza diversa in ambienti differenti. Disponendo di estesi archivi di reperti archeologici datati al 14C e calibrati con una precisione accettabile, si riesce tuttavia a ricostruire i profili demografici con una buona affidabilità. Un altro modo è quello di studiare la demografia delle popolazioni «pre-industriali» storiche o ancora presenti in differenti habitat e zone climatiche per stimare quanti dovevano essere i nostri antenati cacciatori-raccoglitori alla fine del Pleistocene. Questi metodi paleodemografici sono affetti da incertezza statistica e, dato che si basano su una serie di ipotesi, i risultati devono sempre esser presi con beneficio d’inventario. Però, incrociando le stime ottenute con i vari metodi, si riesce a ricavare almeno l’ordine di grandezza delle popolazioni preistoriche e ad avere un’idea delle loro variazioni in termini relativi.
Anche i genetisti hanno iniziato a metter bocca in queste faccende, cercando nella variabilità delle popolazioni attuali i segni delle remote variazioni numeriche di Homo sapiens. Per farlo si utilizza lo stesso metodo della coalescenza che ha permesso di ricostruire l’età di Eva mitocondriale e di Adamo Y. L’idea che sta alla base della paleodemografia genetica è che la probabilità che due genotipi hanno di condividere un antenato nella precedente generazione è inversamente proporzionale al numero di individui che compongono la popolazione. Se si ricostruisce indietro nel tempo tutta la genealogia genetica fino all’antenato comune piú recente, la distribuzione delle coalescenze genetiche si presenta in modo diverso per una popolazione che si è mantenuta numericamente stabile o per una che si è espansa. Nel primo caso, le coalescenze sono relativamente uniformi mentre, nel secondo, si concentrano nella parte piú remota dell’albero, vicino all’antenato comune.
La genetica indica che da una popolazione africana dell’ordine delle decine di migliaia o al massimo di qualche centinaio di migliaia di individui si sarebbe staccato il nucleo di 100-1000 individui che ha dato luogo a tutta l’umanità attuale. Il DNA dei mitocondri e quello del cromosoma Y portano tracce di una strozzatura demografica tra 200 000 e 100 000 anni fa, seguita da una fase di espansione tra 100 000 e 50 000 anni fa. Questo quadro è sostanzialmente coerente con l’idea di un evento di speciazione che avrebbe dato origine a Homo sapiens a partire da qualche popolazione africana del Pleistocene Medio, seguita dall’emigrazione dal continente originario da parte di un piccolo gruppo di individui che poi avrebbero iniziato a diffondere e a espandersi demograficamente. Prendendo in considerazione marcatori genetici e aplogruppi diversi, si possono ricostruire le fasi successive di questa vicenda, scoprendo che tanti crolli demografici, episodi di fissione ed espansioni hanno accompagnato la conquista della Terra. A ogni collo di bottiglia corrispondeva l’assunzione di configurazioni genetiche specifiche in una determinata area del pianeta, dato che l’effetto fondatore e la deriva genica producevano la fissazione di un determinato assetto genetico e la scomparsa degli altri aplogruppi. Tra gli eventi che hanno lasciato cosí la loro impronta ci sono quelli che hanno prodotto le popolazioni dell’Eurasia occidentale o dell’Australia circa 50 millenni fa e quello che ha segnato la colonizzazione delle Americhe, geneticamente databile a circa 10,5 millenni fa.
Tra alti e bassi, la diffusione dell’uomo anatomicamente moderno nelle varie regioni del pianeta fu accompagnata da una prima crescita demografica globale. Le stime canoniche parlano di una popolazione mondiale pre-sapiens di circa un milione di uomini nel periodo compreso tra 1 milione e 500 000 anni fa, che sarebbe leggermente aumentata fino a raggiungere 1,3 milioni alla transizione tra Paleolitico Medio e Superiore. Si stima che poi, in alcune decine di migliaia di anni, alla fine del Paleolitico, l’umanità «sapiente» abbia superato i 5 milioni. In uno studio che attinge ai dati della paleoclimatologia e dell’etnografia, i paleodemografi francesi Jean-Pierre Bocquet-Appel e Pierre-Yves Demars hanno ricostruito nei dettagli le vicende demografiche occorse in Europa occidentale tra l’arrivo di Homo sapiens e l’inizio dell’Olocene. Lo scenario paleoclimatico iniziale è quello del MIS3, un periodo in cui una grande massa ghiacciata si estendeva su gran parte dell’Europa settentrionale e il livello del mare era circa 30-80 m al di sotto dell’attuale. Le grandi pianure europee comprese tra i 51 gradi di latitudine Nord e le Alpi erano ricoperte da una vegetazione mista di prateria e foresta boreale, un biotopo simile all’attuale Canada settentrionale, idoneo per sostenere una comunità di grandi mammiferi come le renne e i loro predatori, rispettivamente prede e competitori dell’uomo. Seguendo un principio di uniformità etnologica, secondo cui l’assetto socioeconomico e demografico dei cacciatori-raccoglitori moderni ricalca quello dei popoli che in passato abitavano in habitat simili, i ricercatori hanno preso a modello delle popolazioni di sapiens del Paleolitico Superiore i gruppi etnici che vivevano nelle regioni dell’America settentrionale e del Canada al momento dell’arrivo degli Europei e di cui si conoscono le densità e le variazioni demografiche in rapporto al clima: i Chippewyan, gli Han, i Mountain, i Naskapi e, in generale, le etnie del dry boreal parkland nordamericano, con densità che variavano tra 0,0042 e 0,0182 abitanti per chilometro quadrato.
Utilizzando queste informazioni e considerando i quasi tremila siti archeologici europei abitati tra 40 e 11 millenni fa si può stimare la dinamica demografica della fase terminale dell’ultima glaciazione e della transizione post-glaciale. Nel periodo Aurignaziano (40 400-31 000 anni fa) la popolazione dell’Europa nordoccidentale (Francia, sud dell’Inghilterra, Germania, Paesi Bassi) ammontava a oltre 4400 abitanti (la stima varia tra 1700 e 28 000); durante il successivo Gravettiano (31-23 500 anni fa) era di quasi 4800, per poi passare a 5900 durante il massimo glaciale, circa 22 000 anni fa. Superata la grande crisi della glaciazione, si registrò una forte espansione demografica, con una popolazione complessiva di quasi 29 000 abitanti (le stime sono comprese tra 11 000 e 73 000) intorno a 18 millenni fa. Le rappresentazioni spaziali dei risultati dimostrano che l’Aquitania e la Cantabria costituirono le aree rifugio entro cui le popolazioni si ritirarono durante i periodi glaciali piú intensi senza subire una evidente riduzione demografica, per poi dilagare nuovamente verso l’Europa centrale e settentrionale nel periodo tardo-glaciale, con numeri maggiori di prima. La capacità di superare le crisi climatiche mediante un riallineamento geografico senza subire alcuna significativa riduzione demografica la dice lunga sull’autonomia ecologica già raggiunta fra 40 e 18 millenni fa da parte di Homo sapiens. L’immagine generale che si ricava da queste analisi è che la preistoria demografica dell’uomo moderno, inizialmente non dissimile da quella degli uomini che l’avevano preceduto nella dispersione eurasiatica, abbia precocemente imboccato una strada che attraverso una serie di turbolenze gli consentiva tuttavia di mantenere, su tempi lunghi, tassi di incremento mediamente positivi e di raggiungere elevati livelli di numerosità complessiva.
Viene quindi da chiedersi se il comportamento demografico di Homo sapiens abbia sempre seguito le stesse regole generali che governano le popolazioni degli altri organismi o se i fattori che hanno dato forma alla sua demografia siano stati totalmente diversi, ed eventualmente quando e come la sua demografia si sia differenziata da quella dei suoi predecessori e di altri animali. Antropologi, demografi ed ecologi hanno affrontato il problema da angolature diverse, utilizzando metodi e concetti differenti che solo recentemente mostrano segni di convergenza. Benché della questione si fossero occupati già molti filosofi, compreso David Hume, il primo a entrare con decisione empiristica sull’argomento è stato un notissimo studioso vissuto in Inghilterra tra la metà del XVIII secolo e il XIX: il prete anglicano Thomas Robert Malthus. Nella sua opera An Essay on the Principle of Population pubblicata nella prima edizione nel 1759, «Pop», come lo chiamavano i suoi scolari, enunciò il principio secondo cui le popolazioni, «data l’attrazione incontenibile tra i sessi», hanno la potenzialità di accrescersi «geometricamente», cioè con andamento esponenziale, e lo farebbero fino a raggiungere, generazione dopo generazione, una densità infinita se non intervenisse qualche forma di limitazione esterna. Secondo Malthus questo limite è imposto dal progressivo ridursi delle risorse: al crescere della densità della popolazione la quantità di risorse disponibili per ciascun individuo diminuisce, innescando processi di mortalità o di riduzione della fertilità, con il risultato di una regolazione naturale. Queste idee ebbero una grande influenza su Darwin e Wallace, che videro nella competizione per le risorse la struggle for life, il fattore che a ogni generazione porta alla eliminazione selettiva del surplus di individui lasciando nella popolazione solo quelli che riescono a sfruttarle piú efficacemente e quindi a vivere piú a lungo e a riprodursi con maggior successo. Il ragionamento malthusiano, oltre a influenzare lo sviluppo della teoria dell’evoluzione per selezione naturale, ha segnato di fatto la nascita della demografia biologica e di quella parte dell’ecologia che studia il rapporto tra le popolazioni e l’ambiente: la demoecologia.
L’idea della regolazione causata dalla competizione per le risorse è stata codificata in forma matematica da molti teorici della demoecologia. Una celebre formulazione è quella che va sotto il nome di «funzione logistica», escogitata nel 1838 dal matematico belga Pierre François Verhulst, secondo cui una popolazione che colonizza un nuovo habitat a partire da una densità iniziale molto bassa va incontro a un accrescimento esponenziale che, però, rallenta al crescere della densità. La crescita si arresta completamente quando la popolazione raggiunge un valore massimo imposto dalla competizione per le risorse. Il termine che usano i demoecologi per la densità massima possibile è quello di «capacità portante» (carrying capacity). In questa ottica, la regolazione avviene attraverso la variazione dei due fattori demografici fondamentali: fertilità e mortalità. All’aumentare della densità la prima si riduce, mentre la seconda aumenta e la rapidità della crescita dipende proprio dal rapporto tra le due. Insomma, la dipendenza dell’accrescimento dalla densità garantirebbe una regolazione automatica delle popolazioni naturali.
Che la regolazione demografica umana segua semplici leggi biologiche di tipo malthusiano, secondo cui la mortalità e la riduzione della fertilità dovuta alla sottonutrizione scattano automaticamente quando la popolazione raggiunge la capacità portante è, però, un concetto ostico alla maggior parte degli etnologi perché nelle attuali popolazioni di cacciatori-raccoglitori la densità di popolazione sembra mantenersi sempre ben al di sotto della capacità portante teorica. È opinione comune tra gli antropologi che i meccanismi attraverso cui le società dei cacciatori-raccoglitori si mantengono a densità basse abbiano a che fare piú con elementi di tipo culturale e sociale che non con la «potatura» del surplus demografico dovuta alla carenza di risorse. Lo zoologo inglese Vero C. Wynne-Edwards, noto per aver introdotto il discusso concetto dell’evoluzione di gruppo, ha descritto con il termine di «omeostasi demografica» l’insieme dei meccanismi comportamentali di regolazione della densità nelle popolazioni animali e umane. L’economista inglese Edwin Cannan e il demografo Alexander Carr-Saunders, agli inizi del XX secolo, hanno enunciato al riguardo un principio di ottimalità, secondo cui nelle popolazioni pre-industriali la regolazione, volontaria e culturale, fa sí che la densità si mantenga intorno a un valore pari al 20-30 per cento della capacità portante teorica, che assicura il massimo di risorse pro capite. Per inciso, Carr-Saunders – nel suo libro del 1922 The Population Problem. A Study in Human Evolution – è stato tra i primi ad analizzare l’impatto a cascata che l’incremento demografico delle popolazioni umane nel corso dell’Olocene ha avuto sulle comunità biotiche del pianeta.
Molti antropologi ed etnologi ritengono che i dispositivi socioculturali che regolano la densità nelle popolazioni di cacciatori-raccoglitori, oltre ai conflitti intra- e inter-etnici, comprendano meccanismi di limitazione piú o meno volontari della riproduzione: ritardo dell’inizio dell’età riproduttiva, celibato, tabú sessuali, lattazione prolungata, aborto, infanticidio. In particolare, sull’infanticidio come meccanismo di regolazione demografica nelle società di cacciatori-raccoglitori si è sviluppata una vasta letteratura, basata molto spesso piú sul sentito dire che su evidenze certe, e molto marcata dal pregiudizio. Solo in rari casi si sono raccolte informazioni dirette a sostegno dell’idea che tra i cacciatori-raccoglitori questa sia una pratica che contribuisce sostanzialmente alla regolazione della riproduzione e quindi della densità di popolazione. Piuttosto, l’infanticidio – soprattutto quello femminile – sembra essere una pratica che si è affermata nelle società stanziali di allevatori-agricoltori dopo il Neolitico e rappresenta ancora oggi una drammatica piaga sociale in varie popolazioni umane di paesi a differenti livelli di sviluppo, come denunciato da numerose recenti indagini sullo sbilanciamento del rapporto numerico tra i sessi in aree dell’Africa e dell’Asia.
Quali che siano i meccanismi, biologici e culturali, che legano la fertilità e la mortalità alla disponibilità di risorse, è fuor di discussione che per la maggior parte della preistoria e della storia di Homo sapiens la crescita demografica di una popolazione è stata funzione dell’assetto climatico ed ecologico della regione di residenza. Il clima di una determinata area – irraggiamento solare, precipitazioni, escursione termica, regime eolico – influenza direttamente la produttività primaria, cioè la quantità di carbonio organico incorporato in biomassa nell’unità di tempo dagli organismi autotrofi attraverso la fotosintesi. A sua volta, la disponibilità di biomassa primaria influenza la produttività secondaria di un ecosistema, cioè la biomassa dei consumatori. I vincoli metabolici del bilancio energetico fanno sí che alla transizione tra produttori primari ed erbivori si verifichi una perdita di circa il 99 per cento dell’energia e che successivamente, a ogni passaggio di livello della catena trofica, si produca un’ulteriore riduzione del 90 per cento circa. L’ecologo inglese Charles S. Elton – nel suo libro Animal Ecology del 1927 – ha per primo evidenziato come questi rapporti di trasferimento conferiscano alle comunità naturali una struttura di tipo piramidale, in base alla quale la biomassa, l’energia e il numero di individui diminuiscono a ogni successivo livello, dagli erbivori ai predatori di vertice. Una conseguenza della riduzione di energia all’aumentare del livello trofico è che la biomassa – o energia – che una popolazione di consumatori può accumulare in una determinata area è maggiore se riesce ad attingere direttamente anche ai livelli basali della catena trofica che non ne occupa una po...