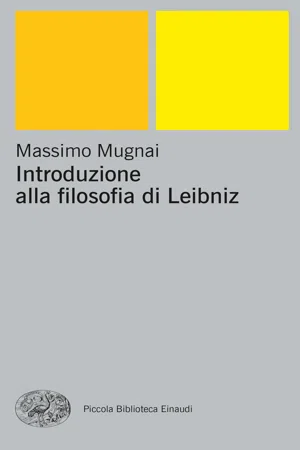![]()
1. La genesi del concetto di “sostanza immateriale” o “monade”. Posizione del problema.
Sebbene Leibniz, nella lettera alla regina Sofia Carlotta, presenti la realtà che ci circonda come un “mondo fenomenico”, che noi stessi contribuiamo a costruire, nella seconda parte di questo scritto1 afferma che tale mondo fenomenico ha il proprio fondamento nell’esistenza di sostanze immateriali. E in altri testi sostiene che i corpi e gli oggetti che percepiamo e vediamo nell’esperienza quotidiana non sono che aggregati di sostanze individuali o monadi2. Cosí, la realtà, gli oggetti e le “cose” di cui abbiamo esperienza sono – al tempo stesso – meri fenomeni, nostre costruzioni e aggregati di monadi o sostanze. Per chiarire questo punto è necessario entrare in qualche dettaglio riguardo alla concezione leibniziana della sostanza.
Leibniz fissa definitivamente la propria concezione della sostanza, – che considera come un ente individuale, un puro spirito in perenne attività, – nel periodo compreso tra la fine degli anni Settanta e la composizione del Discorso di metafisica. Poco dopo, caratterizzerà col nome di monade la sostanza; un altro termine che impiegherà sarà quello di “atomo spirituale”. Le monadi sono «i veri atomi della natura e, in una parola, gli elementi delle cose»3: ciascuna monade non ha parti, non ha estensione né figura né, perciò, può esser divisa in alcun modo.
Le monadi non hanno rapporti diretti tra loro, non agiscono le une sulle altre: questo è il senso della ben nota asserzione, compresa nella Monadologia, secondo la quale «le monadi non hanno finestre, dalle quali possa entrare o uscire qualcosa»4.
Delle varie parti della filosofia leibniziana, quella relativa alla teoria delle monadi appare senz’altro come la piú astrusa: essa venne paragonata da Bertrand Russell a un «racconto di fate»5, e senza un’adeguata comprensione degli argomenti che la sorreggono, sembra il parto di una fantasia filosofica priva di inibizioni. Eppure, nella sua apparente bizzarria, la teoria leibniziana della sostanza ha motivazioni profonde e ben radicate in problemi centrali della scienza dell’epoca e della tradizione filosofica.
A spingere Leibniz a elaborare la teoria delle monadi sono riflessioni concernenti, rispettivamente: A) l’ontologia delle relazioni; B) il problema del continuo fisico-matematico; C) la nozione di forza.
A. L’ontologia delle relazioni.
La teoria delle relazioni ha costituito per lungo tempo un duro banco di prova per gli interpreti della filosofia leibniziana, finché, in anni recenti, la pubblicazione di testi inediti e una piú approfondita conoscenza dell’ontologia logica della tradizione scolastica hanno consentito di gettare una luce chiarificatrice su di essa.
Come ho accennato, il mondo leibniziano è composto da sostanze individuali e dalle proprietà o modificazioni che a tali “sostanze” ineriscono. Questa concezione ha un naturale correlato nell’analisi logico-linguistica: le parti elementari del discorso vengono individuate nel soggetto, nel predicato e nel verbo essere; il verbo essere esprime l’inerire del predicato nel soggetto (o il suo “non-inerire”, mediante l’aggiunta della negazione). All’interno di siffatto schema, tuttavia, rimane problematico il ruolo svolto dalle relazioni. Se infatti il mondo è composto esclusivamente da enti individuali e dalle proprietà che a essi ineriscono, viene spontaneo chiedersi in che senso proprietà corrispondenti a espressioni quali «essere alla destra di Paolo», «essere il vincitore di Dario», «abitare tra Roma e Firenze», ineriscano agli individui che per loro mezzo sono correlati. Naturalmente, anche in un’asserzione del tipo «Tutti gli uomini sono mortali», la proprietà corrispondente a “essere mortale” inerisce a una pluralità di individui (a tutti gli uomini), ma vi inerisce mantenendo, per cosí dire, il medesimo rapporto con ciascun individuo umano: di ciascun uomo si può dire infatti che è mortale. L’asserzione «Paolo è piú alto di Giovanni», invece, non attribuisce una medesima proprietà (“essere piú alto”) a Paolo e Giovanni (questi infatti non è piú alto di Paolo); né si può pensare che all’espressione «esser piú alto di Giovanni» corrisponda una proprietà reale che di fatto inerisca a Paolo, poiché tale proprietà dovrebbe esser tale da far riferimento a Giovanni, e quest’ultimo non può certamente inerire a Paolo. Per adattare la trattazione delle relazioni a un orizzonte ontologico di tipo aristotelico, gli scolastici avevano dato vita a una complessa teoria, dalla quale dipendono le posizioni elaborate da Leibniz6.
A.1. Le relazioni nella tradizione scolastica (e tardo-scolastica). Preliminarmente sarà bene precisare che col termine relazioni designerò quelle che nella tradizione scolastica erano chiamate relazioni reali – sussistenti cioè esclusivamente tra oggetti reali, non tra enti fittizi o “mentali”. Le relazioni venivano pensate come “proprietà di proprietà”, vale a dire come proprietà di secondo livello, fondate su proprietà di primo livello. Per il sussistere, per esempio, di una relazione binaria, tale cioè che coinvolge due individui, si pensava fossero necessari almeno cinque ingredienti: i due individui, o sostanze individuali in questione – detti i termini della relazione (oppure, rispettivamente, il soggetto e il termine della relazione); due proprietà, ciascuna inerente a ciascun termine – chiamate solitamente i fondamenti della relazione; la relazione medesima. Posto che Paolo sia simile a Giovanni sotto il rispetto della sapienza, Paolo e Giovanni sono, rispettivamente, il soggetto e il termine della relazione; la sapienza di Paolo e la sapienza di Giovanni sono i due fondamenti; e la somiglianza è la relazione in senso proprio, che si “innesta” sulle proprietà fondamentali. Questo schema veniva applicato a tutti i tipi di relazione, anche a relazioni che (a differenza della relazione di somiglianza) non sono simmetriche, come “maggiore”, “minore”, “padre” ecc. In tal caso, i fondamenti non sempre appartenevano alla medesima specie: se Sofronisco era padre di Socrate, in Sofronisco il fondamento della paternità era riconducibile alla categoria dell’azione, mentre il fondamento in Socrate era riconducibile alla passione. Una tesi standard della concezione aristotelico-scolastica era che ciascuna relazione non simmetrica si dovesse “dividere” in due parti – la relazione propriamente detta e la sua conversa – ciascuna delle quali veniva attribuita a un soggetto. Cosí, la paternitas veniva attribuita a Sofronisco e terminava in Socrate, mentre la filiatio veniva attribuita a Socrate e terminava in Sofronisco7. A questa prospettiva ontologica corrispondeva, in ambito logico-linguistico, il tentativo di analizzare in termini di enunciati aventi forma soggetto-predicato gli enunciati nei quali entrano relazioni.
A.2. La concezione leibniziana delle relazioni. Duplice natura delle relazioni: «soggettiva» e «oggettiva». In Leibniz si ritrovano entrambi gli aspetti caratteristici della problematica tradizionale circa le relazioni – vale a dire, sia l’idea che le relazioni si fondano su proprietà intrinseche agli enti correlati sia il proposito di darne un’analisi logica che le riconduca a enunciati in forma soggetto-predicato.
Leibniz fornisce due diverse caratterizzazioni della natura delle relazioni: da un lato afferma che le relazioni sono puramente mentali, la loro natura risiedendo nella possibilità che almeno due cose, due oggetti qualsiasi, vengano pensati insieme; dall’altro sostiene che le relazioni “risultano” dai soggetti correlati e dalle loro proprietà fondamentali (talvolta parla addirittura di “supervenienza”: le relazioni supervengono [superveniunt] non appena esistono i soggetti correlati)8. L’idea che le relazioni risultino dalle singole sostanze con le loro modificazioni è un’idea diffusa nella tarda scolastica e corrisponde all’intuizione secondo la quale, se esiste Socrate con una certa proprietà fondamentale (per esempio, l’esser filosofo) e se esiste Platone con una determinata proprietà fondamentale (anche in tal caso l’esser filosofo), allora tra Socrate e Platone sussiste immediatamente la relazione di somiglianza. Analogamente, se un dato oggetto A ha una certa altezza e l’oggetto B un’altezza minore, dalla loro semplice esistenza risulta la relazione in base alla quale diciamo che A è maggiore di B. “Risultare” in questo caso significa “emergere”, “venir fuori”, e implica che ciò che “risulta” o “emerge” dipenda totalmente dagli enti (le sostanze con le loro modificazioni) dai quali risulta. La relazione non si insta...