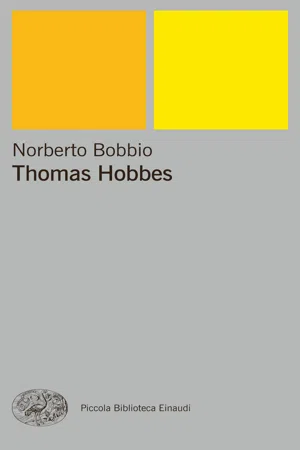
- 240 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Thomas Hobbes
Informazioni su questo libro
A poco piú di quattro secoli dalla nascita del grande filosofo di Malmesbury (1588-1679), questa raccolta dei principali studi di Norberto Bobbio su Thomas Hobbes copre un arco di cinquant'anni di riflessioni e riletture, grazie alla quale è possibile ricostruire non solo la storia del dibattito filosofico-politico in Italia sul filosofo inglese, ma anche piú in generale quella relativa alla centralità dell'analisi giusnaturalistica, ai fini della valutazione dell'importanza del contratto che regola la convivenza tra i cittadini nello Stato.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
II.
La teoria politica di Hobbes
1. Le opere.
Per quanto rivalutato, dagli studi di Ferdinand Tönnies in poi, anche come filosofo, dopo essere stato annoverato per lungo tempo tra i discepoli minori di Bacone, Thomas Hobbes (1588-1679) fu principalmente un filosofo politico. Concepí tutta la materia filosofica divisa in tre parti: De corpore, De homine, De cive: ma quest’ultima, la parte dedicata alla politica, non solo egli compose molti anni prima delle altre (1642), quando l’Inghilterra era alle soglie della guerra civile, ma fu l’unica cui diede forma veramente compiuta, nonostante i due o tre lustri che la separano dalla prima (1655) e dalla seconda (1658), come appare chiaramente a chi esamini le tre parti e le confronti tra loro. Inoltre, la sua prima opera filosofica, Elements of law natural and politic (Elementi di legge naturale e politica), scritta quando la guerra civile non era ancora scoppiata, è, malgrado il titolo, un trattatello completo di filosofia, una specie di prova generale del sistema, dove, peraltro, la parte di gran lunga piú ampia e piú elaborata è quella dedicata alla teoria dello stato, tanto da essere considerata unanimemente come la prima redazione dell’opera maggiore, Leviathan (Leviatano), pubblicata nel 1651. Se infine si tien conto delle varie edizioni curate dallo stesso autore delle opere sin qui nominate e delle opere minori di argomento affine, si vede quanto costante e continuo e preminente sia stato l’interesse per la riflessione politica nella vita di Hobbes:
a) 1640, Elements, già citati;
b) 1642, prima edizione privata del De cive;
c) 1647, seconda edizione pubblicata del De cive, con aggiunte di note di risposta alle obiezioni;
d) 1650, De corpore politico, or the Elements of Law, Moral and Politic, pubblicazione separata della parte di Elements dedicata allo stato;
e) 1651, Leviathan (in inglese);
f) 1666, A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England (Dialogo tra un filosofo e uno studioso del diritto comune d’Inghilterra);
g) 1670, edizione latina di Leviathan, scritta probabilmente in parte prima di quella inglese, ma pubblicata soltanto in tarda età, sostanzialmente immutata, fatta eccezione per qualche correzione di errori nelle dottrine religiose.
Per completare il quadro, si tenga presente quanto sia stata politicamente impegnata e ispirata l’opera storiografica di Hobbes, che comincia con la traduzione di Tucidide, nella quale si assiste, per giudizio concorde dei critici, alla nascita dello scrittore politico, e finisce con la narrazione degli eventi che fanno da sfondo e agiscono da stimolo alle sue riflessioni sulla politica: Behemoth. The History of Causes of the Civil Wars of England (Behemoth. Storia delle cause delle guerre civili inglesi).
Delle opere elencate, essenziali per la comprensione del pensiero politico hobbesiano sono le tre seguenti: gli Elements, la seconda edizione del De cive, l’edizione inglese di Leviathan. Nonostante che quest’ultima sia considerata generalmente la redazione piú completa e piú attendibile, e nonostante vi sia una certa tendenza negli studiosi piú recenti ad accentuare piuttosto che ad attenuare le differenze fra le tre opere, ma piú nel metodo che nella sostanza, il nucleo centrale della teoria si trova già pienamente esposto e dispiegato in Elements, e permane inalterato nelle opere successive.
A differenza della maggior parte degli scrittori politici, Hobbes non si occupò mai attivamente di politica, né come uomo di parte né come consigliere di principi. Fu dunque un filosofo politico nel piú pieno e anche nel piú ristretto senso della parola. A confronto di Machiavelli, egli era soltanto, come ha scritto uno storico inglese, un «dotto». Trascorse gran parte della sua lunghissima vita all’ombra della famiglia Cavendish, conti di Devonshire, prima come precettore, poi come segretario, infine come ospite di riguardo. Nei primi anni compí tre viaggi di studio nel continente (1610-1613, 1629-30, 1634-37), che gli permisero di prender contatto con i grandi filosofi e scienziati del tempo (avvicinò Descartes e Galileo). Alla fine del 1640, prima dell’inizio del Lungo Parlamento (novembre 1640), andò in esilio in Francia, non in seguito a una persecuzione, ma per timore di essere perseguitato avendo scritto e fatto circolare in quello stesso anno un’opera (gli Elements già citati), in cui sosteneva essere la monarchia la miglior forma di governo (cap. V della parte II). Negli undici anni che trascorse in Francia, quasi sempre a Parigi, frequentò i circoli scientifici che facevano capo al padre Mersenne. Nel 1646 fu chiamato a insegnare la matematica al principe di Galles (il futuro Carlo II), esule anch’egli a Parigi. Ma non si legò mai tanto alla Corte da essere costretto ad accettare le conseguenze della disfatta. Instaurata la pace per opera di Cromwell, tornò in patria nel 1651 dopo aver pubblicato la sua opera maggiore, il Leviathan, che gli valse l’accusa, da cui dovette a piú riprese difendersi, e che è di fatto (considerati gli argomenti pro e contro) ingiusta, di aver scritto il libro per ingraziarsi il nuovo vincitore. Certo, nel periodo cromwelliano, avendo potuto godere degli agi del libero studioso, pubblicò le sue opere piú importanti tra quelle non politiche (il De corpore nel 1655; The Questions concerning Liberty, Necessity and Chance, ove raccolse tutti gli scritti della controversia col vescovo Bramhall, nel 1656; il De homine nel 1658). Accettò di buon grado il regime nato dalla rivoluzione che egli aveva aborrito, ma non si compromise mai col nuovo signore sino a tal punto da non poter essere accolto benevolmente da Carlo II, il suo antico discepolo, quando avvenne la Restaurazione (1660). Trascorse la vecchiaia negli studi prediletti, interrotti di tanto in tanto da polemiche, provocate piú spesso da avversari in questioni scientifiche (come il matematico John Wallis) o religiose che non da nemici politici. Per difendere il Leviathan dall’accusa di empietà e di ateismo scrisse An Historical Narration concerning Heresy and the Punishment thereof (1665-66), rimasta incompiuta. Del resto, a parte l’anticlericalismo, la dottrina politica hobbesiana poteva ben essere interpretata e accettata come la giustificazione e l’apologia della Restaurazione: cosí l’interpretò e l’accettò il giovane Locke, quando, lecturer al Christ Church di Oxford, scrisse i suoi due primi trattatelli politici sul magistrato civile.
2. L’idea dominante.
Pur non essendo mai stato un politico militante, Hobbes scrisse di politica partendo dal problema reale e cruciale del suo tempo: il problema dell’unità dello stato, minacciata, da un lato, dalle discordie religiose e dal contrasto delle due potestà, dall’altro, dal dissenso tra corona e parlamento e dalla disputa intorno alla divisione dei poteri. Il pensiero politico di tutti i tempi è dominato da due grandi antitesi: oppressione-libertà, anarchia-unità. Hobbes appartiene decisamente alla schiera di coloro il cui pensiero politico è stato, sollecitato dalla seconda antitesi. L’ideale che egli difende non è la libertà contro l’oppressione, ma l’unità contro l’anarchia. Hobbes è ossessionato dall’idea della dissoluzione dell’autorità, dal disordine che consegue alla libertà del dissenso sul giusto e sull’ingiusto, dalla disgregazione dell’unità del potere, destinata ad avverarsi quando si comincia a sostenere che il potere deve essere limitato, in una parola dall’anarchia che è il ritorno dell’uomo allo stato di natura. Il male che egli paventa maggiormente, e contro il quale si sente chiamato a erigere la suprema e insuperabile difesa del proprio sistema filosofico, è non l’oppressione, che deriva dall’eccesso di potere, ma l’insicurezza, che deriva al contrario, se mai, dal difetto di potere. Insicurezza prima di tutto della vita, che è il primum bonum, e poi dei beni materiali, e infine anche di quella poca o molta libertà che a un uomo in società è concesso di godere.
Negli anni della sua maturità il dissolvimento dello stato in Inghilterra è giunto alla fase estrema della guerra civile. Via via che si passa dagli Elements, scritti prima dei torbidi, al Leviathan, scritto quando la lunga e sanguinosa lotta tra le avverse fazioni è terminata nel regicidio, il tema della guerra civile acquista maggior rilievo: dapprima la guerra civile è un incubo da cui bisogna liberarsi, poi è una calamità che occorre cercare di scongiurare per l’avvenire. Nel paragrafo finale del capitolo VIII della parte II di Elements e del XII del De cive, lo stesso tema delle fazioni che dilacerano lo stato (con la stupenda similitudine di Medea e delle sue sorelle che tagliano a pezzi il padre per farlo rinascere) suscita nella seconda opera per ben due volte l’immagine della guerra civile, mentre la prima parla genericamente di «ribellione». In Leviathan i riferimenti alla guerra civile come al peggiore di tutti i mali sono frequenti1, non solo alla guerra civile in genere, ma a quella che ha infierito o infierisce tuttora, mentre l’autore scrive, in Inghilterra: «Del resto può comprendersi quale sarebbe la maniera di vivere là dove non fosse un potere comunemente temuto, dalla maniera di vivere, che gli uomini hanno tempo fa tenuta sotto un pacifico governo, che è poi degenerata in una guerra civile» (83). Nella prima pagina dell’Introduzione, nella famosa comparazione tra il corpo umano e il corpo politico, la sedizione è paragonata alla malattia, la guerra civile alla morte (5). La guerra civile è un’idea fissa: a proposito delle associazioni disordinate di pensieri, e quindi nella sezione psicologica e non ancora politica del libro, ricorre l’esempio di chi «parlando della presente guerra civile» domanda «quale fosse il valore del denaro romano» (14). In De homine, a proposito della presunzione, ovvero del difetto di coloro che si credono piú saggi di quel che sono, compaiono i giudici che pretendono di dare leggi allo stato anziché applicare quelle poste dal sovrano, con questo commento: «questo suol essere l’inizio della maggior parte delle guerre civili» (XIII, 7).
Nel capitolo I del De corpore Hobbes tesse l’elogio della filosofia. Dalla filosofia naturale sono nate le arti meccaniche che hanno contribuito a migliorare la vita dell’uomo; dalla filosofia civile, ancora infante, l’uomo avveduto può ricavare l’arte di ben governare. E che cosa significa ben governare? Significa costituire lo stato su basi cosí solide da renderne impossibile la dissoluzione, cioè da tener lontano il pericolo della guerra civile, dalla quale, cosí commenta, «derivano le stragi, il deserto e la mancanza di ogni cosa» (I, 7). Subito dopo, parlando di nuovo delle guerre civili, le chiama «le piú grandi calamità». La lingua batte dove il dente duole: proprio nel momento in cui ci spiega che cosa intende per filosofia e quali ne siano lo scopo e l’utilità, la sua attenzione cade di nuovo sul problema della guerra civile: «L’utilità della filosofia morale e civile va giudicata non in base ai vantaggi che traiamo dal conoscerla, bensí in base ai danni che evitiamo con l’ignorarla. Tutti i danni che si possono evitare grazie all’operosità umana, d’altro canto, nascono dalla guerra, soprattutto dalla guerra civile» (ibid.).
Hobbes è spinto a filosofare dal turbamento che suscita in lui il pericolo della dissoluzione dello stato, perché è convinto che la maggior causa del male sia da ricercarsi nella testa degli uomini, nelle false opinioni che essi hanno, o ricevono da cattivi maestri, su ciò che è giusto e ingiusto, sui diritti e sui doveri rispettivamente dei sovrani e dei sudditi. Uno dei temi costanti delle tre opere politiche è la condanna delle opinioni sediziose considerate come la causa principale dei disordini. A proposito del diritto del sovrano di condannare le opinioni contrarie alla salute dello stato, commenta: «Le azioni degli uomini procedono infatti dalle loro opinioni, e nel governare bene le opinioni consiste il buon governo delle azioni riguardo alla pace e alla concordia» (Lev., 116). Nel passo già citato di De corpore, il discorso sul nesso tra filosofia e guerra civile prosegue in questo modo: «La causa della guerra civile sta nel fatto che si ignorano le cause delle guerre e della pace, e che sono pochissimi quelli che hanno appreso i loro doveri, grazie ai quali si rafforza e si conserva la pace, vale a dire la vera regola del vivere civile. Ma la conoscenza di questa regola è appunto la filosofia morale» (I, 7). Nella Prefazione ai lettori del De cive – una delle pagine piú belle dell’opera hobbesiana – paragona ai Centauri, «razza turbolenta e combattiva», i dogmi biformi dei filosofi morali che l’hanno preceduto, «in parte giusti e belli, e in parte brutali e bestiali, causa di tutte le lotte e di tutte le stragi».
3. Il metodo.
Se la causa principale dei mali che affliggono la società civile è di natura filosofica, il rimedio non può essere offerto che dalla filosofia. Ma quale filosofia?
Il problema della buona filosofia, che deve finalmente cacciare la vecchia, che per troppo tempo ha dominato e traviato le menti, è strettamente connesso al problema del metodo. Dopo essersi dedicato per anni esclusivamente a studi umanistici, Hobbes si era convinto, attraverso i contatti avuti nei suoi viaggi continentali con alcuni dei maggiori scienziati del tempo, che le uniche scienze progredite tanto da aver trasformato radicalmente la concezione del cosmo erano quelle che avevano applicato il procedimento rigorosamente dimostrativo della geometria. Non si doveva da ciò presumere che la ragione della arretratezza delle scienze morali fosse da ricercarsi in un difetto del metodo? In un ambiente cosí carico di entusiasmo per i successi delle scienze naturali non era venuto il momento di far percorrere allo studio dell’uomo e della società la stessa strada percorsa con tanto successo dallo studio della natura? La maggior causa di turbamento della pace sociale era, come si è detto, la disparità delle opinioni. Ma la disparità delle opinioni dipendeva essenzialmente dal fatto che i filosofi morali non avevano mai tentato, o per ignoranza o per interesse, di fare della scienza politica una scienza rigorosa. Nella geometria e nelle scienze dimostrative non vi era spazio per dispute oziose intorno al vero o al falso. La geometria – si legge in uno dei tanti brani che si potrebbero citare a questo proposito – «è la sola scienza che finora sia piaciuto a Dio di regalare al genere umano», e poco piú oltre: «le cui conclusioni sono oramai diventate indiscutibili» (Lev., 21, 27). Eppure la filosofia morale era quella piú bisognosa di rigore. E infatti, «se si infiltra qualche errore in ricerche condotte per esercitare la mente, non ne viene alcun danno, se non uno spreco di tempo. Invece, in ricerche eseguite per indicare regole di vita, non solo da errori, ma anche dall’ignoranza nascono offese, lotte, stragi» (De cive, Pref.). Hobbes credeva di sapere che una delle cause dell’arretratezza delle scienze morali era che le loro verità potevano ostacolare «l’ambizione, il profitto o la incontinenza umana» (Lev., 68). Non dubitava che, «se fosse stato contrario al diritto di dominio di qualche uomo o all’interesse degli uomini che dominano “che i tre angoli di un triangolo sono eguali a due angoli retti”, quella dottrina sarebbe stata, se non disputata, soppressa col bruciare tutti i libri di geometria, per quanto poteva colui al quale ciò interessava». Sin dalle prime battute del suo primo libro distingue due specie di sapere, il matematico e il dogmatico, il primo «libero da controversie e dispute», perché confronta unicamente figure e movimento e non interferisce nell’interesse di alcuno, mentre «nel secondo non vi è nulla che non sia soggetto a discussione, poiché confronta uomini e interferisce nel loro diritto e profitto» (Elements, Ep.). Nel paragrafo già citato di De corpore, con un’altra variazione sul tema, contrappone gli scritti «scientifici» dei matematici agli scritti «verbifici» dei filosofi morali, preoccupati soltanto di «ostentare la loro eloquenza e il loro ingegno» (I, 7). In un passo di Leviathan paragona la scienza morale e civile al canocchiale, che permette di vedere le cose di lontano contrapponendola alle lenti moltiplicanti delle passioni che deformano anche le cose vicine (120).
In questa battaglia per una scienza politica rigorosa Hobbes tende ad abbattere contemporaneamente diversi bersagli. L’avversario piú illustre è Aristotele, secondo cui l’etica e la politica non erano conoscenza del certo ma del probabile, dominio riservato non alla logica ma alla retorica: nell’epistola dedicatoria di Elements può sembrare un accenno polemico alla dottrina tradizionale il passo in cui si scusa del cattivo stile dicendo di essersi consultato «piú con la logica che con la retorica». Con questa opposizione alla vetusta e venerata dottrina aristotelica Hobbes fissa uno dei principî piú caratteristici del giusnaturalismo moderno, che perseguirà insistentemente l’ideale di un’etica dimostrativa. La seconda e fittissima schiera di avversari è costituita dagli scolastici vecchi e nuovi che giurano in verba magistri, fondano le loro teorie non sulla ragione e sull’esperienza ma sull’autorità dei precedenti, seguiti senza giudizio vuoi per inerzia vuoi per compiacere ai potenti, e posseggono un sapere soltanto libresco. Hobbes paragona coloro che perdono il loro tempo «a svolazzare attorno ai libri» ad «uccelli che entrati pel camino, e trovandosi chiusi in una camera, svolazzano alla luce ingannatrice di una finestra a vetri, non avendo tanto intelletto da considerare per quale via sono entrati» (22). Altrove li paragona a colui che «fidandosi delle false regole di un maestro di scherma, si avventura presuntuosamente contro un avversario, che o l’uccide o lo ferisce» (30). Poiché i covi infetti di costoro sono le università, la polemica antiscolastica e antilibresca procede di pari passo con la critica delle università, ove lo studio della ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Thomas Hobbes
- Premessa
- Avvertenza
- Thomas Hobbes
- I. Il modello giusnaturalistico
- II. La teoria politica di Hobbes
- III. Introduzione al De cive
- IV. Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes
- V. Hobbes e il giusnaturalismo
- VI. Hobbes e le società parziali
- VII. A guisa di conclusione
- Appendice
- Il libro
- L’autore
- Dello stesso autore
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Thomas Hobbes di Norberto Bobbio in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Philosophy History & Theory. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.