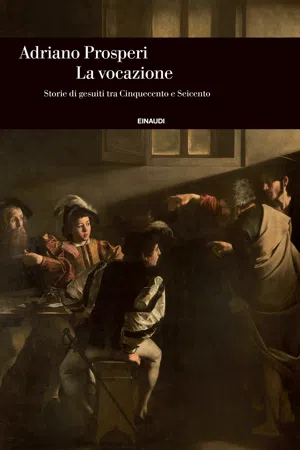![]()
![]()
La relazione inviata da Ottaviano Cesare a Ignazio è il documento di un episodio minore nella piú generale storia della Compagnia. È l’occasione per entrare nel verde paradiso del sogno di redenzione di un adolescente d’altri tempi. Ma, collocato com’è tra le molte narrazioni di «vocazioni illustri» raccolte all’epoca nell’archivio dei gesuiti, invita anche a guardare piú a fondo nella tessitura di testi e contesti. Si tratta di storie reali, di persone per lo piú giovani alla ricerca del modo migliore di investire la loro vita e di come intorno a loro si mossero le persone e le forze che cercavano di ostacolare o di orientare quella loro scelta.
I titoli generali con cui furono selezionate e registrate nell’archivio – Vocationes Illustres («Vocazioni illustri»), prima, Historia Societatis («Storia della Compagnia»)1, poi, come abbiamo ricordato − descrivono il carattere comune dei documenti e la finalità per cui furono raccolti. Erano materiale preparatorio per la stesura della storia generale della Compagnia come storia di una congregazione nata per rispondere a una chiamata divina. D’altra parte anche le scelte di quei giovani erano state sorrette dalla convinzione di essere chiamati da Dio a costruire quella storia. Da qui i caratteri strutturali delle narrazioni. La realtà delle singole vicende vi trova la sua molla ispiratrice e la chiave d’interpretazione nella concezione gesuitica della vocazione. Nella varietà di situazioni, ambienti e protagonisti quella che emerge è la struttura comune del racconto di vocazione.
Ma che cos’era la vocazione? Perché tanta determinazione dei gesuiti nel volersi tenere un giovanissimo adepto fino a entrare in conflitto con le massime autorità della Chiesa di Roma? Li muoveva forse il rispetto della libertà di coscienza del giovane come diritto di ogni essere umano a seguire la sua ispirazione? O non c’era piuttosto una fanatica certezza dell’origine divina della chiamata che il ragazzo aveva sentito dentro di sé? E quanta deliberata strategia di cooptazione c’era dietro le mosse loro fin dall’inizio? Le risposte a queste domande vanno cercate all’interno del modello metastorico del gesuita, quello concepito dal fondatore e portato avanti dalla sua Compagnia.
Un fatto è certo. Non solo il napoletano Ottaviano Cesare ma molti altri giovani suoi coetanei si trovarono a sperimentare contrasti del genere e li raccontarono nei resoconti della loro vocazione. Il caso di Ottaviano, letto accanto a quelli di Cornelis Croock, Andrea Frusio e Alonso de Pisa, ne ha riproposto alcuni caratteri – la svolta risolutiva di incertezze precedenti, il contatto con membri, istituzioni e metodi della Compagnia – e ve ne ha aggiunto uno nuovo: l’età del protagonista. È al compimento dei quattordici anni che Ottaviano acquista un’autonomia di scelta garantita da «leggi divine et humane». Quello è l’avvio della fase degli studi e della riflessione sui progetti per la propria vita. È allora che l’incontro con un collegio gesuitico offre il contesto decisivo e gli ingredienti necessari per farla pendere, la scelta, in una precisa direzione. La dichiarazione della volontà di professare i voti assume qui il valore di un rito di passaggio verso l’età adulta. E il racconto autobiografico si concentra sul taglio netto dei legami con la famiglia e sulla scelta dei voti come ri-nascita nel segno dell’obbedienza assoluta alla nuova famiglia.
Questo modello si ripresenta con varianti e complicazioni di volta in volta diverse. Quanto al rapporto con le famiglie d’origine si possono distinguere diverse modalità, che vanno dalla guerra guerreggiata a una blanda resistenza pronta a cedere e a trasformarsi in entusiastico consenso. Comune a tutte le storie è il carattere della vocazione cosí com’era intesa dai gesuiti: una frattura totale tra un prima e un dopo. Il prima era quello di una vita di compromessi con il mondo, come abbiamo visto, esposta alle tentazioni o anche già immersa nel peccato. Alla famiglia e in particolare al padre spettava in quel disegno un ruolo negativo, per la naturale tendenza a piegare il figlio alla logica di conservazione e accrescimento dell’eredità materiale. Distaccarsene era difficile: anche per la dimensione interiore della resistenza vissuta dal novizio come tentazione.
Quello che si compone attraverso la voce dei protagonisti e dei testimoni è un panorama di varie e mutevoli vicende umane. Vi si trovano storie di gesuiti morti santamente tra le braccia della Compagnia e di altri che invece se ne andarono volontariamente o furono dimessi e ripresi dalle famiglie, o ancora furono espulsi e fecero una brutta fine.
Storie di ribellioni vittoriose e di sconfitte, di brevissime vite di fede presto sigillate da morti sante ma anche di esistenze diventate celebri per imprese memorabili. E anche, qualche volta, di ribellioni vittoriose alla famiglia da parte di adolescenti in cerca della via della salvezza che dovevano sfiorire in fallimenti di adulti.
Quello di Ottaviano, infatti, fu tutto fuorché un caso isolato. Né fu insolita la resistenza della parte femminile, la determinazione della madre nell’ostacolare la scelta del figlio adolescente. Si direbbe che con l’emergere della scuola come canale di affermazione e di conformazione sociale procedesse di pari passo l’emergere di un carattere e un’affermazione della figura materna come dotata di autorità nella e sulla famiglia. Di fatto, la cosa si spiega in molti casi con l’ancor tenera età dei figli quando uscivano di casa per cominciare i loro studi di latino. I genitori per tutelare i figli li mandavano al collegio gesuitico piú vicino; e qui l’intensa pratica sacramentale e la lettura di testi devoti e delle lettere dei missionari dalle Indie cadevano sul terreno già arato dalle devozioni materne stimolando i piú sensibili a combattere i peccati e a seguire la via della perfezione religiosa. Con il risultato che le madri vedevano all’improvviso profilarsi all’orizzonte immediato della loro vita un distacco radicale dal figlio ancora adolescente e fino a un attimo prima tutto in loro possesso. Anche se l’autorità che restava indiscutibile era quella del padre e anche se era a lui che toccava il compito di muoversi nel mondo, il profilo della madre è quello che si disegna spesso dietro la figura maschile e che talvolta si affaccia decisamente in primo piano.
1. Una madre «giudea»: Giovanni Battista Eliano.
Quella della madre del giovane Eliano fu una resistenza alla vocazione del figlio di un tipo speciale: Eliano era membro di una famiglia ebraica. E nei confronti delle comunità ebraiche i gesuiti ebbero allora un’attenzione speciale. Furono loro a dare vita all’istituzione della Casa dei Catecumeni, come luogo dove ospitare e preparare al battesimo chi accettava di passare dall’ebraismo al cristianesimo. Intorno a quell’istituzione si registrarono le tante lacerazioni di affetti materni che nel corso di secoli furono prodotte dal potere di sottrarre i figli minori all’ambiente ebraico: accadeva quando una balia cattolica dichiarava di averli battezzati o il titolare dell’autorità paterna ne faceva donazione alla Chiesa. Non fu questa la vicenda di Eliano. Quando era nato, a Roma nel 1530, gli era stato dato quel nome in omaggio all’avo materno, Elia Levita o Elia Ashkenazi, un celebre dotto a cui si rivolgevano come esperto le comunità ebraiche italiane e tedesche. Quando, ventenne, si convertí al cattolicesimo e fu battezzato a Venezia, volle cambiare il nome in Giovanni Battista Romano: il battesimo era una «nuova nascita» e il contemporaneo ingresso nella Compagnia di Gesú era una rottura con l’antica famiglia. Non piú Elia, il profeta ebraico, ma il Battista, il profeta del Vangelo venuto nel nome di Elia; e Romano in segno dell’appartenenza alla Roma papale. Qui lo chiameremo col nome che si è consolidato nell’uso, Giovanni Battista Eliano2. Dunque un ebreo, di famiglia di alta cultura rabbinica, diventato gesuita: una vittoria speciale della strategia missionaria della Compagnia nei confronti della minoranza ebraica, in un’epoca caratterizzata dalla violenta pressione cristiana sugli ebrei perché si convertissero. Alle origini di quella pressione ci fu la diffusione di attese apocalittiche alimentate dalla scoperta dell’America: la tradizionale convinzione che la fine del mondo sarebbe avvenuta solo quando tutti gli ebrei si fossero convertiti aveva trovato nuovo alimento con la scoperta delle popolazioni del Nuovo Mondo e con l’accelerazione dell’espansione mondiale del cristianesimo. C’era stato il caso dell’ebraismo sefardita della penisola iberica, costretto a scegliere tra l’espulsione e il battesimo. Era nata cosí la categoria dei «cristiani nuovi» o «conversi»: categoria guardata subito con sospetto e divenuta presto vittima di persecuzione nella Spagna imperiale.
Nella fase delle origini della Compagnia l’atteggiamento diffuso nei confronti degli ebrei fu esente da chiusure di tipo razzista. E non pochi furono i casi di gesuiti dalle ascendenze ebraiche. Lo stesso secondo generale della Compagnia, Diego Laínez, era di origine «conversa». Le cose dovevano cambiare alla fine del Cinquecento quando, su pressioni della parte spagnola, la Compagnia si impegnò a chiudere le porte a chi avesse antenati ebrei, cioè sangue ebraico nelle vene3. La conversione e contemporanea vocazione gesuitica di Eliano fu un evento particolarmente importante per almeno due ragioni: le sue origini familiari e il fatto che tutto il processo della conversione si realizzò all’interno della Compagnia. Divenne cosí la prova vivente dell’efficacia di quella strategia della persuasione dolce inaugurata dai gesuiti proprio mentre il papato si avviava sulla strada dei roghi di uomini e di libri. Oltre che mirabile vittoria della Compagnia e glorioso esempio da esibire agli ebrei, quello di Eliano fu per i gesuiti l’insperato acquisto di un maestro di lingue (arabo ed ebraico) rare e preziose per gli allievi del Collegio Romano e di un mediatore culturale e linguistico nell’opera missionaria. Inviato in Egitto insieme con il piú anziano confratello Cristóbal Rodríguez per una missione presso i copti, doveva svolgere poi autonomamente un’altra missione presso i maroniti del Libano. Frutto della sua speciale attenzione al problema delle barriere linguistiche e culturali fu il ricorso alle immagini nella redazione di un catechismo per spiegare la dottrina a illetterati e analfabeti. C’erano dunque tanti motivi per chiedergli di redigere la storia della sua vocazione. Glielo ordinò lo stesso generale Claudio Acquaviva.
Nel metterla per iscritto Eliano volle firmarla sottolineando di suo pugno il significato mistico nascosto nella memoria liturgica della data di quel giorno. Un’attenzione questa, al santo del giorno, che era abituale da parte dei gesuiti. Ma il suo caso fu speciale: era il 24 gennaio 1588, «giorno della conversione di San Paolo», come si legge al termine dello scritto4. Il modello per lui non poteva che essere quello dell’ebreo Saulo diventato l’apostolo cristiano delle genti. A quella data, quando raccontò per iscritto la propria chiamata, Eliano rivestiva l’incarico di penitenziere nella Basilica di San Pietro e aveva alle spalle una rapida e folgorante carriera.
Sembra che il generale gli avesse manifestato da tempo il desiderio di avere una relazione scritta della sua vocazione. Ma ora che gli era giunto l’ordine di farlo era costretto a obbedire, «se ben malvolentieri», come spiegava nella risposta. Era convinto che il dono ricevuto da Dio si dovesse conservare «piú nel cuore […] che manifestarlo con la bocca, o con la penna». Ma poiché quell’avvio della vita nuova era stato dovuto all’irruzione della voce di Dio proprio nel cuore, raccontarlo non era un atto di vanagloria nemmeno quando chi era chiamato a quell’esercizio sapeva di essere uno dei piú illustri membri della Compagnia. Cosí Eliano spiegò come aveva finalmente risolto i suoi dubbi e accantonato le proprie resistenze:
Molto Reverendo in Cristo Padre, il desiderio che V.R. sempre ha mostrato di voler, ch’io le scrivessi la mia vocatione alla fede, et alla santa religione, et quello che ho passato in essa per 37 anni, che per gratia del Signore vi sono stato, et spero con la sua medesima gratia di perseverar sino al fine, io, se ben malvolentieri metto questo in carta, per dover servar i doni del Signore piú nel cuore, secondo quello «secretum meum mihi, secretum meum mihi»5, che manifestarlo con la bocca, o con la penna; non dimeno penso di non far contro, a quello, che detta la conscienza, quando in questo l’ubedirò, come sarò pronto di farlo in ogni altra cosa, che mi commandasse, et tanto maggiormente che raccontando con ogni verità, et sincerità il tutto, mi rinfrescarò la mia memoria, et accenderò il mio affetto in riconoscere i tanti doni, et gratie del Signore, acciò cosí gli sia piú grato, et corrisponda a quelli.
Una resistenza ribadita anche alla fine del racconto. L’aveva scritta «per obedir’a V.R.; et se non mi fosse cosí strettamente stato commandato da V.R., non haverei mai pensato di farlo»6: bisognava esorcizzare la minaccia della vanagloria. Ma alla fine si era piegato all’ordine ricevuto non solo per il dovere dell’obbedienza: si era convinto che rinfrescarsi la memoria delle grazie ricevute gli avrebbe offerto la possibilità di accendere ancora i suoi sentimenti di devozione.
Ritroviamo nella sua storia il punto di svolta consueto: l’esperienza degli studi e quella del collegio gesuitico come luogo dove aveva imparato e dove ora conduceva la sua vita di docente. Ma lui vi era arrivato da piú lontano di tutti, dall’ebraismo. E proprio quell’eredità religiosa e culturale rese la sua conversione un fatto fondamentale nella storia della Compagnia in una fase in cui l’interdizione spagnola contro i cristianos nuevos non aveva ancora cancellato il favore con cui si guardava a chi veniva dal mondo ebraico.
Padre e madre erano ebrei («giudei», scrive Eliano). Il padre era di origine boema ma abitava da anni a Roma. La madre invece era nata a Padova, figlia «di quel grande Elia Ashkenazi, molto conosciuto per i molti suoi libri». E il piccolo che ne aveva ripreso il nome era stato mandato dal nonno a Venezia molto presto, a sette anni, con il progetto che dovesse succedergli nella via degli studi. Era qui che aveva imparato l’ebraico, seguendo gli insegnamenti del nonn...