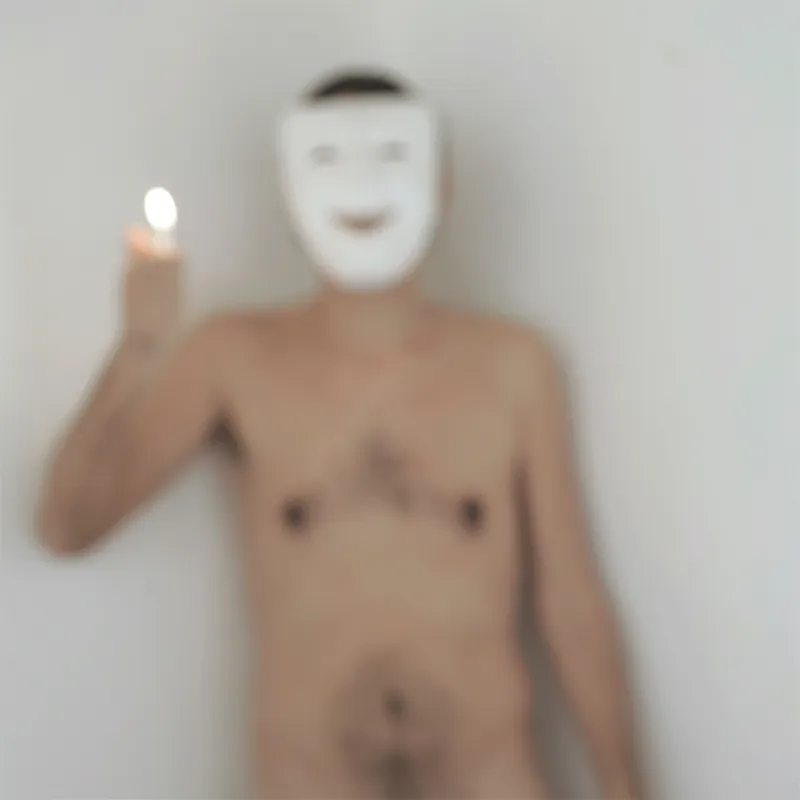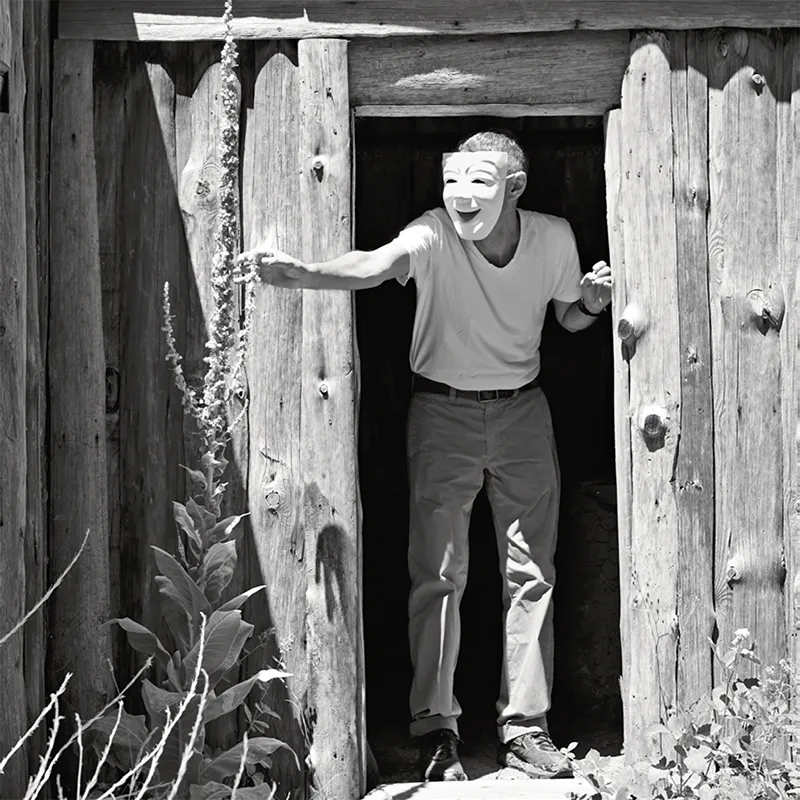Un giovane uomo, in un pomeriggio di marzo, nel 1995, prende un vaporetto e poi un autobus, lascia la laguna veneziana guardando al di là delle torri del petrolchimico di Marghera, dove il cielo si estingue perduto in lontananza e sembra non esistano né cielo né mare. Il giovane uomo, spaventato da quella bellezza sorprendente, va in direzione opposta e gusta ogni metro di terraferma, di asfalto. Scende alla fermata distante un centinaio di metri da un concessionario d’auto; non c’è il marciapiede, ma un palo infilzato nella terra sterile e, attaccato al palo, un foglio con gli orari scoloriti e illeggibili.
Il giovane uomo segue la freccia che indica l’ingresso e gli orari di apertura, fissa il grande cartello LA VETRINA DELL’USATO, ovvero auto esposte in mezzo a erbacce sorte negli interstizi del bitume sbrecciato. Il sole di marzo colpisce le schede tecniche – anno di immatricolazione, cilindrata, alimentazione, chilometri percorsi, optional – adagiate sui cruscotti, i parabrezza rilasciano effetti contraddittori, e avvicinandosi è possibile scorgervi riflessi rami, lampioni, nuvole, e sembra di ascoltare echi, brani intermittenti, dichiarazioni frammentarie di venditori, di ciò che il tempo ha smentito. Poco oltre le frecce ASSISTENZA, OFFICINA, RICAMBI, esistono davvero i saloni delle auto nuove e perfette, nei quali la luce è uniforme e l’artificio domina la natura, e l’artificio è la natura; lí non stazionano esemplari con segni sulle portiere, graffi lungo le fiancate opera di qualche adolescente annoiato, o scalfitture sui paraurti, dettagli che enfatizzano la distrazione dell’automobilista, la volontà distruttiva e autodistruttiva dell’essere umano. Dentro i saloni, il giovane uomo aspira l’aroma dell’invenduto carico di promesse, di nuovi incontri e lunghi viaggi, o di semplici tragitti provinciali e interregionali, trasformati in momenti unici, eccitanti, ai quali è difficile smettere di credere.
L’odore del nuovo, che il giovane uomo sente vicino in quel pomeriggio di marzo – tanto da identificarlo con qualcosa di intimo, con una parte di sé –, è la risultanza di studi in laboratorio. Acquistare un’auto nuova significa comprare anche la fugacità dell’odore che dura poche settimane: quante auto, con l’odore del nuovo, si acquistano in una vita? Ogni componente dell’auto è stata trattata in fabbrica durante la fase di assemblaggio, in modo che il giovane uomo, al momento dell’acquisto, potesse ritrovare qualcosa di incontaminato: l’invenzione di un odore o, addirittura, di un profumo, un profumo creato da uomini chiusi in stabilimenti edificati accanto a svincoli autostradali, uomini in camice bianco con il logo automobilistico impresso sopra il cuore; questi uomini in camice bianco centellinano cinquanta elementi senza che nessun componente prevalga sull’altro, creano ciò che, in modo invisibile, unisce collanti, solventi, vernici, gomme, plastiche, cere, resine sintetiche: un odore che, seppure replicabile, nella realtà diventa un istante preciso, l’istante in cui, nel marzo 1995, il giovane uomo entra nell’auto. Cosí, quasi infastidito dalla parlantina del venditore, si adagia sul sedile avvolgente di una berlina tedesca, e da vinto, come un re deposto che allunga le braccia verso se stesso trasformato in suddito bambino, stringe il volante.
Desidera da anni un’auto tedesca, potente, confortevole, con gli optional del momento, quelli cui un uomo non ha mai pensato, gli optional che pochi anni dopo saranno considerati buffi esperimenti, ma che in quel pomeriggio del marzo 1995 ammalierebbero anche il consumatore piú diffidente, e a maggior ragione il giovane uomo, felice di farsi invadere, di personalizzarsi attraverso la tecnologia. Sceglie una Bmw, e mentre firma i moduli del finanziamento – sotto lo sguardo del venditore che, raggiunto il proprio scopo, tace in modo crudele, assegnando al momento il valore di irreparabilità – fissa, piú che la propria calligrafia o la faccia del misero tiranno di fronte, i volti sorridenti del giovane uomo e della giovane donna nel dépliant appoggiato sulla scrivania, e pensa che il dépliant non menta, e il mondo, per quanto fondato sull’astrazione dei flussi di denaro, si basi ancora, nel sentire comune, su dati quantificabili: un uomo, una donna, lo spazio di un corteggiamento, la durata di un rapporto sessuale, di una relazione sentimentale, la velocità media, i secondi impiegati per arrivare da zero a cento chilometri orari, i consumi di carburante nei tratti urbani, extraurbani e autostradali, lo spazio di arresto in caso di frenata. La Bmw costa trentacinque stipendi di un operaio, ma è semplice possederla, bastano tre mesi di paga per avere subito le doppie chiavi: tutto il resto a rate. Il giovane uomo – lontano dall’impaccio scolastico – sigla i moduli con un andamento disinvolto, consolidato dallo scambio finanziario ormai maturo; la sua identità è la cifra indicata, e quando la scorrevolezza sembra patire un lieve affaticamento, il venditore interviene ripetendo, ancora alcuni autografi. Allora il giovane uomo sorride, è il protagonista, l’euforia, l’imitazione, è la realtà. Il venditore marchia con una crocetta la riga dove apporre l’ultima firma, come se avesse il timore che, nel corso delle tante firme, l’identità dell’acquirente potesse davvero mutare. Bene, e cosí abbiamo finito.
La firma dei moduli negli uffici del concessionario d’auto, piú che una formalità, è la replica di una rappresentazione: la banca ha già concesso il finanziamento, il novanta per cento dell’importo complessivo dell’automobile. Le banche, a metà dell’ultimo decennio del Novecento, prestano soldi quasi a tutti: mutui per acquistare prime e seconde case, finanziamenti per ogni genere di consumo, dal piccolo al grande, dal frullatore francese all’auto tedesca; è una sensazione collettiva che spinge ogni singolo individuo lontano da se stesso, accudendolo in una teca denominata «credito trasparente».
Il Duemila – piú che il miraggio venturo o l’approdo di un percorso evangelico bimillenario – è il fantasma economico che regge l’Occidente, il giovane Est europeo ex comunista, le nazioni sudamericane, il Sudest asiatico, l’Oceania, alcune zone africane: il Duemila è il fantasma economico che sostiene tutto il mondo, perfino l’Italia.
È plausibile concedere un prestito bancario al giovane uomo che desidera una Bmw pur vivendo su un isolotto veneziano, bisogna conferire un valore allo svago automobilistico notturno, in terraferma. Lí la Bmw del giovane uomo raggiungerà la popolazione di auto sportive, station wagon e berline tedesche, che ancora oggi popolano il Veneto come fiere in cattività.
Il giovane uomo esce dalla concessionaria in auto, si sente isolato, protetto dal paesaggio circostante e al tempo stesso proiettato come mai prima nello spazio, distante da sé. Dall’altro lato della strada, una nutria, investita da poco, ha il corpo tozzo, la testa tumefatta, il pelo bruno rossastro macchiato di sangue, cosí come i peli bianchi al di sotto del mento; gli incisivi ricurvi spuntano dalla bocca accompagnati dall’ultimo fiotto di sangue, che bagna il confine tra la linea bianca e il nero dell’asfalto: il sangue è il confine tra due colori.
Attraverso il parabrezza luccicante, il giovane uomo ignora le mosche ronzanti e tantomeno sente la puzza del cadavere. L’abitacolo ha solo l’odore del nuovo, in un’altra epoca il cadavere avrebbe confermato la presenza della morte nella vita, il luogo della nutria sarebbe stato lo spazio da cui proveniamo e quello in cui finiremo; e invece, dal parabrezza, dall’odore del nuovo creato in laboratorio, la nutria morta, per chi ancora la vede, resta un’immagine qualsiasi: un cartellone pubblicitario al di là della banchina, gli occhi di una modella, il volto di Cristo dipinto dal suo stesso sangue.
Il giovane uomo si immette nella prateria di svincoli, rotatorie ricoperte di ciuffetti d’erba bruciata dal gelo dell’inverno appena trascorso, lambisce lunghi steli di acciaio sui quali spiccano le prime antenne di telefonia mobile. Guarda dal suo trapasso automobilistico l’insieme disperso di case singole e a schiera, siepi divisorie ricoperte di smog, giardinetti spogli e cucce vuote dei cani, spazi pubblici microscopici con i giochi arrugginiti per bambini, e il solito rosario di capannoni, parcheggi e spiazzi sterrati adibiti a luoghi espositivi ricavati da ex campi di mais; finisce sotto le torri del petrolchimico di Marghera dove, con un gesto protettivo verso la carrozzeria della Bmw, temendo che le esalazioni e i fumi possano rovinarla, si gratta l’interno del polso, sotto il cinturino dell’orologio, e aspira con maggiore convinzione l’odore del nuovo, la quiete dell’abitacolo, pur sapendo che, in poche settimane, svanirà: la Bmw assorbirà l’odore del proprietario, del giovane uomo. Attraversa un paio di binari dismessi del petrolchimico, gradisce la morbidezza delle sospensioni tedesche e guarda la propria fronte, l’attaccatura dei capelli nello specchietto della Bmw; poi ruota la testa verso la ferrovia costruita dagli austriaci un secolo e mezzo prima, e sopra il Ponte della Libertà vede passare, come comparse già vestite per film in abiti d’epoca, i pendolari che, in direzione contraria, tornano da Venezia alle case nell’entroterra: corpi sfuocati trasportati da treni regionali lenti e sporchi, esseri trasformati in ologrammi.
Il giovane uomo pensa che non vivrà mai in quel modo, ambisce al meglio, ottempererà ai subappalti, dominerà la progressione di finanziamenti, rate, incassi, lavorerà cominciando dall’impianto elettrico della Fenice di Venezia. Guida fino al termine della terraferma pensando al prossimo giro d’affari, laddove la strada finisce e continua la vita del giovane uomo. Posteggia, si volta per guardare la lucentezza della propria carrozzeria che sopraffà tutte le altre macchine parcheggiate, e infine stanco, ma soddisfatto, torna all’isolotto artificiale dove è nato e cresciuto.
Nella seconda metà degli anni Novanta, vivevi a Padova, immaginavi un incipit cosí a proposito di Enrico Carella, il giovane veneziano titolare di una ditta di impiantistica elettrica; Enrico Carella, colui che, tra le 20.40 e le 20.45 del 29 gennaio 1996, con la complicità del cugino, Massimiliano Marchetti, aveva appiccato il fuoco alla Fenice di Venezia.
(Da qui in avanti rinunci al romanzo, ti concentri sui fatti, su ciò che racchiudono. Rifiuti di assegnare profondità a ciò che profondo non è. Niente psicologismi, meglio abbandonare i personaggi alla solitudine dei propri gesti; attenersi ai fatti, questo testo è un insieme frammentato di fatti, nulla esiste al di fuori di essi, sebbene possa capitare che un fatto sia un’immagine, e un’immagine sia un fatto, e un fatto sia una visione, e una visione sia un fatto. A questo fuoco interessa il mito, ma è come se sapesse il rischio di essere narrato all’interno della cornice veneziana: la cornice veneziana fagocita tutto, compreso il fuoco generato all’interno di essa. Questo fuoco è umile, si ciba della cronaca per diventare inclassificabile: né romanzo, né racconto, né saggio, né novella, né poesia. Flashover. I fatti, allora, entrare nei fatti, usare l’archivio per edificare una scrupolosa congettura, una concatenazione di ipotesi, supposizioni basate sempre sui fatti: come ogni buona fotografia insegna, l’unico modo per raccontare questa storia incendiaria, direbbe Lewis Baltz, è usare fatti reali, grazie ai quali è possibile costruire, pezzo dopo pezzo, realtà artificiali, che svelino verità, o meglio ancora, diresti, pezzetti di verità).
Dieci mesi prima dell’incendio, Enrico Carella, per l’acquisto di una Bmw, paga quarantatre milioni e cinquecentomila lire, quasi tutti rateizzati. La banca concede il finanziamento: il giovane imprenditore – traboccante futuro – è una garanzia.
(Essere imprenditore. Le pratiche burocratiche italiane: entrare in una Camera di Commercio, presentare il certificato di buona salute e idoneità fisica al lavoro, battezzarsi con un nome legato al numero della partita Iva).
Il nome è Viet, ditta individuale che opera nell’impiantistica elettrica. Viet è un nome credibile per stare sul mercato? Enrico Carella ha scelto un acronimo, a volte l’acronimo si comprende poco, soprattutto al telefono. Ditta Viet. Biec? No, Viet. Biet? No, Viet! Può ripetere? V di Venezia. I di Italia. E di Empoli. T di Torino. Cosa significa Viet? Un acronimo di Venezia impianti elettrici? E la t finale? Inutile farsi domande sui nomi delle aziende: suonano meglio quando non significano nulla.
(Cosa significa Bmw? Cosa significa Google? Cosa significa essere se stessi?)
Enrico Carella coinvolge il cugino, Massimiliano Marchetti. Il cugino è appena uscito di prigione, una detenzione di quarantacinque giorni, esito di un arresto per spaccio di droga. Marchetti ha bisogno di lavorare, Carella ha bisogno del cugino, entrambi hanno bisogno di droga. Uniti dal lavoro, dalla parentela, dalla droga, in un vincolo che riflette la condizione lavorativa: Marchetti è il cugino dipendente, Carella è il cugino padrone.
Il cugino padrone e il cugino dipendente.
(Il cugino padrone: cugino padrone, in minuscolo, e non Cugino Padrone, in maiuscolo. In maiuscolo sarebbe un personaggio unico, con la pretesa di concentrare su di sé le caratteristiche di tutti gli altri cugini padroni esistenti; Cugino Padrone, in maiuscolo – unità dichiaratamente personaggio, archetipo, modello di imprenditore parente –, attraverserebbe la vita partendo da una condizione privilegiata. Invece qui non serve costruire la gabbia del nome proprio, del soprannome o del nickname, per essere se stesso e annettere la biografia di tutti; lui è il cugino padrone nel suo farsi quasi personaggio, nel suo essere agito in minuscolo; è un elemento intercambiabile, esploso in frammenti, diminuito sotto la soglia di personaggio, e la connotazione familiare sembra sminuire ulteriormente il suo essere padrone; eppure, proprio grazie a questa debolezza congenita, lui è ancora piú forte, disinteressato a diventare personaggio emblematico, a trasferirsi in altri; il cugino padrone da uno non rappresenta i tanti; al contrario, i tanti, i qualsiasi, malgrado il desiderio del cugino padrone di smarcarsi dalla massa, ecco, i tanti si incarnano, diventano lui, e contro la sua volontà, si fanno uno. Le ditte scoppiano di padroni che sono anche cugini di qualcuno, il mondo è pieno di padroni, e di cugini. Prima di essere padrone, era cugino, e quando diventa ditta Viet, si trasforma in potenziale cugino padrone, che non è come essere un semplice padrone: per essere il cugino padrone, deve assumere il cugino, e cosí il cugino diventa il cugino dipendente, e lui, finalmente, il cugino padrone).
Il cugino padrone ottiene il primo subappalto della sua attività imprenditoriale: il rifacimento dell’impianto elettrico alla Fenice di Venezia. L’appalto è conquistato da un’azienda romana, la Elettrotecnica Argenti. Vincere un appalto non significa lavorare nella sede del cantiere; basta scegliere un uomo ben introdotto nella città in cui si è vinto l’appalto, e quest’uomo troverà una ditta locale che svolgerà il lavoro al prezzo piú conveniente per tutti. Il capocantiere dell’azienda vincitrice dell’appalto è Renato Carella, padre del cugino padrone; la ditta cui l’azienda Argenti assegna il subappalto è quella del cugino padrone. Le procedure dovrebbero andare diversamente, ma spesso i legami di sangue e di convenienza sono piú forti di qualsiasi legge, o meglio, sono l’unica legge.
Il 25 settembre 1995 la Viet inizia a lavorare all’interno della Fenice. Non c’è alcuna delibera, alcuna autorizzazione firmata e approvata dalla giunta comunale di Venezia.
(Talvolta l’indolenza grava su un uomo sensibile, incapace di gesti semplici come alzarsi dal letto, aprire la finestra o riempire il serbatoio di carburante; viceversa, per un funzionario del Comune di Venezia, un tipo di uomo definito specialista tecnico, alzarsi dal letto, aprire la finestra, riempire il serbatoio di carburante si rivelano operazioni banali; malgrado questa adattabilità, per il funzionario è impossibile siglare un documento con la propria firma e portarlo all’attenzione della giunta comunale, è come se la penna pesasse tonnellate, cosí il funzionario rimanda il mo...