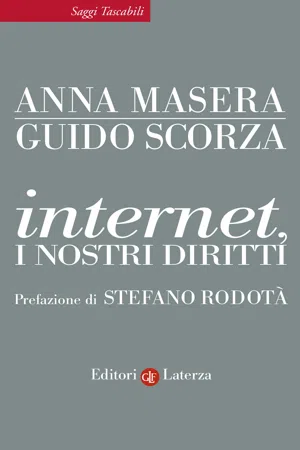1.
Accesso.
Internet come l’acqua, l’elettricità e il gas
I don’t care where I live,
so long as there’s a roof to keep the rain off my books,
and high-speed Internet access.
Eliezer Yudkowsky
Internet per i migranti
«Sei sorpreso che gli immigrati siriani abbiano uno smartphone? Mi dispiace dirtelo, ma sei un idiota».
Il 7 settembre 2015 il quotidiano britannico «The Indipendent» ha risposto con questo titolo ad una polemica sui migranti che, in fuga da guerra e povertà, sbarcano sulle coste europee stringendo tra le mani uno smartphone.
Per un migrante che sbarca in un paese ignoto, del quale non conosce neppure la lingua, lo smartphone è l’unica risorsa trasportabile davvero irrinunciabile, più importante di cibo e vestiti. È l’unico mezzo per accedere a Internet e così ricevere la posta elettronica, spedire soldi a casa o riceverli, rimanere in contatto con la famiglia, accedere ad ogni genere di informazione utile per il viaggio, conoscere la propria posizione attraverso il GPS e le google maps, o per tradurre nella propria lingua ciò che si legge o si sente dire ma non si è in grado di capire.
Ecco perché si sarebbe davvero idioti a confondere uno strumento di sopravvivenza, quale è uno smartphone connesso a Internet per un migrante, con uno status symbol di chissà quale forma di benessere: quello che gli smartphone sono stati in passato – molto più di oggi – a casa nostra.
L’accesso a Internet per gli altri
Ma se per un migrante l’accesso a Internet è una questione di sopravvivenza, che cosa significa per i cittadini del mondo benestante in cui viviamo?
Internet serve a guardare film – soprattutto pornografici – senza pagare il biglietto, come ha detto una volta Franco Bernabè, ex presidente di Telecom Italia, oppure, come dice papa Francesco, è il più grande strumento di incontro e solidarietà della storia dell’uomo e, in questo senso, un dono di Dio? Internet è, in realtà, l’uno e l’altro.
E i suoi tre miliardi di utenti, come e perché usano Internet? Qualche numero aiuterà ad avere le idee più chiare al riguardo.
In un secondo – uno qualsiasi – nel mondo vengono inviati oltre 10.000 tweet. Nello stesso secondo, vengono caricate oltre 2500 fotografie su Instagram, uno dei social network di maggior successo tra quelli dedicati alla condivisione di immagini (di recente, peraltro, acquistato da Facebook). E ancora in un secondo – sempre lo stesso – si fanno quasi 2000 chiamate e videochiamate su Skype e oltre 50.000 ricerche su Google, e vengono guardati più di 107.000 video su YouTube. Per esempio, il 14 settembre 2015, alle 19.32, in tutto il mondo sono state effettuate oltre tre miliardi e mezzo di ricerche su Google, sono stati scritti quasi tre milioni e mezzo di post e guardati su YouTube più di sette miliardi e mezzo di video.
E a proposito dello smartphone dei migranti che sbarcano in Europa, in una sola giornata come questa, quando la mezzanotte di domani è ancora lontana, il numero di smartphone venduti in tutto il mondo supera i 4,5 milioni, mentre quello dei tablet sfiora il milione di pezzi.
Si tratta, naturalmente, di numeri che fotografano l’utilizzo solo di una parte dei servizi accessibili attraverso Internet e che, tuttavia, offrono almeno un’idea di quanti sono e cosa fanno i cittadini del mondo che accedono a Internet.
Comunicazione, informazione, condivisione di idee, opinioni e immagini, fruizione di contenuti audiovisivi e ricerca, sono, probabilmente, le principali espressioni per riassumere le motivazioni statisticamente più ricorrenti per le quali le persone accedono a Internet.
Educazione, economia, partecipazione democratica, ma anche salute e cittadinanza digitale, sono, invece, le aree nelle quali la rapida diffusione dell’accesso a Internet nel mondo ha fatto registrare l’impatto maggiore.
Da Tank Man alla primavera araba
Tank Man, uomo del carro armato, è il soprannome dato dai media di tutto il mondo al ragazzo che il 5 giugno 1989 si parò davanti ai carri armati del governo cinese per fermarli, divenendo il simbolo della manifestazione degli studenti di piazza Tienanmen a Pechino. Tank Man deve la sua fama a una foto scattata dal fotografo professionista Jeff Widener, della Associated Press.
Nel 1989, però, Google, YouTube, Facebook e Twitter non esistevano. Per cui si sa tutto del fotografo, pluripremiato, che scattò la foto, ma non si sa nulla di Tank Man, del quale non si conosce neppure l’identità.
Mohamed Bouazizi, invece, è un giovane ambulante tunisino che il 17 dicembre 2010 si è dato fuoco a Sidi Bouzid, una delle aree più povere della Tunisia, in un estremo gesto di protesta contro le condizioni economiche e politiche del suo paese.
Bouazizi è passato alla storia perché le immagini del suo gesto disperato – catturate, questa volta, non da un fotografo professionista con una macchina da migliaia di dollari, ma dai passanti con i loro smartphone da poche decine di dollari – sono state pubblicate, in tempo reale, su Facebook, Twitter e YouTube e sono rimbalzate in tutto il mondo nello spazio di pochi minuti, divenendo, di fatto, il detonatore della cosiddetta «primavera araba».
Secondo uno studio della Boston Consulting del gennaio 2012, intitolato The Connected World, la popolazione mondiale di utenti Internet avrebbe dovuto superare i 3 miliardi nel 2016. È accaduto, invece, che già alla fine del 2014, in tutto il mondo, gli utenti Internet fossero più di 3 miliardi e oggi, all’inizio del 2016, a usare Internet siamo in 3,5 miliardi.
E la diffusione di Internet rivoluziona anche l’economia del pianeta. La cosiddetta economia digitale, infatti, raggiungerà i 4200 miliardi di dollari nei soli paesi del G20: se fosse un’economia nazionale sarebbe classificata al quinto posto nel mondo, dietro Stati Uniti, Cina, Giappone e India e davanti alla Germania.
«Il progresso tecnologico espande l’economia e crea ricchezza, ma nessuna legge economica dice che i benefici saranno di tutti», profetizzava già nel 1995 Jeremy Rifkin, che aggiungeva: «Internet rischia persino di bruciare i pochi posti di lavoro rimasti sulla terra».
L’accesso a Internet sarà anche l’alleato più fidato dei migranti che sbarcano sulle coste europee, uno strumento di rivoluzioni democratiche senza precedenti nella storia dell’uomo, o il volano dell’economia globale di questo secolo, ma di controindicazioni ne ha parecchie, per essere candidato ad accedere all’olimpo dei diritti fondamentali degli uomini e dei cittadini.
Il web ci rende davvero liberi?
«Non possiamo dare per scontata la capacità del web di ridurre le disuguaglianze», esordisce il Web Index Report 2014-2015 della WWW Foundation di Tim Berners Lee, l’uomo che ha dato i natali al web e lo ha poi «regalato» all’umanità. «Siamo al bivio tra un web ‘per tutti’, che rafforza la democrazia e crea uguali opportunità per tutti, e un web ‘winner takes all’ (chi vince piglia tutto), che concentra ulteriormente il potere economico e politico nelle mani di pochi», si chiosa nello studio.
E, in effetti, i dati esaminati nel rapporto raccontano di un mondo spaccato in due: da un lato i paesi più ricchi, che beneficiano appieno delle potenzialità della rete; dall’altro lato quelli meno abbienti, che restano sempre più indietro. Nei primi è più facile accedere a Internet, anche perché il costo per la connessione è 80 volte inferiore e la qualità dell’accesso enormemente migliore.
Per 4,4 miliardi di persone, d’altra parte, Internet è ancora solo un’aspirazione, qualcosa di cui magari hanno sentito parlare ma che non conoscono davvero. E in nove casi su dieci i disconnessi sono proprio i più poveri, il cui tasso di penetrazione nella rete è aumentato tra il 2011 e il 2013 di un solo punto percentuale.
Ecco perché il diritto di accesso a Internet dovrebbe essere considerato un diritto fondamentale di ogni persona e al secondo comma dell’articolo 2 della Dichiarazione dei diritti in Internet si è avvertita la necessità di prevedere che «Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale».
Lo stesso articolo così prosegue: «3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla rete. 4. L’accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite. 5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità».
È il primo passo per garantire l’accesso effettivo alla rete a quegli oltre quattro miliardi di cittadini del mondo che oggi – per ragioni sociali, culturali, politiche ed economiche – ancora non possono farlo e che non accedendovi sarebbero condannati a restare indietro nel cammino verso il futuro, l’educazione, la salute, la libertà, la democrazia, la prosperità.
Ma guai a confondere questo primo passo – per quanto importante – con l’effettivo riconoscimento del diritto.
Al riguardo, appare straordinariamente istruttiva una bella lezione tenuta da Piero Calamandrei, ineguagliabile avvocato e politico del nostro dopoguerra, ai suoi studenti a proposito dell’articolo 34 della nostra Costituzione, che stabilisce: «I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi...