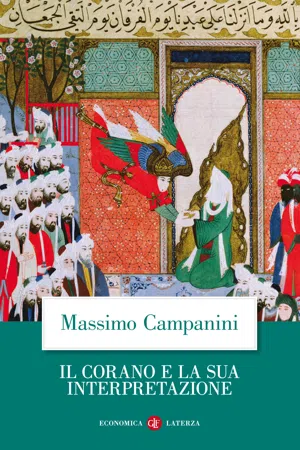V.
Letture contemporanee del Corano
Già parecchie volte nei primi capitoli di questo libro abbiamo discusso dell’interpretazione del Corano, soprattutto in riferimento alle soluzioni avanzate in quello che noi chiamiamo Medio Evo (che corrisponde invece all’apice e all’acme della civiltà islamica). Qui si tratterà di affrontare il problema dell’interpretazione nella prospettiva contemporanea. L’età contemporanea (intendiamo in particolare il Novecento, anche se la rinascita del mondo islamico va retrodatata alla fine del Settecento) ha conosciuto un’intensa attività interpretativa sul Corano, non inferiore a quella «medievale». E ciò per la buona ragione che, nell’età contemporanea, i musulmani si sono dovuti scontrare e confrontare con la civiltà e la cultura europee, apportatrici della modernità. Questa modernità può essere individuata in alcune parole e in concetti chiave caratteristici della civiltà europea e, da molti punti di vista, contrari alla tradizionale mentalità e cultura islamica. In primo luogo, il laicismo, ovvero la separazione tra foro interiore e foro esteriore, tra religione e società (e soprattutto tra religione e politica): l’Islam, abbiamo già detto più volte, integra almeno religione e mondo ed è una concezione onnicomprensiva della realtà, per cui il laicismo sembra esserle, in tutta apparenza, alieno. In secondo luogo, la tecnologia, che ha piegato la natura al dominio umano invece di ricercare l’armonia tra essa e l’uomo: per l’Islam il sapere è vita, non potenza; la natura deve essere coadiuvata (anche se sfruttata a beneficio dell’uomo), non forzata a fini che le sono estranei1. In terzo luogo, la nazione, la democrazia e il diritto naturale: queste categorie politiche collidono coi concetti classici della filosofia politica e della giurisprudenza islamica come umma/ Comunità, califfato e origine del diritto nella volontà di Dio e nella rivelazione. Infine, l’individualismo, che appare in netta opposizione al predominante carattere collettivistico e olistico dell’Islam2. La dialettica con la modernità ha dunque significato, da un certo punto di vista, alienazione, visto che la modernità ha imposto ai musulmani di rileggere, di rivedere, di giudicare, talora di correggere, comunque di comprendere meglio i fondamenti della propria cultura onde rapportarli a una realtà che sembra dominare e schiacciare il mondo islamico. Ricordiamo che il trionfo della modernità europea ha significato, per molti decenni, la subordinazione coloniale del mondo islamico all’imperialismo occidentale. È attraverso l’occupazione coloniale e la guerra di conquista che i popoli musulmani hanno conosciuto la modernità: e questo non poteva che essere traumatico, anche se è forse possibile ritenere che, senza quello scontro con la modernità, i musulmani sarebbero rimasti chiusi in se stessi, preda del loro sentimento di superiorità e di autosufficienza. Naturalmente, non vi era – e non vi è – mezzo migliore per capire quali sono le chances dell’Islam di fronte alla modernità che rivolgersi all’analisi e allo studio del documento basilare su cui esso si sorregge totalmente: il Corano.
1. I commentari coranici della «salafiyya»
La salafiyya è stato un movimento riformista di grande respiro che, nato nella seconda metà dell’Ottocento, ha stimolato una rinascita dell’Islam soprattutto nel mondo arabo per almeno tutta la prima metà del secolo scorso. L’iniziatore del salafismo può essere considerato il persiano Jamâl al-Dîn al-Afghânî (1839-1897), che operò a lungo in Egitto e a Istanbul. Il principale discepolo di al-Afghânî è stato il già citato Mu-
hammad ‘Abduh, muftî (giurisperito che pronuncia opinioni giuridiche) d’Egitto e insegnante di grande prestigio, uno degli intellettuali di punta del mondo arabo a quell’epoca. Ad ‘Abduh hanno fatto riferimento, più o meno direttamente, il siriano Rashîd Ridà (1865-1935) e l’algerino ‘Abd al-Hamîd Ibn Bâdîs, oltre a numerosi altri pensatori di cui non è possibile ricordare qui il nome. Da molti punti di vista, il progetto riformista dei salafiti ha rappresentato il punto di partenza dell’organizzazione dei Fratelli Musulmani, fondata in Egitto nel 1928 da un insegnante, Hasan al-Bannâ3, e poi ramificatasi in tutti i paesi del Vicino Oriente e del Nord Africa.
I princìpi fondamentali della salafiyya possono essere riassunti in pochi punti: ritorno alle fonti originali dell’Islam, il Corano e la sunna del Profeta; rinnovamento dei costumi nell’ottica di un sempre più costante impegno civile e sociale; assimilazione della scienza e del sapere moderno; recupero per l’Islam e per i popoli arabi di un ruolo nella storia, all’epoca conculcato dal colonialismo europeo. Il salafismo si è notevolmente impegnato nel commentario coranico proprio nell’ottica di implementare questi princìpi di base. Tuttavia, secondo H’mîda Ennaifer, il commentario tradizionale salafita – tra i cui studiosi possiamo citare il tunisino sunnita Muhammad al-Tâhir Ibn ‘Âshûr (1879-1973) e l’iraniano sciita Muhammad Husayn Tabâtabâ’î (1903-1983) – presenta alcuni difetti che ne hanno compromesso l’utilità e l’adeguatezza nel mondo contemporaneo4. In sintesi essi sono: a) il mantenersi all’interno dell’eredità concettuale antica, stabilita dai tradizionalisti, al fine di salvaguardare, con l’unità del testo, l’unità della Comunità; b) privilegiare il commento del Corano attraverso la sunna (secondo la terminologia chiarita più sopra, ciò vuol dire privilegiare il commentario secondo l’autorità e la tradizione rispetto al commentario razionale); c) legare l’interpretazione del testo al modo con cui esso veniva compreso al momento della rivelazione: il che vuol dire, ancora una volta, eccedere nella sacralità del testo e minimizzarne la flessibilità storica; d) considerare i commentari tradizionali dotati di un’autorità tale da farne dei «secondi testi» che quasi affiancano e sostituiscono il «primo testo», cioè il Corano in quanto tale. Questi «difetti», se sono effettivamente riscontrabili nelle opere dei commentatori salafiti più legati alla tradizione, non sono comunque immediatamente identificabili presso i principali esponenti del salafismo.
Nel loro disegno riformista, infatti, ‘Abduh e Rashîd Ridà insieme iniziarono (ma non completarono) un monumentale commentario coranico, noto come il commentario del Manâr (Il faro), nome della rivista, diretta da Ridà, su cui il lavoro venne pubblicato prima di essere raccolto in volume. Ibn Bâdîs fu essenzialmente un predicatore e un pubblicista; e le sue riflessioni sul Corano, sistematiche e profonde ma che non costituiscono un commentario vero e proprio, videro la luce su un’altra rivista, Al-Shihâb (La meteora). L’atteggiamento dei salafiti fu quello di costruire il Corano, cioè di farlo valere come una struttura di pensiero, come una fonte di insegnamenti teologici e morali che possa servire affinché i popoli islamici affrontino la modernità. In tal senso, il ruolo del commentatore (e del commentario) non è avulso dal contesto sociale e politico. La «costruzione» del Corano passa attraverso il concetto ambiguo e scivoloso di razionalità. È difficile dire che cosa sia la razionalità, darne, cioè, una definizione filosofica assolutamente univoca e precisa. Ma i salafiti, ‘Abduh soprattutto, sostennero che l’Islam e il Corano sono razionali. ‘Abduh riteneva che il Corano è l’unico testo sacro che argomenta in maniera rigorosamente deduttiva e dimostrativa, oltre a considerare come compito fondamentale dell’uomo la riflessione scientifica e sistematica; e che l’Islam è l’unica religione che si appoggia su prove e incita alla scienza. Questo presupposto ispira tutto il commentario del Manâr. In moltissimi luoghi si legge che la fede, nell’Islam, è fondata sulla ragione: dopo essersi impadronita della ragione attraverso le prove dimostrative, la fede costituirà per il credente uno strumento di mobilitazione e lo condurrà a impegnarsi per Dio e per la sua religione.
Questo fondamentale atteggiamento razionalistico si esprime a molteplici livelli. Vi è innanzitutto una ferma critica al principio di autorità e alla imitazione servile e cieca (taqlîd). Si tratta, peraltro, di una rivendicazione comune ai riformisti musulmani, fin dal tempo di Ibn Taymiyya, che spronava a riaprire la porta all’indagine autonoma e razionale sui princìpi della dogmatica e della giurisprudenza. Vi è, in secondo luogo, la rivendicazione – anch’essa abbastanza frequente nella tradizione islamica, per lo meno sunnita – del fatto che l’Islam è una religione priva di mistero, soprattutto per quanto riguarda Dio. Non vi è nulla da rivelare di segreto su Dio: né incarnazione, né Trinità, né sacramento. L’ovvietà di Dio è garanzia del fatto che la mente umana si può piuttosto rivolgere alla scienza e alla natura. Hasan Hanafî dirà che è inutile elucubrare sull’essenza di Dio: l’importante è lottare per il progresso e la liberazione dell’uomo. Così, non vi è spazio per il miracolo che sorprende e stupisce l’ingenuo e ne condiziona e distorce la fede:
nel commentario del Manâr, lo sceicco ‘Abduh insiste sul fatto che il miracolo (mu‘jiza) ha un carattere apologetico ed è servito a supportare la credibilità della rivelazione. Egli sostiene l’idea, cara ai musulmani, che il tempo del miracolo mu‘jiza è finito. Muhammad ha inaugurato l’epoca della ragione. I miracoli erano necessari ai tempi dell’infanzia dell’umanità. La fede musulmana, sostiene ‘Abduh, si regge sulla ragione5.
Ciò significa che i salafiti condannavano tu...