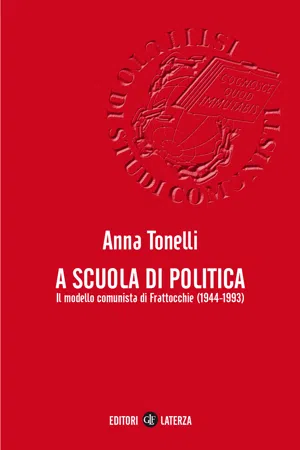1.
Educare alla politica
(1944-1954)
1. A partire da Gramsci: per una preparazione ideologica di massa
«La preparazione ideologica di massa è una necessità della lotta rivoluzionaria, è una delle condizioni indispensabili della vittoria». Antonio Gramsci è il primo e più convinto teorizzatore dell’utilità delle scuole politiche per formare la coscienza e il profilo dei militanti.
Già nella definizione dell’etica socialista, Gramsci fornisce un contributo fondamentale attraverso le riflessioni sui temi dell’educazione, della cultura e della formazione. Per sua volontà, insieme al gruppo di «Ordine Nuovo», nascono nel 1919 a Torino i corsi della «scuola di cultura e propaganda socialista», rivolti soprattutto agli operai, sollecitati a diventare «padroni del vostro pensiero e dell’azione vostra, artefici diretti della storia della vostra classe». Le lezioni e i corsi rientrano nella prospettiva teorica più ampia che considera la centralità della classe operaia come termine da cui partire per il sovvertimento dell’ordine sociale e politico. Un obiettivo che, secondo Gramsci, deriva dalla necessità di contrapporsi alla mancanza di un progetto educativo da parte della famiglia borghese, da colmare attraverso un’ampia opera di alfabetizzazione che attribuisca ai nuovi educatori politici il compito di trasmettere «la fiaccola della civiltà da una generazione all’altra, dal passato all’avvenire».
Seguendo una propensione che porterà all’approfondimento dei vari aspetti della pedagogia e della cultura nei rapporti con la società civile, Gramsci si sofferma sulla necessità di approntare tutti gli strumenti atti a definire la preparazione di massa e il lavoro culturale organizzato, con le scuole di partito a funzionare da perno centrale. In questo, diventa calzante e condivisibile la definizione di Fiamma Lussana che considera Gramsci come «mandante delle scuole ideologiche».
Agendo sulla formazione della coscienza delle masse, si avranno inevitabili ripercussioni sul piano politico con il raggiungimento di due obiettivi: combattere l’arretratezza culturale e prefigurare la lotta rivoluzionaria. Il lavoro culturale e teorico va dunque condotto e articolato in tutte le sedi e in tutte le forme per promuovere l’emancipazione della classe operaia che passa attraverso la militanza nel partito. E sarà proprio il Partito comunista d’Italia a rappresentare il punto di riferimento per cementare l’appartenenza e fornire il bagaglio teorico e politico indispensabile a tutti gli aderenti. Di qui l’insistenza sulla scuola interna di partito, anche per corrispondenza, come prima fase di attività per migliorare i quadri e costruire le figure «degli organizzatori e dei propagandisti».
Quando spiega le linee teoriche e pratiche dei corsi della scuola interna del partito, Gramsci guida la più solida forza organizzata antifascista che si erge come baluardo a Mussolini e, contemporaneamente, come alternativa politica rivoluzionaria. Compito della scuola è quello di unire l’impostazione ideologica con la prospettiva rivoluzionaria, trasformando la «coscienza teorica e la dottrina rivoluzionaria» in «un’arma» indispensabile «all’avanguardia del proletariato la quale forma e istruisce i suoi quadri», al fine di una battaglia per la trasformazione della società.
Nell’introduzione al primo corso della scuola interna di partito, nell’aprile-maggio 1925, firmato «La Sezione agitazione e propaganda del Pc», Gramsci fornisce i dettagli sul tipo di lezioni da tenere, suddivise in tre parti: la prima sulla «teoria del materialismo storico»; la seconda sugli «elementi fondamentali di politica generale»; la terza sul «Partito comunista e i principi di organizzazione che gli sono propri». Mentre le nozioni di base teoriche del materialismo storico sono desunte dalla «traduzione del libro del compagno Bukharin», più particolareggiate sono quelle che riguardano la politica, ripartite in più voci:
l’economia politica; lo sviluppo del capitalismo fino all’epoca del capitale finanziario; la guerra e la crisi del capitalismo; lo sviluppo delle forze economiche; la società comunista e il regime di transizione; la dottrina comunista sullo Stato; la I e la II Internazionale; la III Internazionale; la storia del Partito bolscevico russo; la storia del Partito comunista italiano; il potere sovietico e la struttura della Repubblica dei Soviet; la politica economica del potere dei Soviet nell’epoca del comunismo di guerra; origine e base della nuova politica economica; l’industria; la politica agraria e la politica contadina; commercio e cooperazione; politica finanziaria; i sindacati, loro funzioni e loro compiti; la quistione nazionale.
Dopo una sezione così corposa, l’ultima si sofferma sui principi di organizzazione rivoluzionaria del partito «quali vennero sviluppandosi nell’attività direttiva della Internazionale comunista e quali furono fissati in maniera più completa nella Conferenza di organizzazione tenuta a Mosca nel marzo di quest’anno».
Il corso, rivolto genericamente ai membri del partito, si avvale di dispense e fascicoli indipendenti su temi specifici (la questione sindacale, politica, operaia o contadina, ecc.) con note informative, schemi di conversazione e consigli didattici per lo studio «fatto senza l’aiuto e la guida immediata dell’insegnante».
Gramsci suggerisce il metodo di studio, con l’invito ad affrontare i testi non come una semplice lettura, ma come materiale da studiare, sforzandosi «di ricordare, di assimilare gli argomenti trattati in modo da essere in grado di fare delle relazioni e delle piccole conferenze»: da qui il partito si muove per selezionare dalla scuola gli elementi migliori «e per ogni suo bisogno si rivolgerà ad essi prima che a chiunque altro». A tal proposito, avverte Gramsci, non bisogna temere difficoltà e ostacoli nell’apprendimento, per l’aiuto reciproco derivante dai membri della scuola:
Gli allievi devono aiutarsi in tal caso come possono: la costituzione dei gruppi e la ripetizione in comune delle lezioni ricevute può talvolta eliminare questo ostacolo. In ogni caso tutti gli allievi sono pregati di scrivere alla direzione della scuola, esponendo la loro situazione, domandando maggiori delucidazioni, consigliando altri metodi e altre forme di esposizione.
Già in questi scritti gramsciani in cui si fa riferimento alla partecipazione delle classi lavoratrici alla vita politica con il conseguente ripensamento ...