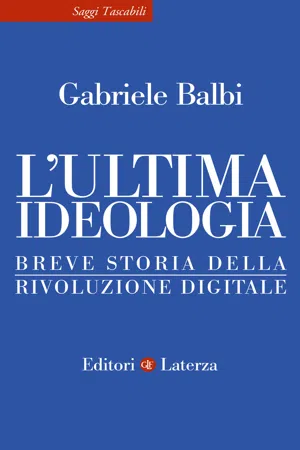
- 168 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La rivoluzione digitale ci ha reso sempre connessi e in grado di comunicare istantaneamente con persone di tutto il mondo, ci ha regalato una quantità apparentemente infinita di informazioni e opportunità, ci ha dato l'illusione che vecchie barriere e gerarchie crollassero e che 'magnifiche sorti e progressive' fossero davanti a noi. Ma è proprio così? O si tratta di una vera e propria ideologia, con i suoi miti, i suoi profeti, le sue menzogne? Un libro attualissimo e straordinariamente utile per capire meglio una delle narrazioni più significative del nostro tempo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'ultima ideologia di Gabriele Balbi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Studi sulla comunicazione. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1.
Definire la rivoluzione:
benedetta incertezza
Per capire la rivoluzione digitale occorre anzitutto definirla. Quali definizioni si sono imposte nel corso dei decenni e quali invece sono state scartate? In quale periodo storico è nata ed ha prosperato? E come è stata chiamata nel corso del tempo? Queste tre domande guideranno un capitolo che mira a ricostruire le principali modalità con cui la rivoluzione digitale è stata caratterizzata, periodizzata e ribattezzata, segnalando ambiguità e incertezze che, contrariamente a quanto si può pensare, costituiscono un punto di forza e di vitalità della rivoluzione stessa.
1.1. Trasformare e ritrasformare: da atomi a bit
Ci sono due strumenti straordinari per capire l’evoluzione dei concetti, ovviamente non solo quello di rivoluzione digitale: Factiva e Google Ngram Viewer. Factiva è un database di proprietà di Dow Jones che raccoglie circa 32.000 fonti digitalizzate in 28 lingue tra giornali, riviste, documenti aziendali, trascrizioni di trasmissioni televisive e radiofoniche, immagini e molto altro. Google Ngram è un motore di ricerca liberamente accessibile online che permette di rintracciare la frequenza di alcune parole nei milioni di libri che Google ha digitalizzato nel corso del tempo.
Inserendo in entrambe le basi di dati la stringa digital revolution dal 1960 a oggi otteniamo due grafici e varie informazioni utili per cominciare a capire l’evoluzione del termine. Nello specifico, l’espressione «rivoluzione digitale» è stata usata specialmente a partire dagli anni Novanta del Novecento, ha vissuto un primo picco di popolarità tra la fine degli anni Novanta e i primissimi anni del Duemila e un secondo intorno al 2017-2018. Factiva permette anche di associare al termine cercato le aziende, le istituzioni e i personaggi più frequentemente citati. Tra le prime ci sono Alphabet (e quindi la galassia Google), Microsoft, Apple, l’Unione Europea e la BBC, queste ultime evidentemente impegnate in politiche e strategie di digitalizzazione. Tra i personaggi, ai primissimi posti figurano Donald Trump, Steve Jobs, Rupert Murdoch, Bill Gates, il primo ministro indiano Narendra Modi e uno degli imprenditori più noti del paese come Mukesh Dhirubhai Ambani.
Questi dati forniscono una visione generale e quantitativa della frequenza d’uso dell’espressione digital revolution e di termini ad essa correlati; non dicono, ad esempio, se ci sia una visione positiva o negativa della rivoluzione digitale, in quali contesti venga nominata (ironici o seri, per esempio), o ancora se compaia su riviste più o meno prestigiose. Ma possono ugualmente essere utili per inquadrare la rivoluzione digitale, la sua popolarità nel corso del tempo, l’associazione con potenti aziende digitali o imprenditori «mitici», così come con politici o specifici luoghi geografici (evidentemente, tre aree del mondo come Stati Uniti, il vero paese trainante della rivoluzione digitale almeno agli inizi, India ed Europa spiccano in queste osservazioni iniziali).
Ma cosa intendiamo quando parliamo di rivoluzione digitale? Siamo sicuri di poter convergere su una definizione univoca, che ne colga gli aspetti principali e che sia facilmente comprensibile? Come molto spesso capita per concetti e idee popolari, anche le caratteristiche della rivoluzione digitale non sono ben definite, sono date per scontate o sottointese o, ancora, si sono ripetute ossessivamente alcune formule stereotipate. Un luogo simbolico da cui partire è allora Wikipedia: le voci della più famosa enciclopedia online, infatti, sono fonti storiche di grande valore per comprendere come discorsi e pensieri comuni si sedimentino nel corso del tempo. Nella versione italiana che si trova attualmente online, la rivoluzione digitale è definita come
il passaggio dalla tecnologia meccanica ed elettronica analogica a quella elettronica digitale che, iniziato nei paesi industrializzati del mondo durante i tardi anni Cinquanta con l’adozione e la proliferazione di computer e memorie digitali, è proseguito fino ai giorni nostri in varie fasi storiche, all’interno della cosiddetta terza e quarta rivoluzione industriale. Si fa riferimento a questo periodo di cambiamento e di sviluppo tecnologico anche con l’espressione rivoluzione informatica, per indicare gli ampi cambiamenti socio-economici apportati dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC, o in inglese ICT). Grazie allo sviluppo di dispositivi interattivi, World Wide Web, digitale terrestre e smartphone, si è assistito alla proliferazione e alla moltiplicazione dei canali d’accesso all’informazione, che hanno cambiato le modalità in cui avviene l’atto comunicativo.
Questa definizione è molto ricca e contiene vari elementi che saranno discussi nel libro. Anzitutto, la rivoluzione digitale viene qui identificata come un passaggio tecnologico da un paradigma analogico a uno, appunto, digitale, due universi considerati incompatibili ma che di fatto non lo sono. La fortuna di questa definizione è di lungo corso, ma sicuramente fu Nicholas Negroponte a popolarizzarla nel suo best seller Essere digitali, del 1995. Sebbene la locuzione «rivoluzione digitale» appaia nel libro solo quattro volte, Negroponte teorizzò infatti il passaggio da un mondo fisico fatto di atomi a uno immateriale costituito da bit, a suo avviso un passaggio radicale e paradigmatico che avrebbe condotto verso un mondo nuovo, irriconoscibile rispetto al passato. C’è un’immagine plastica di questa idea. In un lungo articolo del «National Geographic» dedicato alla rivoluzione dell’informazione, sempre del 1995, c’è una foto di Bill Gates con in mano un CD-Rom, imbragato e issato su una torre di 330.000 fogli di carta. Tutto ciò per dichiarare: «Questo CD-Rom può contenere più informazione di tutta la carta che è sotto di me». È la rappresentazione simbolica della transizione tra atomi e bit teorizzata da Negroponte, oltretutto promossa da uno dei guru della rivoluzione digitale.
Una seconda caratteristica della rivoluzione digitale che emerge dalla voce Wikipedia citata è il fatto che essa sia una rivoluzione trasformativa per le società umane, in grado di scatenare cambiamenti sociali, economici e politici che hanno condotto (o condurranno) verso una nuova società che avrà al centro l’informazione. In altri termini, i cambiamenti sociali degli ultimi decenni sono spesso raccontati come una mera conseguenza della rivoluzione digitale. Questa convinzione va oltre il determinismo tecnologico classico, secondo cui le tecnologie causano linearmente i cambiamenti sociali; è infatti un’entità astratta come la rivoluzione digitale che, complici anche le nuove tecnologie che sforna incessantemente, diventa motore della trasformazione e quindi causa o agente primario del cambiamento.
Il passaggio da un paradigma analogico, fatto di atomi e materialità, a uno digitale immateriale e i cambiamenti radicali che hanno investito le società contemporanee (la versione cinese di Wikipedia sostiene come sia «la più grande e profonda rivoluzione tecnologica della storia umana [...] e non è ancora finita») sono i due denominatori comuni della definizione di rivoluzione digitale più noti e accettati. Entrambi criticabili, ma si tratta pur sempre di due racconti verso cui si è andati a convergere, due dei pilastri ideologici più rilevanti su cui poggia l’immagine mentale che abbiamo della rivoluzione digitale. Ma queste due caratteristiche sono sufficienti per definirla? Su due soli pilastri non si regge una costruzione solida.
La definizione di Wikipedia propone infatti altre questioni aperte che troveranno spazio nel libro. La temporalità della rivoluzione digitale è, per esempio, tema assai controverso: secondo la versione italiana, si avvia «durante i tardi anni Cinquanta del Novecento», in quella inglese e spagnola «dalla fine degli anni Cinquanta ai tardi anni Settanta», nella sofisticata voce francese, che mette in luce l’ambiguità e l’ideologia del concetto, se ne fa risalire la genesi al Settecento e Ottocento con le prime macchine da calcolo, in quella tedesca alla «fine del 20° secolo». Quali siano le periodizzazioni della rivoluzione digitale e, soprattutto, perché siano così varie sarà oggetto del prossimo paragrafo.
Un’altra questione, toccata non solo nella versione italiana della definizione, concerne il nome: la rivoluzione digitale è stata chiamata in molti modi, utilizzando termini che possono all’apparenza sembrare sinonimi ma che in realtà nascondono diversi modi di interpretare il suo potere trasformativo e che, naturalmente, sono figli dei tempi storici in cui sono stati coniati. Il terzo paragrafo di questo capitolo è dedicato a questo tema.
Un’ultima dimensione accennata nella definizione di Wikipedia in italiano è il legame tra rivoluzione digitale e nuove tecnologie della comunicazione: vengono in particolare nominati le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), i dispositivi interattivi, il World Wide Web, il digitale terrestre e lo smartphone. A questo elenco si possono aggiungere molte altre tecnologie che, nel corso degli anni, sono state viste come dirompenti e rivoluzionarie; alcune di queste verranno definite come reliquie nel capitolo 4.
1.2. Datare e ridatare: le periodizzazioni variabili
Si può datare la rivoluzione digitale? C’è consenso sulla sua origine e sulla eventuale fine? Non è semplice rispondere a queste domande.
I racconti «ufficiali» vedono spesso nella cibernetica non tanto l’inizio della rivoluzione digitale quanto la sua principale fonte d’ispirazione, un preludio e un innesco alle trasformazioni successive. L’espressione «cibernetica» venne introdotta nel 1947 – lo stesso anno in cui fu inventato il transistor, spesso considerato un oggetto chiave della rivoluzione – per designare una nuova scienza interessata all’interazione tra il computer (e più in generale le macchine) e gli esseri umani e ai fenomeni di autoregolazione dei sistemi di comunicazione. Due nuovi aspetti che secondo il matematico statunitense Norbert Wiener – uno dei patriarchi della rivoluzione, come si dirà nel capitolo 4 – sarebbero stati in grado di generare le trasformazioni sociali più rilevanti in futuro.
Al di là della disciplina-faro, che oltretutto potrebbe non rappresentare la causa scatenante ma uno dei sintomi del fenomeno rivoluzionario, le periodizzazioni della rivoluzione digitale sono estremamente variabili. Come detto, alcuni ritengono che abbia radici nell’Ottocento, ma la maggior parte dei racconti si focalizza sul Novecento. Gli anni Quaranta e Cinquanta sono talvolta indicati come l’inizio della rivoluzione digitale perché in quel periodo i primi grandi computer, definiti mainframes, avviarono una rivoluzione del calcolo. Altri ritengono che gli anni Sessanta siano un momento spartiacque perché in quel decennio venne installata la rete Arpanet, oggi riconosciuta come la principale antenata di internet. Gli anni Settanta vengono definiti da alcuni studiosi come davvero cruciali perché furono lanciati sul mercato nuovi prodotti, come i microprocessori e i personal computer, e la cosiddetta rivoluzione dell’informazione cominciò a diventare una delle metafore più rappresentative della società dell’epoca. La società dell’informazione e quella post-industriale avevano al centro l’idea che il computer e le nuove reti di telecomunicazione (non si parlava ancora di internet) fossero gli strumenti fondamentali per passare da un’economia basata su agricoltura e industria a una basata sui servizi e l’informazione. Anche Jean-François Lyotard, teorico della post-modernità, identificò nella rivoluzione dell’informazione che stava avvenendo a fine anni Settanta una delle chiavi per comprendere il passaggio da una società moderna ad una post-moderna. Negli anni Ottanta, specie nei paesi occidentali, si assistette all’ingresso del computer in molte case anche e soprattutto come strumento di gioco: per questo alcuni studiosi individuano in questo decennio la vera esplosione della rivoluzione digitale.
Il decennio più gettonato e cruciale per lo sviluppo dell’idea è però quello degli anni Novanta, come l’analisi sulla popolarità del termine con cui si è aperto il capitolo conferma. Sono gli anni della diffusione di massa della telefonia mobile e del lancio del World Wide Web, ancora oggi una delle principali applicazioni della rete internet. È il decennio in cui Bill Clinton e Al Gore, rispettivamente presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, elaborarono il noto piano The National Information Infrastructure: Agenda for Action (1993), meglio conosciuto come il progetto delle «autostrade dell’informazione», che mirava a potenziare e digitalizzare le reti di telecomunicazioni del paese e che fu poi copiato e adattato in molte altre nazioni. Nelle prime righe di questo documento si diceva: «Lo sviluppo dell’infrastruttura nazionale dell’informazione può aiutare a scatenare una rivoluzione dell’informazione che cambierà per sempre il modo in cui le persone vivono, lavorano e interagiscono tra loro». Il mantra della rivoluzione totale (che verrà indagato meglio nel capitolo 3) era quindi già ben presente. Sempre nei primi anni Novanta nacque «Wired», la rivista probabilmente più simbolica e più autorevole della rivoluzione digitale, che verrà citata spesso in questo libro e che soprattutto contribuì a diffondere, o meglio a propagandare, l’esistenza e la rilevanza della rivoluzione stessa.
Altri osservatori ritengono invece che la rivoluzione digitale sia avvenuta davvero a partire dagli anni Duemila, quando effettivamente milioni e poi miliardi di persone cominciarono a usare i loro smartphone per connettersi alla rete. Secondo questa tesi, una rivoluzione si realizza pienamente quando i suoi effetti e i suoi prodotti sono a disposizione della massa, cosa effettivamente accaduta solo negli ultimi decenni, oltretutto in maniera diseguale a seconda delle regioni del mondo.
La periodizzazione della rivoluzione digitale è complicata proprio dal fatto che, in paesi e culture diverse, la digitalizzazione è giunta in momenti distinti e spesso in ritardo rispetto agli Stati Uniti o ad altri paesi occidentali digitalmente all’avanguardia. Cina, India o Russia vengono ritenute da decenni «sul punto di» abbracciare la rivoluzione digitale (la locuzione on the cusp of è ossessivamente ripetuta dalla pubblicistica internazionale) o, più recentemente, queste stesse nazioni sono candidate a «guidare» questa rivoluzione nel mondo di domani. Lo si sostiene sulle pagine di «China Daily», su quelle del «Moscow Times» o sul «Times of India», ma lo si può anche ascoltare nei discorsi ufficiali di politici e imprenditori di quei paesi. Se in Cina questa narrazione è emersa almeno dai primi anni Duemila, in India è un fenomeno che risale al secondo decennio del secolo. Per esempio, il già citato primo ministro Narendra Modi nel 2018 ricordò come l’India fosse alle soglie della quarta rivoluzione industriale (uno dei tanti sinonimi della rivoluzione digitale, come vedremo) e che l’avrebbe guidata in futuro. Altri organi di stampa, come «allAfrica» o «Gulf Business», parlano di una rivoluzione digitale in grado di far progredire e far compiere un definitivo salto nella modernità alle zone più arretrate dell’Africa, dell’Asia o dell’America Latina. Sembra, insomma, che la forza retorica della rivoluzione digitale si sia trasferita dagli Stati Uniti, dove imperversò negli anni Novanta e all’inizio del Duemila, agli altri paesi del mondo senza sostanziali rivisitazioni.
La rivoluzione digitale è giunta con tempi molto diversi anche in vari settori mediali e della vita quotidiana e questo è un altro fattore che ha contribuito a complicarne la datazione. Per restare ai media, per esempio, il settore della musica è stato tra i primi a essere trasformato dalla digitalizzazione già a partire dagli anni Ottanta del Novecento con il CD, poi con il formato MP3 negli anni Novanta, quindi con la musica in streaming dai primi anni Duemila. Altri settori mediali sono stati interessati dal fenomeno della digitalizzazione molto più tardi e per alcuni – per esempio la radiofonia e l’editoria libraria – il processo di completa digitalizzazione non è mai avvenuto e forse non avverrà.
Ancor più interessanti e vaghi sono i discorsi associati alla presunta conclusione della rivoluzione digitale – del resto le rivoluzioni hanno molti inizi e raramente hanno una fine. Alcuni osservatori sostengono che la rivoluzione digitale sia finita perché ha vinto e ha definitivamente trasformato il modo di vivere degli esseri umani. Questa ipotesi, emersa tanto negli anni Novanta quanto negli anni Duemila, esibisce come prova il fatto che staremmo già vivendo in un universo o meglio in un’era digitale, di c...
Indice dei contenuti
- Introduzione. Capire l’ultima delle ideologie
- 1. Definire la rivoluzione: benedetta incertezza
- 2. Confrontare la rivoluzione: eredità del passato, costruzione del presente
- 3. Pensare la rivoluzione: i mantra
- 4. Credere nella rivoluzione: una quasi-religione contemporanea
- Conclusione. A chi serve e perché prosegue la rivoluzione digitale?
- Riferimenti bibliografici