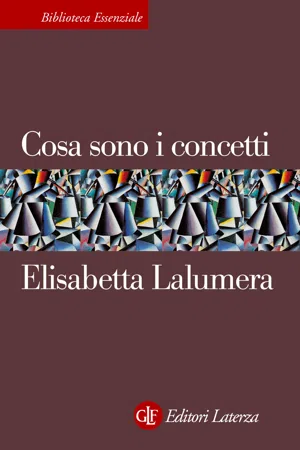
- 184 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Cosa sono i concetti
Informazioni su questo libro
Se i concetti non esistessero, la nostra mente non potrebbe cogliere (e ricordare) ciò che gli oggetti delle nostre esperienze hanno in comune. In queste pagine, filosofia e psicologia cognitiva concorrono a tracciare la natura del nostro ragionare.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Cosa sono i concetti di Elisabetta Lalumera in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Storia e teoria della psicologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PsicologiaCategoria
Storia e teoria della psicologia1.
Il problema dei concetti
Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo,
que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.
En el abarrotado mundo de Funes no había
sino detalles, casi inmediatos.
que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer.
En el abarrotado mundo de Funes no había
sino detalles, casi inmediatos.
Jorge-Luis Borges
Funes el memorioso
1.1. Concetti e categorie
Ogni istante della nostra vita è unico e irripetibile. Il geranio sul mio davanzale non sarà mai più uguale a come lo vedo ora, con lo stesso numero di petali nella medesima posizione, con la stessa gradazione di rosso e di verde nella luce delle dieci. Dopotutto però, lo innaffierò anche domani. Si tratterà di riconoscere che è la stessa pianta, che è una cosa dello stesso tipo. Niente di più facile. Per comprendere e modificare la realtà, la nostra mente è in grado di rappresentarne gli aspetti salienti e ricorrenti e di elaborare queste rappresentazioni: i concetti. Applicare un concetto per categorizzare significa appunto riconoscere che l’esperienza presente, l’individuo qui e ora, è simile a qualcos’altro, già incontrato prima: che appartiene a un tipo, una categoria. Così, per fare qualche esempio un po’ diverso, se avete un concetto di arte gotica riconoscete che il duomo di Milano e Notre Dame di Parigi appartengono a una categoria comune, anche se sono edifici molto diversi sotto vari aspetti. E il vostro concetto di ingiustizia vi permette di individuare ciò che è comune alla situazione di un prigioniero condannato senza processo e a quella dell’unico bambino della classe che non viene lodato per l’esercizio risolto. I concetti ci permettono di marcare l’identico in situazioni diverse. Inoltre, usare un concetto per pensare o immaginare permette di utilizzare le informazioni che possediamo, anche in assenza dello stimolo che le ha generate. Così, voi e io possiamo discutere di arte gotica anche se, in questo momento, i nostri occhi sono fissi su una pagina scritta. Per questo i concetti sono fondamentali per l’uso e la produzione del linguaggio, per il ragionamento, la soluzione di problemi, l’immaginazione e l’azione. Se la nostra memoria fosse piena di ‘dettagli’ e di ‘casi particolari’ – come nella citazione da Borges che ho riportato sopra – nulla di tutto questo sarebbe possibile. Ma ci torneremo più avanti.
Intanto, una prima chiarificazione terminologica. Chiamiamo ‘categorie’ i tipi di cose che, per una ragione o per l’altra, ci interessa distinguere e rappresentare tramite i concetti: specie, eventi e tipi di oggetti (i cani, il Natale, i film di Antonioni, le forchette, i numeri pari) oppure proprietà (rosso, noioso, cinese). In quanto segue converrà adottare un’ontologia (un inventario di ciò che esiste) abbastanza larga da contenere tutte queste varietà di tipi di cose, in aggiunta agli individui (questo geranio, la mamma, Jack lo Squartatore, Immanuel Kant). Distinguiamo quindi le categorie (e gli individui – d’ora in poi questo sarà sottinteso), che sono ‘nel mondo’, dai concetti che le rappresentano, secondo un uso abbastanza consolidato in filosofia e un po’ meno in psicologia, dove talvolta i due termini sono usati in modo intercambiabile.
C’è una questione filosofica importante a proposito del rapporto tra categorie e concetti: tra la realtà con le sue ‘nervature naturali’ (come diceva Platone) e il nostro modo di segmentarla. Ad esempio, di solito si è propensi a ritenere che l’oro e l’acqua esisterebbero anche senza i nostri concetti di oro e di acqua, seguendo un’intuizione realista, e che sarebbero comunque distinti dal rame o dall’acido cloridrico, indipendentemente dagli interessi, dalle pratiche e dalle abitudini di vita degli esseri umani. Le scienze naturali studiano l’oro e l’acqua, non i nostri concetti di oro e di acqua. Certamente la questione si complica quando ci chiediamo se le ingiustizie esisterebbero anche senza il nostro concetto di giustizia. Per i nostri scopi, tuttavia, possiamo evitare di chiederci se vengano prima le categorie o i concetti, fermo restando che li teniamo distinti. Spetta alla metafisica occuparsi delle differenze fra categorie, i tipi di cose: fra quelle evidentemente meno dipendenti dalla nostra attività cognitiva e quelle che sembrano scaturire dai nostri modi di vivere. Distinguere categorie e concetti consente comunque di mantenere l’intuizione secondo la quale c’è una differenza tra una cosa (di qualunque tipo sia) e la sua rappresentazione.
Diciamo che un concetto si riferisce a o rappresenta una categoria – ad esempio il concetto di cane si riferisce a tutti e soli i cani, quelli presenti, passati e futuri, e il giudizio ‘è un cane’ è vero di ciascuno di essi. Allo stesso modo diciamo che la parola italiana ‘cane’ si riferisce ai cani. Lasciamo qui a ‘rappresentazione’ un senso intuitivo: è qualcosa che sta per qualcos’altro in virtù di certe caratteristiche particolari. Ad esempio il mio codice fiscale rappresenta la mia persona per il fisco e per l’anagrafe della Repubblica italiana. Ma anche la mia foto rappresenta me, in un altro modo (e le mie tracce sulla sabbia in un altro modo ancora). In che modo un concetto rappresenta una certa categoria? In virtù di quale relazione tra l’uno e l’altra? Come deve essere fatto un concetto per rappresentare una categoria fra tutte le altre? Questa è una delle domande fondamentali che riguarda i concetti; qui la chiameremo questione semantica. La risposta classica che ci viene dalla storia della filosofia è la seguente: un concetto rappresenta una categoria perché codifica tutte e sole le proprietà che i membri di quella categoria possiedono. Ogni categoria ha una natura – un insieme di proprietà condivise – che il concetto rispecchia, o esprime. Ad esempio, il concetto di cane codifica le proprietà di essere un animale, mammifero, quadrupede, carnivoro, eccetera. Per questo si riferisce ai cani, che godono di queste proprietà. Il dibattito contemporaneo – come vedremo – nasce dalla critica alla teoria classica.
La controparte psicologica o cognitiva della relazione di riferimento è la categorizzazione, che avviene nella nostra mente: noi applichiamo i concetti alle cose del mondo, talvolta sbagliando, talvolta correttamente. La categorizzazione è un processo complesso, che la psicologia studia con esperimenti comportamentali, simulazioni di intelligenza artificiale, e oggi anche con tecniche di brain-imaging. Si possono studiare i concetti anche chiedendosi, in primo luogo, come avviene la categorizzazione. Dato poi che categorizzare significa rendere disponibili informazioni percettive per il ragionamento, l’azione e la comunicazione, indagare la natura dei concetti dal punto di vista cognitivo comporta porsi il problema delle relazioni tra concetti e percezione, apparati sensomotori, capacità di parlare e comprendere. Tipicamente gli psicologi oggi non affrontano la questione semantica in modo diretto, bensì descrivendo i meccanismi responsabili della categorizzazione e delle altre capacità cognitive superiori.
La terza questione fondamentale riguardo ai concetti in realtà precede le altre due in senso logico – anche se è una domanda che di solito ci si pone quando già si dispone di una teoria su come funziona la nostra conoscenza del mondo. Si tratta della questione metafisica: i concetti esistono? Nella nostra ontologia, cioè l’inventario delle cose reali – accanto ai tavoli, alle biciclette, ai fondi azionari e ai dentisti – dobbiamo ammettere anche i concetti? Se sì, un concetto – il concetto di ingiustizia ad esempio – è un oggetto astratto, come un numero, oppure è uno stato della nostra mente, oppure ancora una configurazione del cervello?
C’è infine la questione dell’individuazione – termine, quest’ultimo, entrato nell’uso relativamente da poco in filosofia. Che cosa rende un concetto diverso da ogni altro, ovvero, in che consiste dire che A e B sono lo stesso concetto, oppure due concetti diversi? Si noti che la questione dell’individuazione si pone per svariati generi di entità, anche per alcuni che ci sono ben più familiari dei concetti. Ad esempio, intuitivamente abbiamo un’idea abbastanza precisa del criterio di individuazione delle persone: una persona è diversa dall’altra se ha un diverso codice genetico e una diversa data di nascita. Paradossalmente è meno facile fissare un criterio di individuazione per oggetti ben più banali, come i treni. Se qualcuno vi dice che prende ogni mattina lo stesso treno dovete adottare un criterio di individuazione fra vari possibili, ossia decidere se il vostro interlocutore intende dirvi che ogni mattina percorre la stessa tratta nello stesso orario, oppure se sale sul medesimo insieme di carrozze e locomotore, oppure ancora se per ‘stesso treno’ dovete intendere stesso orario, tratta e insieme di veicoli. Anche per i concetti, come vedremo, è possibile fornire diversi criteri di individuazione, fra loro incompatibili, come nel caso dei treni.
Con un’iperbole nemmeno troppo azzardata, si potrebbe dire che la storia della filosofia e quella della psicologia consitono, in buona sostanza, nella storia delle risposte a queste domande sui concetti (e a poche altre): la questione semantica, quella ontologica e metafisica, e la questione dell’individuazione. Platone, Aristotele, Guglielmo di Ockham, Tommaso d’Aquino, Descartes, Locke, Hume, Berkeley, Kant e Wittgenstein si sono occupati, potremmo dire, di comprendere la natura dei concetti, o ‘idee’, o ‘termini mentali’. Alcuni periodi sono stati particolarmente proficui per questa ricerca, e probabilmente ne stiamo vivendo uno. A partire dal 1960 circa, la filosofia e la psicologia hanno prodotto molte idee importanti sui concetti, elaborato nuove teorie e anche ridiscusso i modelli proposti dai filosofi del passato. Lo sviluppo veloce delle scienze della mente, da un lato, e il dialogo tra filosofi e psicologi dall’altro rendono oggi molto vivo il dibattito. In questo libro partiremo proprio dal passato prossimo – la filosofia e la psicologia degli ultimi cinquant’anni circa – per illustrare alcuni problemi e soluzioni specifici che sono stati proposti.
1.2. Possiamo fare a meno dei concetti?
Partiamo dall’inizio, dall’ontologia. I concetti esistono? Per avvicinarsi alla risposta può essere utile compiere prima un esercizio di immaginazione o, come si dice tra i filosofi analitici, un esperimento mentale: supporre che i concetti non ci siano, e considerare le conseguenze. Si sono cimentati in questo esperimento diversi autori del passato. John Locke, nel Saggio sull’intelletto umano (1690), scrive che nessuna mente è abbastanza spaziosa da contenere la rappresentazione di ogni singolo oggetto, uomo, animale, pianta o altro, che sia stato esperito con i sensi. Vale a dire: se non avessimo concetti, tutto ciò di cui facciamo esperienza ‘non ci starebbe’. Anche la nostra lingua sarebbe enormemente complicata: senza poter rappresentare tipi di cose, ma solo individui, avremmo una moltitudine non governabile di nomi propri. Locke sembra dire qui che, in sostanza, abbiamo i concetti per ragioni di spazio: con una mente più capace – un magazzino più grande, un hard disk più potente – potremmo tenere traccia di ogni particolare che abbiamo incontrato, e fare a meno dei concetti. La stessa idea si trova in uno dei classici contemporanei della psicologia dei concetti, il testo di Edward Smith e Douglas Medin:
senza concetti, la vita mentale sarebbe caotica. Se percepissimo ciascuna entità come unica, saremmo sopraffatti dalla effettiva diversità di ciò di cui facciamo esperienza, e non riusciremmo a ricordarne altro che una minima parte. E se ci fosse bisogno di un nome diverso per ogni entità individuale, la nostra lingua sarebbe tremendamente complessa, e la comunicazione praticamente impossibile (Smith e Medin 1981, p. 1).
Di fatto, è vero che siamo dotati di menti finite (e nemmeno i nostri computer se la passano meglio). Ma cambiamo le coordinate dell’esperimento per capire se una mente infinita potrebbe ‘fare senza’. Consideriamo Funes el memorioso, il protagonista di un famoso racconto dello scrittore argentino Jorge-Luis Borges. Funes non aveva problemi di spazio mentale: a causa di un incidente provocato da un cavallo – immagina Borges – egli ricordava tutto quello che vedeva e sentiva, in ogni minimo dettaglio. Ad esempio com’era un certo fiore che aveva tenuto in mano in una certa ora, oppure «la forma delle nubi australi dell’alba del 30 aprile 1882» (J.L. Borges 1944). Funes aveva anche escogitato un sistema numerico – un linguaggio fatto di cifre – che gli permetteva di dare un nome a ciascun ricordo. Ma la sua non era una situazione ideale. Lasciamo stare il peso esistenziale dei ricordi (avrebbero potuto essere tutti belli, anche se il racconto è velato di tristezza): Borges suggerisce che forse Funes non era in grado di pensare, di utilizzare davvero la massa di dati in suo possesso. Ogni rappresentazione nella sua mente, potremmo dire, era così dettagliata da fare tipo a sé, era irrimediabilmente particolare. Quando Funes ricordava una giornata, gli ci voleva una giornata, e non serviva a nulla.
Alla stessa conclusione arriva il matematico e astronomo francese Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1748) con una variante, potremmo dire, dell’esperimento mentale di Borges. Immaginiamo una popolazione di esseri che ricordano tutto, come Funes, ma che hanno pochissime esperienze, tanto da poter ‘chiamare per nome’ (un nome proprio ovviamente) ciascuna di esse senza difficoltà. Nemmeno questi piccoli archivisti, suggerisce Maupertuis, potrebbero fare molto con le loro raccolte di rappresentazioni particolari: ‘nessuna delle questioni che oggi tanto ci assillano si [potrebbe] insinuare nel loro spirito’.
Ma che cosa, esattamente, non potrebbero fare? Dopotutto, i loro archivi mentali sono accurati: contengono esattamente la copia di tutto ciò che è stato esperito. Sono come una carta geografica che riproduca ogni cosa, senza tralasciare alcun particolare e dettaglio. Come terzo esperimento mentale immaginiamo una mappa che sia fatta proprio così, in scala 1:1. Ecco un dialogo del logico e scrittore inglese Lewis Carroll in cui si discutono gli svantaggi di questa mappa (Sylvie and Bruno Concluded, 1893):
«And then came the grandest idea of all! We actually made a map of the country, on the scale of a_ mile to the mile_!». «Have you used it much?» I enquired.
«It has never been spread out, yet,» said Mein Herr: «the farmers objected: they said it would cover the whole country, and shut out the sunlight! So now we use the country itself, as its own map, and I assure you it does nearly as well».
Facile concludere che la mappa in scala 1:1 non serve a nulla, alla fine è meglio farne a meno. Perché, dunque, non possiamo fare senza concetti? Come sostiene in modo incisivo la filosofa contemporanea Ruth Millikan (Millikan 2000), i concetti ci servono per ‘reidentificare’: ‘marcare l’identico’ in situazioni diverse. Marcare l’identico richiede che venga tralasciata, in qualche misura, l’informazione sulle differenze – che si eviti la scala 1:1 – ma permette di connettere le informazioni ricevute. Ai piccoli archivisti di Maupertuis e ai cartografi scrupolosi di Carroll manca questa capacità fondamentale di connettere, come anche a Funes. Per questo Borges scrive che forse il protagonista del suo racconto non è davvero in grado di pensare. Non può imparare, né utilizzare la conoscenza acquisita. Vediamo questo processo più in dettaglio.
1.3. A che cosa servono i concetti
Only connect.
Edward Morgan Forster
La funzione dei concetti nell’apprendimento è quella di astrarre, ovvero tralasciare le informazioni (in questo caso quelle relative al caso particolare) e trattenerne altre. Ecco come viene descritta dallo psicologo dello sviluppo Paul Bloom:
bevo un succo d’arancia e mi piace. Bevo olio e non mi piace. La sedia mi regge quando mi ci siedo; se mi siedo su una scatola di cartone, la scatola si sfascia e finisco sul pavimento. Se accarezzo il gatto, fa le fusa, se accarezzo il cane può darsi che ringhi. Questi eventi costituiscono lezioni importanti: sul bello del bere aranciata e sul brutto del bere olio, su dove sedersi e dove no, e con quali creature è il caso di interagire. Ma da essi si può imparare solo se si possiede una rappresentazione mentale dei tipi di cose in questione. Per imparare dall’episodio dell’aranciata non basta sapere che questo liquido questa volta è gradevole: bisogna poter generalizzare ...
Indice dei contenuti
- 1. Il problema dei concetti
- 2. Come sono fatti i concetti
- 3. I concetti e l’architettura della mente
- Epilogo. Varietà di concetti
- Cos’altro leggere
- Riferimenti bibliografici
- L’autrice