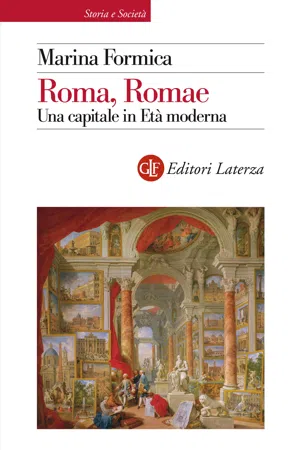Il processo d’innesto tra antico e nuovo che aveva segnato la storia dell’Urbe durante il XV secolo giunse, com’è noto, a piena maturazione nel Cinquecento, un secolo in cui si assistette a una trasformazione complessiva della vita ecclesiastica e devozionale, della sfera letteraria e artistica, delle relazioni politiche, economiche e sociali non solo in svariati Stati europei, con le loro diverse propaggini, ma in primo luogo nei domini ecclesiastici. E, considerato che fu proprio Roma il motore del cambiamento, non sembra azzardato assumere la città a osservatorio dei molteplici problemi legati all’affermazione delle monarchie assolute, alla riconversione feudale e fondiaria del capitale, agli innesti tra il latino classico e le lingue volgari, così come all’aspirazione di nuove esperienze di religiosità e all’emergere di nuove concezioni del manufatto urbano.
In un’età variamente definita dagli storici – età di transizione? Italistic Age? età del tardo Rinascimento o del Rinascimento, tout court? età della Controriforma? della Riforma cattolica? –, l’Urbe si configura infatti quale laboratorio sperimentale di tendenze più generali, che portano pure a riconsiderare la questione delle periodizzazioni: nella scelta d’includere o di escludere la Controriforma, il Concilio di Trento, emerge, in particolare, la questione se avvalorare o meno un lungo Rinascimento che dal XVI secolo arrivi fino all’Illuminismo settecentesco, a enfatizzare le continuità di un processo che pose l’essere umano al centro del mondo.
Sullo sfondo di queste e altre possibilità interpretative, può forse apparire paradossale notare come, in un universo ormai globalizzato, che vedeva l’Europa venire in contatto con le alterità del Nuovo Mondo condizionandole ed essendone condizionata, Roma si fosse imposta come fulcro di una nuova centralità. Realtà cosmopolita da sempre, nel XVI secolo la città iniziò a essere nuovamente riconosciuta come «plaza del mundo», secondo la celebre definizione di Ferdinando il Cattolico; un riconoscimento confermato ancora a fine secolo dal barone de Bemelberg, per il quale era appunto Roma, indiscutibilmente, la «capitale del mondo».
Il XVI secolo si aprì sotto il pontificato del ligure Giuliano della Rovere (1503-1513). La scelta del nome, Giulio II, rinvia non solo a una prassi consolidata (i pontefici della prima Età moderna sceglievano in genere nomi diversi da quelli dei predecessori, a rimarcare la propria soggettività e autonomia), ma, più specificamente, a un’opzione simbolicamente precisa: intendimento del neo-eletto, invero, era quello di eleggere a proprio modello il grande condottiero e imperatore dell’antica Roma, Giulio Cesare.
Sin dai riti dell’insediamento, della Rovere propose con insistenza richiami al passato glorioso dell’Urbe. Nel quadro di una cerimonialità elaborata e maestosa, poi divenuta punto di riferimento dei pontificati successivi, Giulio II iniziò con il prendere «possesso» della Basilica del Laterano, prima di procedere all’intronizzazione liturgica a San Pietro; successivamente, accompagnato da un solenne corteo, si diresse al Campidoglio, da dove, ricevute le chiavi della città dalle mani del senatore, iniziò la cavalcata per la Via Papalis. Archi decorati da motivi classicheggianti fecero da scenario al passaggio in cui il pontefice, profondendo monete al popolo, accolse dal rabbino capo il rotolo del Pentateuco rovesciato, a sottolineare la sottomissione che la comunità ebraica avrebbe dovuto riconoscergli.
Una spiccata impronta militaresca contraddistinse la Roma del potente nipote di Sisto IV, passato alla storia come «il papa guerriero». «Principe secolare» più che «pontefice», secondo la nota espressione guicciardiniana, egli intendeva consolidare lo Stato ecclesiastico e ottenere l’unanime riconoscimento della supremazia dell’Urbe sul mondo. In nome di questi obiettivi mirò ad assicurarsi il consenso delle famiglie della nobiltà romana più direttamente colpite dal nepotismo familistico del suo predecessore (i Caetani, gli Orsini, i Colonna, oltre che i della Rovere) e di alcune potenze italiche (gli Sforza, i Varano, i Montefeltro), fino ad allearsi con Luigi XII di Francia e con l’imperatore Massimiliano, uniti tutti dalla comune avversione alla Repubblica di Venezia, che, tra l’altro, aveva occupato le Romagne e i territori che Alessandro VI aveva precedentemente assegnato ai propri familiari. Questa solida trama di alleanze fu altresì coronata dal sostegno finanziario offertogli dal banchiere Agostino Chigi, che, divenuto appaltatore illuminato delle miniere di Tolfa – motore ormai dell’industria tessile di tutta Europa –, proseguì anche con questo papa nella concessione di prestiti a interessi elevati.
Armato un possente esercito contro Perugia e contro Bologna, Giulio riusciva dunque a sconfiggere le signorie locali dei Baglioni e dei Bentivoglio e a entrare trionfalmente nelle due città riconquistate. La successiva battaglia di Agnadello (14 maggio 1509), contro la Serenissima, segnò l’apoteosi di Roma. I Veneziani, umiliati, furono di fatti costretti a restituire Ravenna, Rimini, Cervia, Faenza. Forte di questi successi, della Rovere procedette sicuro anche all’incorporamento di Parma e Piacenza, sottratte al Ducato di Milano nel 1512, senza curarsi delle comprensibili resistenze dell’imperatore, che, a quel punto, pare mirasse addirittura a sostituirlo al soglio di Pietro.
Non è un caso che Niccolò Machiavelli insista nel ritrarre Giulio II intento a presentarsi come «italiano et desideroso del bene italico» (Principe XI). Con lui, l’affermazione dell’Urbe come potenza centrale nella penisola divenne inconfutabile, assoluta. Riducendo i territori concessi in vicariato e favorendo l’espansione dei domini immediate subiectae – amministrati da un legato o da un rettore rappresentante del papa –, della Rovere riuscì inoltre ad attuare il disegno d’inserirsi nelle dinamiche tra le baronie e i poteri municipali in varie aree dei suoi domini rinsaldando la posizione centrale della capitale. Anche nei confronti di quest’ultima, d’altronde, il pontefice conseguiva un ennesimo successo: con la creazione della guardia svizzera (1506), infliggeva al patriziato cittadino, già esautorato dei propri tradizionali, residui privilegi, pure l’interdizione dalla custodia dei palazzi apostolici.
Un siffatto autoritarismo non poteva non suscitare resistenze tra i ceti aristocratici. E quando una grave malattia afflisse il papa, nell’estate del 1511, facendo presagire come imminente un ricambio al vertice, si verificò un fatto del tutto imprevisto: le famiglie che, da consuetudine, detenevano il controllo militare della città (i Colonna, gli Orsini, gli Anguillara, i Cesarini, i Savelli) si allearono tra loro per imporre al collegio cardinalizio la designazione di porporati appartenenti alle relative genìe. Era la cosiddetta pax romana, un’alleanza in base alla quale il pontefice, una volta ristabilito, si trovò costretto a intraprendere la via della mediazione e dunque a concedere sia alcuni privilegi alle rappresentanze cittadine sia diverse condotte militari ai baroni ribelli.
Sarebbe purtuttavia parziale, oltre che scorretto, ricordare la Roma giuliana solo come città aggressiva e militaresca.
Si è già notato come papa della Rovere avesse iniziato il suo mandato declinando l’immagine della Roma moderna attraverso la riproposizione di quella antica con una cerimonia fastosa, destinata a divenire modello d’emulazione per vari sovrani europei. Ebbene, proprio la grandiosità appare come il tratto distintivo di questo pontefice, che, oltre a organizzare numerose celebrazioni improntate alla riproposta dei valori dell’antichità (celebri i cortei e le mascherate del Carnevale del 1513, ove Giulio II venne osannato come «liberatore d’Italia»), volle istituire la...