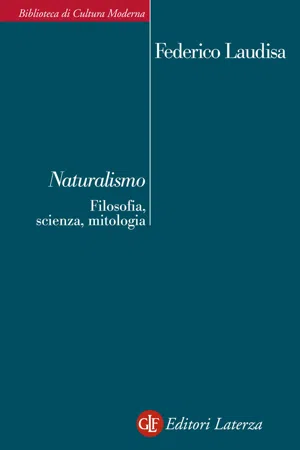Capitolo 1. Geografie del naturalismo
[La scienza moderna] ha rifiutato di riconoscere l’autorità del filosofo, che pretende di conoscere la verità attraverso l’intuizione, col penetrare, cioè, in un mondo di idee o nella natura della ragione o nei princìpi dell’essere o in qualsiasi altro modo che trascenda l’empirico. Anche per i filosofi la via della verità non può essere diversa. Il cammino dei filosofi è indicato da quello degli scienziati (Reichenbach 1979, p. 197)
1.1. Un termine, molti significati
Quando al risveglio dai sogni di gloria dell’empirismo logico, e dei vari fondazionalismi che ne erano derivati, la riflessione filosofica di orientamento analitico si è ritrovata con un gran bisogno di strumenti intellettuali nuovi, uno tra i più utili si è rivelato il concetto di ‘somiglianza di famiglia’, discusso originariamente da Ludwig Wittgenstein nelle Ricerche filosofiche. Alle prese con mille varianti di una vaga intuizione di partenza, la somiglianza di famiglia permette di raggruppare in uno spazio comune una serie di concetti tra loro vicini sotto alcuni aspetti fondamentali, senza doversi troppo preoccupare di dimostrarne l’equivalenza logica in modo rigoroso. Per un primo sommario inquadramento dell’oggetto di questo libro – il naturalismo, nelle sue varianti filosofiche e scientifiche – l’uso della somiglianza di famiglia è non soltanto utile, ma indispensabile. Analogamente a molti altri concetti filosofici, non esiste infatti una formulazione univoca e universalmente condivisa di naturalismo, ma piuttosto un ampio albero genealogico di concetti più o meno strettamente imparentati, che contribuiscono nel loro complesso a formare un clima filosofico più che una teoria univoca e rigorosamente strutturata. Questa circostanza è un luogo comune di gran parte dei testi che si occupano di naturalismo filosofico – Jaegwon Kim parla per esempio della «pletora di naturalismi» (Kim 2003, p. 84; cfr. anche Picardi 1997, p. 109) – e certe caratterizzazioni del naturalismo cui faremo riferimento nel corso del libro potranno dunque risultare talvolta approssimative. Anche se questa approssimazione apre in linea di principio la strada, di fronte ad argomenti critici su certi tipi di naturalismo, all’obiezione che quello di cui staremmo parlando non è ‘autentico’ naturalismo ma soltanto una sua versione ‘deviante’, l’adozione del suddetto concetto di somiglianza di famiglia dovrebbe essere sufficiente per bloccare questa possibilità o almeno per renderla concettualmente oziosa (cfr. per es. Maddy 2007, p. 1). In prima approssimazione, possiamo considerare il naturalismo come quell’atteggiamento filosofico che:
(N1) accetta come possibili entità del mondo soltanto i tipi di cose che le teorie scientifiche pongono come oggetti effettivi della loro indagine;
(N2) ritiene che i metodi delle teorie scientifiche siano gli unici che producono autentica conoscenza;
(N3) nega all’analisi concettuale tipica della filosofia un ruolo privilegiato nella giustificazione della conoscenza stessa.
Pur nella varietà di prospettive di cui cercheremo di fornire una mappa nel corso del libro, il naturalismo rappresenta certamente lo spirito del tempo nella filosofia analitica a partire dalla seconda metà del XX secolo. Non sono naturalmente mancati filosofi che hanno assunto una posizione critica nei confronti di questo atteggiamento culturale ma il citato Kim, per esempio, descrive semplicemente una situazione di fatto quando afferma che «se si può dire che la filosofia analitica attuale abbia un’ideologia filosofica, questa è indubbiamente il naturalismo. Il naturalismo filosofico ha guidato e vincolato la filosofia analitica come suo credo dominante per gran parte del ventesimo secolo» (Kim 2003, p. 84). Ma al di là della distanza tra chi magnifica le sorti del naturalismo e chi ne prende le distanze, è necessario mettere subito in evidenza un primo aspetto costitutivo, che non è formulabile in modo completamente preciso e univoco per ogni ambito di discussione ma che ne caratterizza indubbiamente l’identità in un senso trasversale: il naturalismo dipende in modo essenziale da un modello di conoscenza di origine strettamente scientifica e, più in generale, dal ruolo di paradigma della conoscenza che la scienza ha assunto negli ultimi tre secoli. La centralità di una certa immagine di razionalità scientifica in tutte le numerose varianti del naturalismo implica allora un’attenzione particolare a un aspetto sul quale ci concentreremo tra breve, nel prossimo paragrafo: il ruolo fondamentale che la rivoluzione scientifica ha svolto nell’introdurre nella cultura occidentale una categoria – per così dire – di esistenza scientifica, una categoria che semplicemente non esisteva prima della rivoluzione scientifica ma che modella in modo irriducibile tutta la riflessione filosofica successiva sull’ontologia, l’epistemologia e i loro complessi rapporti.
Nella sua lunga storia, la filosofia ha dato vita a un grande arcipelago di visioni del mondo e della ragione umana: in questa mappa concettuale, molti ‘ismi’ propongono tesi sulla natura della realtà, della conoscenza o della mente che, singolarmente, sono certamente di estremo interesse per un filosofo naturalista: tesi come – poniamo – ‘ogni autentica forma di conoscenza deve avere origine empirica’ o ‘la mente dipende in modo funzionale dalla struttura del cervello’ e via di questo passo. Il rapporto costitutivo che il naturalismo instaura con la scienza influenza tuttavia anche un secondo aspetto costitutivo del naturalismo, vale a dire la sua natura metafilosofica: il naturalismo, infatti, ambisce a vincolare in una precisa direzione l’identità stessa della filosofia, prescrivendo quali dovrebbero essere i compiti di un’analisi filosofica nei suoi rapporti con la scienza.
Avendo idealmente di fronte sia l’area dei ragionamenti filosofici sia l’area della conoscenza accumulata dalle teorie scientifiche, il naturalismo si propone infatti di indicare alla riflessione filosofica un obiettivo primario: analizzare la conoscenza umana come un vero e proprio insieme di processi naturali, le cui proprietà e i cui confini devono essere studiati in una prospettiva non troppo dissimile da quella nella quale il biologo studia un virus e il fisico studia le caratteristiche termiche di un nuovo materiale. È proprio in questa prospettiva metafilosofica che il naturalismo scientifico-filosofico contemporaneo potrebbe essere rappresentato in prima battuta con l’aiuto di (almeno) tre divieti.
Divieto 1: abbasso le entità sovrannaturali;
Divieto 2: abbasso la filosofia ‘prima’ e il ruolo privilegiato del ragionamento a priori;
Divieto 3: non può esistere una teoria filosofica della conoscenza e della giustificazione, ma soltanto una teoria scientifica della cognizione (trascuriamo in questa fase il fatto che si possono avere molte idee diverse su cosa sia la ‘cognizione’, con conseguenze potenzialmente importanti sul dibattito intorno al naturalismo).
Questa formulazione può essere utile in prima istanza, dal momento che trasmette efficacemente l’idea che il naturalismo si contrappone in modo molto netto a tesi che hanno occupato (e, nelle forme dovute, continuano a occupare) un ruolo molto rilevante nella tradizione filosofica anche recente. È altrettanto chiaro tuttavia che si tratta di una formulazione imprecisa: provare a chiarirla ci permetterà di porre all’attenzione aspetti centrali della visione naturalistica del mondo e della conoscenza di esso, aspetti che – proprio per la loro centralità – vedremo ripresentarsi anche in capitoli successivi.
Un primo elemento di ambiguità è rappresentato dal fatto che i tre divieti non sono tutti diretti a una medesima area di indagine filosofica. Il primo è evidentemente un divieto di natura ontologica, dal momento che rappresenta una presa di posizione su come deve essere fatto ciò che esiste (in un senso naturalisticamente accettabile di ‘esistere’: ma su questo torneremo a breve). Bandire le entità sovrannaturali dovrebbe però comportare in primo luogo sapere o dare per noto cos’è ‘naturale’ – un’assunzione che assomiglia pericolosamente al tentativo di dare implicitamente per risolto proprio il problema che si sta cercando di risolvere o di chiarire. Lo stesso David Hume, il filosofo che a ragione o a torto viene indicato come il proto-naturalista moderno, così scriveva intorno al problema dell’origine naturale o meno dei princìpi morali: «Ma se si dovesse chiedere se dobbiamo cercare questi princìpi in natura, o se invece dobbiamo cercare loro un’origine diversa, replicherei che la nostra risposta dipenderà dalla definizione della parola ‘natura’, e che nessuna parola è più ambigua ed equivoca di questa» (Hume 1987, vol. 1, p. 501). Caratterizzare l’aggettivo ‘naturale’ contrapponendolo a ‘sovrannaturale’, ‘artificiale’ o ‘normativo’, significa per esempio assumere implicitamente che l’interpretazione dell’aggettivo ‘naturale’ nel senso di «ciò che è descritto dalle scienze naturali come un oggetto del mondo» sia non problematica, cosa evidentemente non vera. Inoltre, il bando nei confronti delle entità sovrannaturali potrebbe in linea di principio comportare l’eliminazione dall’insieme di tutto ciò che esiste ‘in senso forte’ (cioè nel senso naturalistico di cui sopra) anche di cose come i numeri o più in generale le strutture matematiche. Il prezzo da pagare per un’eliminazione del genere sembra piuttosto elevato: proprio tra coloro che lavorano nell’ambito di quelle scienze ‘dure’ che motivano il radicalismo di molti naturalisti, sarebbero non pochi quelli che resisterebbero strenuamente all’applicazione indiscriminata del bando nei confronti, per esempio, di cose come i numeri reali o i gruppi di simmetria che, pur essendo in qualche senso ‘sovrannaturali’, sembrano svolgere un ruolo cruciale nella descrizione/spiegazione della natura. Gli altri due divieti (il 2 e il 3) sono invece di natura chiaramente epistemica: essi riguardano le modalità di conoscenza del mondo naturale e, più in particolare, hanno l’effetto combinato di mettere in dubbio che esista davvero qualche forma di conoscenza che non sia – in forma più o meno mediata – riducibile a una forma di conoscenza puramente scientifica.
In questo percorso di avvicinamento a un nucleo ragionevole di assunzioni comuni ai vari naturalismi, la distinzione che appare come logicamente prioritaria è dunque quella tra un naturalismo ontologico e un naturalismo epistemico (o metodologico). Il naturalismo ontologico si concentra sulle forme di esistenza di ciò che c’è al mondo e prescrive che tali forme possano essere quelle e soltanto quelle contemplate dalla scienza: quest’ultima, cioè, è secondo il naturalismo ontologico l’autentica agenzia che legifera sull’esistenza delle cose del mondo, anzi l’unica agenzia che stabilisce se un’entità indistinta è davvero a tutti gli effetti una cosa. Ciò significa che il naturalismo ontologico si trova a bandire vari tipi di entità ‘sospette’: non soltanto dunque la numerosa fauna di animali concettuali che si incontrano nella tradizione filosofica occidentale – come le forme platoniche, gli universali, l’io cartesiano o i kantiani concetti puri dell’intelletto – ma anche new entry della metafisica analitica contemporanea (un semplice esempio può essere la nozione di disposizione). Soltanto ciò la cui esistenza può essere accertata mediante i metodi empirici della scienza contemporanea ha titolo per essere incluso tra gli effettivi oggetti del mondo, ed è proprio questa assunzione a giustificare il fatto che molto spesso il naturalismo tout court è trattato come sinonimo di naturalismo scientifico.
Una volta stabilito cosa ha diritto di essere considerato un oggetto del mondo e cosa no, si pone però il problema di come è possibile conoscere le entità che hanno avuto il privilegio di rientrare tra ciò che esiste: di questo si occupa il naturalismo epistemico, secondo il quale non esistono problemi specificamente e irriducibilmente filosofici nell’indagine sulla natura della conoscenza. Quest’ultima rappresenterebbe un corpo unico rispetto al quale scienza e filosofia si pongono in sostanziale continuità – tanto di oggetti quanto soprattutto di metodi – dal momento che la filosofia non deve essere vista come un’attività razionale che persegue obiettivi essenzialmente diversi da quelli della scienza, né tantomeno come un’impresa di fondazione ‘ultima’ che dovrebbe sostenere la legittimità conoscitiva dei contenuti della scienza stessa. Come vedremo più in dettaglio nei paragrafi successivi, questo obiettivo di una vera e propria naturalizzazione della conoscenza ha trovato le sue motivazioni originarie soprattutto nelle influenti riflessioni di Willard V.O. Quine e Alvin Goldman: ma prima di addentrarci nelle questioni sollevate da questa prima, pur semplice classificazione, soffermiamoci su quella rivoluzione culturale rappresentata dalla nascita della scienza moderna in Occidente, senza la quale il naturalismo non avrebbe nemmeno ragione d’essere. Torneremo successivamente sulla dicotomia tra ontologia ed epistemologia e sul tipo di relazione che il naturalismo prescrive tra questi due regni.
1.2. La scienza moderna e le origini del naturalismo
Tra gli eventi che maggiormente contribuiscono alla fondazione della modernità occidentale, accanto alle rivoluzioni economiche, politiche, sociali e culturali un posto di rilievo spetta senza dubbio alla cosiddetta «rivoluzione scientifica», almeno nel senso in cui questa ci è oggi familiare, vale a dire quello di una grande impresa collettiva volta tanto alla scoperta delle leggi naturali fondamentali quanto alle loro implicazioni tecnologiche e applicative in generale. Nei centocinquant’anni che dividono il De Revolutionibus Orbium Celestium di Niccolò Copernico (1543) dai Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Isaac Newton (1687), si consolida una visione sempre più unitaria del mondo naturale, attraverso un processo culturale che lo separa in modo irreversibile dalle immagini cosmo-teologiche premoderne. Alcune delle caratteristiche di questo processo hanno un significato filosofico autonomo e particolarmente rilevante per collocare le lontane radici scientifiche di un atteggiamento naturalistico nei confronti della realtà e della conoscenza: si tratta di fondamentali implicazioni che la nascita della scienza moderna determina nella struttura stessa di una razionalità scientifica in senso ampio (cfr. Laudisa, Datteri 2011, cap. 1).
In primo luogo, si sviluppa una diffusa e più marcata disposizione alla modellizzazione e all’astrazione nella descrizione e spiegazione dei processi naturali. Coloro che sarebbero diventati i protagonisti della nascita della scienza moderna misero all’opera ciò che agli occhi di uno scienziato contemporaneo appare un prerequisito minimale dell’indagine scientifica: per comprendere in senso generale un fenomeno, le proprietà che esso soddisfa e le leggi che ne governano il comportamento, è necessario costruire in prima istanza una rappresentazione astratta e idealizzata del fenomeno stesso. Questo rende possibile una migliore integrazione della componente empirica e della componente logica della scienza – che nel passato erano state tenute largamente distinte – e soprattutto un’applicazione sempre più estesa della matematica ai fenomeni naturali: come possiamo ben comprendere oggi, a più di quattro secoli di distanza dalla rivoluzione scientifica, la potenza formale della matematica può dispiegarsi adeguatamente soltanto se applicata a descrizioni semplici e idealizzate dei fenomeni studiati. Si fa strada insomma nella rivoluzione scientifica l’idea che la crescita della nostra comprensione di un determinato fenomeno naturale passi necessariamente attraverso un certo grado di matematizzazione nella descrizione di quel fenomeno e, di conseguenza, attraverso la costruzione di un modello di quel fenomeno: vale a dire una descrizione astratta che preserva – in forma semplificata – solo quelle caratteristiche del fenomeno originario che appaiono più adatte a essere analizzate in forma rigorosa. Ciò implica che, nel tentare di comprendere le basi di un fenomeno naturale mediante un suo modello, gli scienziati dovranno stare attenti non soltanto alle proprietà che considerano importanti (e che saranno presenti nel modello), ma anche a quelle che decideranno di tralasciare e che quindi il modello ignorerà. Una precisazione essenziale, prima di continuare. Alla nascita di ciò che oggi definiamo ‘scienza moderna’ concorrono un gran numero di scienze e indagini particolari, e soltanto per una parte di esse il processo di matematizzazione cui abbiamo appena accennato ebbe un ruolo decisivo: ci furono, in altre parole, svariate discipline che contribuirono in modo essenziale a formare una moderna immagine del mondo e nelle quali la matematica ebbe un ruolo limitato o nullo (Clericuzio 2005). L’esempio più chiaro è naturalmente la rivoluzione darwiniana, in seguito alla quale si sviluppa nelle scienze biologiche un quadro esplicativo destinato a comprendere sotto di sé l’intero complesso dei fenomeni del vivente. Rimane tuttavia il fatto filosoficamente assai significativo che la scienza moderna esce da uno stato di minorità quando comprende che la conoscenza della natura progredisce attraverso strutture ideali, capaci di spiegare i fenomeni concreti proprio come approssimazioni di quelle strutture.
Proprio sullo sfondo del radicale rovesciamento di prospettiva implicito nella rivoluzione scientifica, assume allora un effettivo significato il riferimento alla nuova centralità del concetto di esperimento, una centralità che nel passato è stata sovente intesa come l’elemento di novità quasi esclusivo di tutta la scienza moderna. Non di rado, infatti, numerose presentazioni più o meno divulgative dei caratteri fondamentali della scienza moderna (presentazioni contenute in volumi di larga diffusione, in testi scolastici o in capitoli introduttivi di manuali scientifici di livello universitario) si concentravano sulla presunta scoperta di un enigmatico ‘metodo sperimentale’ come evento messianico dell’era moderna: dalla sera alla mattina, una simile scoperta avrebbe magicamente dato avvio alle magnifiche sorti della conoscenza scientifica del mondo (nonché – secondo certe letture più pessimistiche – al dominio tecnico della scienza sul mondo). In questa visione la scienza moderna prenderebbe avvio in modo pressoché esclusivo dal ricorso crescente all’esperimento nelle indagini naturali, a scapito di una conoscenza ‘libresca’ e puramente teorica ereditata dalla cultura antica.
Questa visione è naturalmente inadeguata, e lo è a vari livelli: essa risulta infatti non soltanto incapace di cogliere in mod...