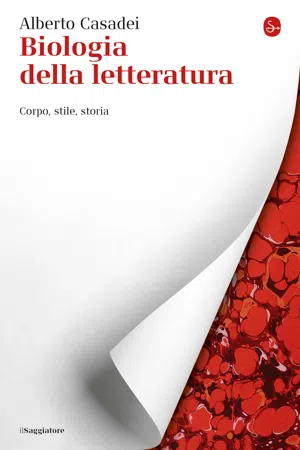![]()
1. Fondamenti biologico-antropologici in campo artistico
Dai pittori nelle grotte agli autori del Gilgameš
1.1. Cominciamo col porre in evidenza quali sono i presupposti biologici attualmente noti che costituiscono con ogni probabilità una base per la creazione artistica e letteraria. Tenendo conto di quanto detto nell’Introduzione, non sarà però possibile ridurre a determinate potenzialità fisiche e in specie neurologiche la complessità di un’opera d’arte: come avviene appunto nei sistemi complessi, in ogni opera convergono numerosi fattori che, presi singolarmente, non contengono le premesse dell’esito al quale poi contribuiscono. In particolare, i processi di simbolizzazione e di codificazione, generati in modi ancora molto discussi, creano comunque sistemi di secondo livello, caratterizzati da una dominante (nel senso formalista-jakobsoniano di «componente essenziale che garantisce l’integrità di un testo»): nel caso delle opere artistiche, questo processo si compie attraverso lo stile (e quindi, storicamente, con le varie stilizzazioni: cfr. Capitolo 2).
Useremo i dati sperimentali e le loro interpretazioni scientifiche più accreditate come coordinate di partenza e non come spiegazioni autoconsistenti. D’altra parte, sono inaccettabili molte ermeneutiche dei fatti artistici successive all’affermazione della totale autonomia delle opere, ritenute in sostanza sistemi semiotici privi di referenzialità: possono essere stati impiegati diversi tipi di formalizzazione, ma resta vero che il mito della coerenza e coesione testuale ha impedito di collegare le opere a un percorso di creazione-inventio complessivo e, in qualche misura, accertabile.
Se consideriamo le attuali analisi neurocognitive e più in generale biologico-antropologiche prescindendo per ora dai singoli dettagli sperimentali, potremo individuare alcune categorie generali utili per ipotizzare possibili campi di intersezione fra presupposti corporei e loro riuso artistico. È opportuno concentrarsi su quelle caratteristiche che sembrano meglio adattarsi a una fisionomia della natura umana inserita in una prospettiva evolutiva e in continua interazione con i vari mondi esterni definibili come ‘realtà’. L’uso di questi termini presuppone alcuni assunti filosofici e teorici cui si è accennato nell’Introduzione e che saranno riproposti in forma problematica al termine di questa indagine (cfr. Capitolo 5); per ora si dovrà prescindere dalle valenze strettamente tecniche, ricavabili dalla bibliografia segnalata, per indicare quelle che consentono un confronto concettuale più ampio.
Le potenzialità biologico-cognitive che emergono con maggiore evidenza dagli studi attuali sul rapporto corpo-cervello-mente sono le seguenti:
a) Attenzione/percezione attimale: si tratta di stadi fondativi del rapporto fra singolo ente e mondi esterni, e riguardano in primo luogo la necessità di cogliere immediatamente la presenza di un’entità estranea, eventualmente (a un certo livello evolutivo) ostile; la facoltà che chiamiamo attenzione può tuttora specializzarsi in modi che contrastano con una razionalità utilitaristica o progettuale, per esempio impedendo al cervello di rendersi conto di un accadimento differente da quello verso cui è orientato: un classico esempio è quello degli esperimenti sulla ‘cecità attenzionale’ (condotti da Daniel J. Simons e altri). Ciò produce la necessità di creare processi di attrazione (usi retorici, straniamento, foregrounding ecc.) che diano luogo a una consapevolezza specifica, e magari sempre più raffinata e complessa; secondo alcune teorie, anche gli aspetti della facoltà che chiamiamo ‘coscienza’ derivano da una progressiva evoluzione e da un’integrazione di questa potenzialità, peraltro fondamentale per la sopravvivenza;
b) Ritmicità/ricorsività: la percezione di una regolarità ritmica è probabilmente connessa alla filogenesi e all’ontogenesi umane, dato che il battito cardiaco percepito costantemente nella sfera prenatale costituisce un importante fattore di scansione, prima non finalizzata (o forse finalizzata implicitamente all’autopercezione dell’esistere, il che contribuirebbe a spiegare le valenze terapeutiche-acquietanti della musica), poi fondamentale nell’organizzazione spaziotemporale; è facile comprendere perché una ritmicità o ricorsività sia quindi ben percepibile tanto a livello sonoro-musicale, quanto in ambiti connessi, a cominciare dal linguaggio; non è attualmente facile capire se la ricerca di regolarità a molti livelli (disposizione dell’Umwelt umana, creazioni estetiche ecc.) sia da connettere a questo stadio o dipenda anche da altri fattori, per esempio l’intrinseca simmetria del corpo umano; come sempre, è possibile pensare a diversi livelli di complessità e a stadi diversi biologico-evolutivi;
c) Mimesi/simulazione incarnata: con questi termini si indicano le capacità corporeo-cerebrali di reagire a stimoli esterni, eventualmente riproducendo in sé sensazioni-emozioni (per esempio dolore, gioia, paura ecc.) provate con evidenza da altri e non dall’individuo osservante. Questa potenzialità, che si estende anche all’osservazione-riproduzione di meri gesti o azioni, è connessa all’esistenza dei cosiddetti neuroni specchio e può produrre forme di empatia o una specifica simulazione corporea (embodied simulation) di accadimenti esterni. Numerosi sono ancora i passaggi da definire prima di poter giungere alla descrizione di un processo scandito ma continuo che parte dalle forme percettive neurali per arrivare alla riproduzione-elaborazione degli stimoli esterni in forme di socialità antropologica e poi in forme (proto)artistiche, eventualmente fruibili in condizioni particolari (‘simulazione liberata’: cfr. Gallese e Guerra 2015, p. 75). È indubbio che l’attenzione attimale deve essere accompagnata da una forma di attenzione più continuativa e semantica, sia per acquisire capacità e competenze, sia per poter ritrasmettere queste ultime a un livello più elevato, semmai in modi simbolici;
d) Blending/metaforizzazione: viene così indicata, in generale, la tendenza biologico-cognitiva a collegare elementi di per sé percepiti in modo autonomo, fondendoli in nuovi campi concettuali; nonché, più specificamente, quella a creare immagini e campi metaforici idonei a designare e a segmentare quanto definiamo reale o immaginario. Queste potenzialità risultano riscontrabili al livello dell’attività cerebrale, nella formazione del pensiero, ma si estrinsecano di certo in ambito linguistico-semiotico: i processi che conducono alla simbolizzazione partendo da condizioni biologiche devono essere ancora precisati, ma il nesso tra sistemi metaforici e situazioni corporee sembra ormai accertato. Questo tipo di propensione, forse ricollegabile al sistema cerebrale della ‘ricerca’ (cfr. Solms e Turnbull 2002, cap. 4), garantisce in ogni caso la non staticità delle relazioni con la sfera dell’Umwelt, i cui stimoli sono ricombinabili per realizzare altro, nel pensiero così come nel concreto, dalle tecniche alle arti (su questi temi, cfr. da ultimo Turner 2014).
Ciascuna di queste propensioni può essere considerata fondativa, anche se la loro ricaduta in ambito evolutivo può essersi verificata in momenti molto distanti nel tempo (cfr. Rose 2005; Ingold 2015). Probabilmente ciascuna di queste potenzialità ha prodotto esiti che rimarranno per sempre ignoti: al di là delle ingegnose ipotesi, le verifiche fattuali possono risalire al massimo ai primi reperti antropologicamente significativi, (databili, per ora circa al 200 000 a.C. e, nel caso delle arti, circa al 40 o 30 000 a.C.). Ma di certo è dalla progressiva collaborazione delle propensioni biologiche fondamentali che nasce una serie di testimonianze che consideriamo proto-artistiche: e lo scatto, come vedremo meglio, è dato dalla possibilità di trovare una loro sintesi attraverso lo stile (cfr. qui più avanti e Capitolo 2).
Dobbiamo però tralasciare parecchie implicazioni che risulterebbero senz’altro interessanti. Per esempio, è chiaro che i presupposti indicati interagiscono con le funzionalità cerebro-corporee nel loro insieme, a cominciare da quelle legate al versante delle emozioni e delle loro ricadute sulla percezione del mondo esterno e interiore (cfr. Damásio 1999, 2010; per un’ampia bibliografia cfr. Burke e Troscianko 2017, pp. 35-53, specie 38-42): non a caso, questo versante può agire anche nell’affermarsi di un’attività protoartistica, per esempio quando una ritmicità semplice viene scandita da gesti corporei e accompagnata dal suono strumentale di una canna bucherellata (sono disponibili resoconti di rituali africani simili). È senz’altro vero che, in molti ambiti letterari, la capacità di suscitare emozioni è considerata essenziale, specialmente da quando il testo scritto è entrato in un circuito che lo pone in collegamento (o in cortocircuito) con opere visive di vario tipo (film, video, serie televisive), nelle quali l’impatto emotivo risulta del tutto predominante. Tuttavia, l’obiettivo di suscitare emozioni, socialmente giustificato, non è di per sé garanzia di un’attività di tipo artistico, se non a un livello semplificato e spesso inconsapevole: semmai esse diventano un elemento di sottolineatura o enfasi quando s’innesca un livello di elaborazione stilistica più alto, che mira a una consapevolezza durevole (e quindi a una memorizzazione). Occorre quindi, come giustamente ha più volte sottolineato Michael Burke (2011, 2013), uno stile che non solo controlli (o esasperi) l’effetto emotivo, ma anche permetta di ricondurlo a un percorso esistenziale e non solo a una percezione attimale: ciò può indurre addirittura a un ripensamento di tipo etico (magari trasgressivo) e quindi alla condizione di ‘vita rivissuta’, secondo l’accezione propria dell’Erlebnis (cfr., anche per una bibliografia a partire da Dilthey, Casadei 2000, 2014, specie pp. 39 ss.), che sembra intrinseca alle grandi opere d’arte.
Inoltre, siamo costretti ad accennare soltanto a molte componenti ‘secondarie’ che potranno essere meglio sceverate a partire dalla combinazione di presupposti come quelli indicati: basti pensare, a livello linguistico, ai fenomeni del fonosimbolismo e al problema dell’iconicità, che rinviano a una percezione integrata mente-corpo (si consideri il celebre esperimento sugli effetti di termini quali ‘kiki’ e ‘bouba’, quasi sempre associati al concetto di acutezza, il primo, e di rotondità-ottusità, il secondo; e si considerino gli effetti di sinestesia e ideastesia indotti appunto dai suoni o anche dalle immagini: Nikolić 2016). In altri casi, resta tuttora sub iudice la valenza fondativa o invece derivata di usi metaforici a formularità spaziale-deittica (cfr. almeno Talmy 2000), che però potrebbero rientrare già in una prima fase di concettualizzazione attraverso il linguaggio della sfera dell’habitat umano. Su queste e su numerose altre potenzialità ‘miste’ si fondano per esempio molti esperimenti poetici soprattutto, ma non esclusivamente, postromantici. Si tratta però, nella prospettiva qui adottata, di casi particolari o non primari, e come tali potranno essere segnalati quando opportuno, ma non saranno oggetto di analisi specifiche.
1.2. Precisiamo intanto alcuni punti. Secondo varie ricostruzioni, fondate soprattutto sugli assunti della linguistica cognitiva, solo l’ultima delle quattro potenzialità sopra indicate vanterebbe un’immediata rilevanza nella costituzione di un’opera letteraria, in particolare per l’uso qualificato di immagini metaforiche. Ma è indubbio che tutte le proprietà biologiche segnalate possono essere coinvolte nella costituzione di un’opera che, nel tempo, definiremo ‘artistica’. Il problema che qui affronteremo sarà quello di individuare almeno gli snodi fondamentali per definire il passaggio dalle mere propensioni alle configurazioni di livello più elevato, in primis simboliche o concettuali.
In ciò probabilmente intervengono molti altri fattori al momento oggetto di indagini. Per esempio, è ancora da definire il ruolo di quegli slittamenti per contiguità che definiamo con termine retorico metonimie. Dopo gli studi di Gilles Fauconnier (1985), se ne conosce la funzione connettiva e si ipotizzano i percorsi neurocerebrali che consentono un’associazione-decodifica relativamente semplice se si dice ‘vela’ al posto di ‘nave’. Tuttavia resta difficile determinare a quale livello di attività cerebrale si collochi il procedimento metonimico: si è sviluppato prima, dopo o assieme all’attività di metaforizzazione? In che rapporto sono queste attività rispetto a quella più generale di blending? A questi dubbi non siamo al momento in grado di rispondere con certezza, ma ciò non toglie che si possa ipotizzare che sia costante nella biologia umana una complessiva propensione ad associare per contiguità immediata oppure per similarità a distanza: tale propensione, nel suo insieme, diventa ‘finalizzata’ (in forme e gradi diversi) quando viene impiegata consciamente o meno per realizzare un’attrazione verso un punto specifico.
Più in generale, una posizione analoga, ossia tesa a ricostruire gradualità/scalarità a vari livelli, anziché algoritmi computazionali, consente di ridurre la gravità del problema delle scarse conoscenze riguardo all’effettivo funzionamento cerebrale che arriva a produrre, per esempio, una metafora. Il passaggio dalla molecola alla metafora, per usare un fortunato titolo di Jerome Feldman (2006), è sicuramente da indagare e probabilmente consentirà precisazioni su vari aspetti, ancor meglio di quanto non si sia riusciti a partire dalle ricerche di Lakoff, Turner e molti altri neuroscienziati e neurolinguisti. Di certo l’integrazione fra elementi eterogenei può arrivare a un grado di complessità tale da costituire una potenzialità non desumibile dai tasselli di partenza, nemmeno conoscendo la loro esatta disposizione in un processo di primo livello. Ciò è particolarmente chiaro quando le metafore sono reimpiegate con una finalizzazione non motivabile superficialmente (su questo torneremo nei capitoli 2 e 3): come ricordava brillantemente Maryanne Wolf (2007), la lettura di un’opera complessa come la Recherche di Proust, o (aggiungiamo) una poesia altamente metaforica di Celan, spinge ad attivare zone cerebrali diverse, addirittura a riplasmare processi sclerotizzati, così come possono farlo, in altri modi, un quadro o un dramma, venendo così pienamente a giustificare la loro valenza conoscitiva-durevole, e non solo quella di produttori di un piacere emotivo-puntuale. Insomma, la migliore conoscenza dei processi strettamente fisiologici aiuterà a precisare la genesi di proprietà di livello superiore, ma è lecito intanto sottoporre queste ultime a una disamina specifica, che dia conto dei loro legami sicuri con le propensioni biologiche.
Si possono formulare ipotesi che giustifichino le priorità di determinati effetti rispetto ad altri: a puro titolo di esempio, il fatto che le metafore fisico-realistiche, del tipo «Dare un calcio alla fortuna», attivino aree cerebrali del movimento, non solo garantisce un’interazione fra talune propensioni diverse sopra indicate (l’embodiment e il blending), ma suggerisce che la situazione descritta dalla metafora non risulti, almeno a livello inconscio, affatto implausibile. Ciò può consentire che un’immagine semanticamente irrealistica venga col tempo implementata nel sistema comunicativo, magari dopo essere stata per un periodo sentita come risultato di un blending. La decodifica degli effetti emotivo-cognitivi del linguaggio figurato, con nuove ipotesi sulle interazioni continue fra i due emisferi cerebrali, è l’obiettivo di numerose ricerche in corso (cfr. almeno Gibbs 2008): qui si privilegerà la riflessione sui processi generatori di quegli effetti, secondo una tipologia di analisi che vorrebbe seguire non tanto le diramazioni della rete di rapporti tra biologia e arti, sino alle giunture più esili (le ricadute soggettive sul versante della fruizione), bensì soprattutto gli addensamenti e gli snodi che consentono di indicare proprietà di vario livello e di delineare gradualità/scalarità specifiche dei vari ambiti.
1.3. Devono ora essere definiti alcuni concetti che saranno impiegati per l’opera di decodifica dello status delle opere artistico-letterarie. Si tratta di concetti-ponte, che nella forma adottata o in altre simili sono presenti in molti ambiti disciplinari, sia pure con accezioni solo in parte sovrapponibili: ma le intersezioni sono sufficienti a garantire un’interfaccia abbastanza precisa in relazione a problemi comuni tra scienze e arti, nella direzione di una possibile consilience che tenga conto dei comuni presupposti biologico-cognitivi, eventualmente interpretati in modo diverso (ora come fenomeni quantificabili e ripetibili, ora come qualia).
In primo luogo va citato il concetto di nucleo di senso, riscontrabile in vari filoni della riflessione linguistica (come «semantic nucleus») e fenomenologica. Già Husserl (1913) si era soffermato sull’idea di senso come noema e nucleo intimo di un atto, e le sue considerazioni sono state riprese da Gilles Deleuze (1969) e in varie opere da Paul Ricoeur, che ha indagato specialmente l’aspetto fondante di un’esperienza soggettiva o di un avvenimento (cfr. Ricoeur 1969, trad. it. pp. 59 ss.). Ma ora è opportuno unire questa concezione con le indagini neurobiologiche che, come già ricordato, ...