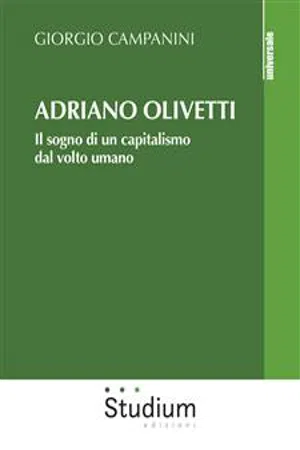
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La figura e l'opera di Adriano Olivetti (1901-1960) costituiscono un momento essenziale della riflessione da tempo in atto in Occidente sul destino della società industriale e sul necessario ritorno ad un rinnovato "umanesimo del lavoro". L'agire pratico e la riflessione teorica di Olivetti su un possibile nuovo "umanesimo della tecnica" possono rappresentare ancora oggi un importante punto di riferimento in vista della costruzione di una "economia dal volto umano".
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Adriano Olivetti di Giorgio Campanini in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Editore
Edizioni Studium S.r.l.Anno
2020Print ISBN
9788838248764eBook ISBN
9788838250194II. La nostalgia della comunità. Olivetti e il progetto del personalismo comunitario
Premessa
Nel panorama della storia delle idee del Novecento, Adriano Olivetti [1] occupa un posto del tutto peculiare in ordine alla elaborazione di una specifica categoria concettuale; quella di comunità [2] . Ciò avviene per una ben precisa ragione, e cioè per il fatto che l’imprenditore piemontese si propone di operare la saldatura tra una tradizione “comunitaria” essenzialmente filosofica e sociologica ed una concreta esperienza “comunitaria” quale è quella della moderna azienda industriale. Ciò che per gran parte del corso della storia delle idee degli anni ’30 era rimasto allo stadio di semplice, e talora astratta, enunciazione ideale, diventava con Olivetti un preciso progetto di comunità, con una sua puntuale articolazione interna (sia pure con alcune componenti ideali ancora “utopiche”, seppure non utopistiche).
È questo ideale percorso, dalla comunità come ideale alla comunità come progetto, che si tenterà di ripercorrere nelle sue linee essenziali, alla ricerca delle sue ultime intenzionalità. Ciò non significa che l’opera teoretica di Olivetti sia riducibile soltanto a questo libro; altre pagine potrebbero e dovrebbero essere richiamate ma esse in realtà rappresentano essenzialmente arricchimenti, integrazioni, sviluppi di questo progetto originario [3] . L’ordine politico della comunità appare la sua opera fondamentale dal punto di vista delle idee politiche. In queste note, dunque, si farà riferimento preferenziale a quest’opera, rinviando alla letteratura specialistica per un’analisi più completa del complesso del pensiero olivettiano [4] .
La riemergenza dell’idea di comunità nella prima metà del Novecento
La riflessione di Olivetti sul concetto di comunità, che trova la sua espressione di sintesi nell’opera pubblicata giusto all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, si colloca all’interno di una generale ripresa di questa categoria di pensiero nella storia delle idee del Novecento a partire dagli anni ’80. Sembrava allora – al culmine di una fase di rapidi mutamenti intervenuti nell’ambito della tecnologia e in ordine ai quali aveva fatto da volano la brusca accelerazione determinata dalla prima guerra mondiale, cioè dalla prima “guerra tecnologica” – che l’impetuoso processo di industrializzazione della società occidentale avesse ormai definitivamente dissolto l’antica rete di rapporti comunitari che aveva caratterizzato l’Europa medievale e che era continuata nell’età moderna, almeno nelle sue ancora significative componenti agricole ed artigianali. Ma, soprattutto all’inizio del Novecento (negli anni della nostalgia della Francia rurale ed eroica descritta e cantata da Charles Péguy), la riflessione sulla comunità aveva avuto il carattere del rimpianto, assai più che della proposta politica, ed aveva assunto essenzialmente la forma della critica, o del radicale rifiuto, della società industriale, piuttosto che di un suo profondo rinnovamento dall’interno.
Vi è stato tuttavia un momento, e cioè gli anni ’30 del Novecento, in cui l’idea di comunità è prepotentemente riemersa, e non a caso, nella cultura dell’occidente; e ciò nonostante la crisi che questa categoria doveva conoscere anche all’interno della tradizione socialista, (sin dalle origini caratterizzata da una forte componente comunitaristica), per effetto della radicale alterazione che dell’idea stessa di comunità era stata fatta dalla rivoluzione “sovietica” e dall’uso distorto delle strutture comunitaristiche, ben presto sacrificate alle esigenze di un’economia rigidamente e centralisticamente pianificata, talché delle reali comunità di lavoro rimaneva soltanto il nome.
La crisi del comunitarismo, e l’uso manipolatorio che di questa categoria veniva fatto dai totalitarismi degli anni ’30, dalla Russia sovietica alla Germania nazista, divenute sinonimo di una rigida pianificazione, sino all’Italia fascista, nella quale il corporativismo risultò il camuffamento dello spirito comunitario, determinò negli anni ’30 la riemergenza di una categoria che sembrava essere diventata ormai periferica rispetto al corso delle idee politiche dell’occidente.
Al di là di una motivazione in un certo senso contingente – la riproposizione fuori dell’area di lingua tedesca della fondamentale opera di Ferdinand Toennies, Comunità e società [5] – le ragioni di questo ritorno sono essenzialmente due.
In primo luogo va segnalato il disagio che negli ambienti intellettuali si avverte in quegli anni di fronte alla radicale distorsione del concetto di comunità operato dai regimi totalitari: kolkohz e soviets appaiono ai più avvertiti osservatori come un vero e proprio tradimento dell’antica tradizione comunitaristica russa [6] e tali appaiono anche le “comunità di lavoro” realizzate dalla Germania nazista in un contesto di accentuato ed esasperato centralismo.
Se gli inizi dell’esperimento corporativo di Mussolini suscitarono qualche illusione [7] , ben presto apparve chiaro che il corporativismo quale era stato concretamente attuato dai regimi autoritari nulla aveva a che spartire con lo spirito comunitario. Ma proprio per questo i più convinti assertori dell’idea di comunità avvertivano l’esigenza di riproporne il volto genuino contro le deformazioni operate dai totalitarismi.
In secondo luogo, ed in parallelo con la segnalata crisi dell’idea di comunità, va sottolineata l’ulteriore accelerazione tecnologica che l’occidente europeo conosce negli anni ’30, anche in relazione alla fine del disarmo e all’avvio di una lunga stagione di preparazione ad una guerra che (è generale convinzione) sarà disputata e vinta essenzialmente sul terreno della tecnologia. In questo processo di accelerazione tecnologica i regimi autoritari – indifferenti alle condizioni di vita dei lavoratori ed al riparo da scioperi ed agitazioni sociali – appaiono relativamente più avvantaggiati rispetto ai regimi liberali, in seguito tuttavia essi stessi costretti dalla logica inesorabile dell’economia di guerra a porre l’accento sullo sviluppo tecnologico e a lasciare in ombra il fattore umano della produzione. Così, anche nei regimi democratici, il processo di modernizzazione si sposa spesso con l’emarginazione culturale e sociale degli operai. Memorabili le pagine di Simone Weil sulla condizione operaia [8] , drammatico documento di questa nuova stagione di estraniazione e di alienazione della classe operaia. Ed anche Weil, non a caso, resta uno dei punti di riferimento dello stesso Olivetti.
Questo insieme di riflessioni – che ha come epicentro la Francia, la quale del resto rappresenta il punto di riferimento per gli intellettuali italiani di area democratica, data la distanza culturale dai paesi anglo-sassoni e dopo la svolta autoritaria della Germania nazista – ha in comune da un lato l’acuta consapevolezza della crisi, dall’altro la sempre più diffusa convinzione che solo un ritorno allo spirito comunitario può salvare l’Europa dalla nuova barbarie che si annunzia.
Si situa, in questo contesto, la diffusa ripresa del tema umanistico, di cui documento emblematico è uno dei testi fondamentali degli anni ’30, Humanisme intégral: questo “umanesimo integrale” [9] è chiamato a riscoprire un’autentica dimensione comunitaria, oscurata dal falso umanesimo dei paesi totalitari, ma nello stesso tempo messa a dura prova, negli stessi paesi democratici, dall’acritica assunzione del modello della società tecnologica, di cui vengono messe in evidenza le potenziali componenti anti-umanistiche.
Di qui un insieme di proposte volte tutte al superamento della duplice crisi dell’occidente – tanto di quello totalitario quanto di quello rimasto democratico – in una prospettiva volta a riproporre, contro ogni nostalgia ruralistica e dunque senza ipotizzare un antistorico ritorno al passato, il grande tema della comunità. Non è un caso che il comunitarismo sia lo sfondo sul quale si collocano le varie ipotesi di “rifondazione” della civiltà occidentale. La stessa proposta di Olivetti si situa al crocevia di questo dibattito e intende rappresentarne una ripresa, dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale, nei nuovi scenari che si aprono all’indomani della fine del conflitto alla cultura ed all’economia dell’occidente.
Le fonti del “comunitarismo” di Olivetti
La sfida rappresentata dal particolare contesto storico degli anni fra il 1943 e il 1945 – degli anni, cioè, della crisi e della fine dei totalitarismi – rappresenta il contesto generale all’interno del quale si colloca la proposta olivettiana. L’ordine politico delle comunità può essere letto, in questa prospettiva, come uno dei numerosi “manifesti” che, nella fase terminale della guerra e all’indomani della sua conclusione, vengono alla luce nell’intento di costruire su nuove e più solide basi la nuova Europa [10] .
Dello specifico “manifesto” olivettiano non è facile ricostruire l’insieme delle fonti, che restano spesso implicite (poche, infatti, le citazioni dirette). Si possono tuttavia individuare tre grandi filoni di pensiero ai quali, direttamente o indirettamente, L’ordine politico delle comunità si ispira.
Il primo filone è rappresentato dalla tradizione socialista, tanto nella sua versione inglese [11] quanto nella sua reinterpretazione francese [12] . Proprio negli anni ’20 e ’30, infatti, alla luce dei risultati solo in parte positivi sul piano economico e terribilmente distruttivi sul piano delle libertà democratiche dell’esperimento sovietico, e cioè della prima e grande esperienza di “socialismo riuscito”, si opera, all’interno della tradizione socialista, una profonda revisione del classico principio della socializzazione dei mezzi di produzione (od almeno della grande impresa).
Questa posizione di pensiero, ricorrentemente bollata di “revisionismo” dal marxismo dogmatico, si afferma progressivamente in Europa e darà luogo all’emergenza, nel secondo dopoguerra, delle socialdemocrazie e al progressivo arretramento, sin quasi all’estinzione, dei partiti comunisti.
In questa linea latamente “socialdemocratica” si colloca anche Olivetti, con una particolare attenzione alla componente prettamente “umanistica” del progetto socialista di riorganizzazione generale dell’economia. Si giustifica, in questa prospettiva, anche la precoce attenzione accordata al pensiero di Simone Weil [13] ed insieme la diffidenza di Olivetti verso due “classici” della tradizione socialista di lingua francese (alla quale pure, per altri versi, è assai vicino), e cioè P.J. Proudhon e Ch. Péguy [14] .
Il secondo punto di riferimento è costituito dalla tradizione liberal-democratica, tanto nella sua versione filosofica (Benedetto Croce) quanto nella sua espressione propriamente politica, nella linea che va da A. de Tocqueville – non a caso uno degli autori maggiormente richiamati in L’ordine politico delle comunità – al pensiero anglosassone degli anni ’30 e ’40. Critico del liberalismo ottocentesco, per l’insufficiente attenzione da questo accordata al problema della giustizia sociale, Olivetti riconosce tuttavia (e non poteva non essere così, nel 1945, dopo oltre vent’anni di dittatura fascista) il valore fondante della libertà; né, d’altra parte, mette mai in discussione il principio della libertà di mercato, pur nella consapevolezza che esso va tutelato ed orientato, in vista dell’armonizzazione degli interessi di una libera economia con quelli generali della società. Più che a specifiche letture, Olivetti mostra, nella trattazione di questi temi, di fare riferimento soprattutto alla sua esperienza e competenza di imprenditore e di profondo conoscitore dei meccanismi dell’economia di mercato.
Su un altro versante, l’esperienza del migliore liberalismo (soprattutto di quello di Tocqueville) si ritrova in Olivetti, cioè sotto il profilo dell’elevato apprezzamento e della forte valorizzazione delle autonomie locali. Anche sotto questo aspetto l’America, ancora un poco “tocquevilliana” dalle autonomie, del federalismo, dei pluralismi, appare ad Olivetti esemplare [15] .
La terza e più importante fonte del particolare “comunitarismo” di Olivetti è tuttavia rappresentata, per pressoché generale consenso, dal personalismo comunitario francese. Non a caso, quasi in apertura della sua fondamentale opera politica, Olivetti affermava (con evidente riferimento alla propria evoluzione intellettuale) che «il pensiero politico contemporaneo è grandemente debitore a scrittori come Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Denis de Rougemont per il loro sforzo di portare la Persona e le comunità differenziate in cui si esprime la società umana» [16] .
Di questi tre autori quello che sembra avere più direttamente ed incisivamente influenzato Olivetti è Mounier, del cui personalismo lo stesso “Movimento di Comunità” puo’ essere considerato una ripresa e un tentativo di attualizzazione.
Al di là del citato riconoscimento iniziale, né Maritain né Mounier vengono poi utilizzati nella stesura de L’ordine politico delle comunità; ma la frequentazione dell’opera mounieriana appare ricorrente, e ...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Adriano Olivetti
- Indice dei contenuti
- Premessa
- Introduzione. Adriano Olivetti e il sogno comunitario
- I. Olivetti nei percorsi storici del comunitarismo
- II. La nostalgia della comunità. Olivetti e il progetto del personalismo comunitario
- III. Olivetti e i nuovi orizzonti della rappresentanza politica
- IV. Per un nuovo modello di economia
- Conclusione. Un autentico umanesimo del lavoro
- Note per una biografia
- Indice dei nomi
- UNIVERSALE STUDIUM