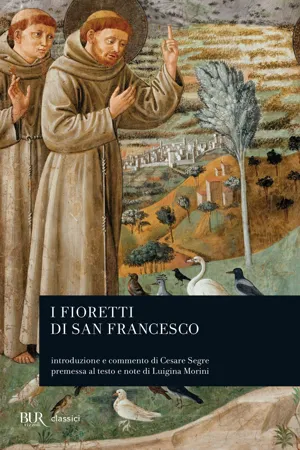INTRODUZIONE
Forse perché si chiamava Leone, come il compagno di Francesco, Tolstoi si vede apparire al fianco un poverello che gli espone, in versi, gli ammonimenti del fioretto VIII sulla perfetta letizia; con la stessa compagnia incontra un lupo, quello di Gubbio, ed è spettatore della predica agli uccelli. Tra zirli di tordi e trilli di quaglie, miti vacche e giumente baie, Tolstoi, messo in marcia da ammonimenti evangelici, ha anche il piacere d’incontrarsi con Dante e Matelda, e poi col corsaro della Pampa, Garibaldi. La scombinata invenzione è del Pascoli («Tolstoi»), che negli stessi Poemi italici fa apparire a Paolo Uccello, anzi Pavlo Vcello, un san Francesco che lo esorta alla povertà, chiamandolo «cattivello» e additandogli a esempio la «sirocchia lodoletta». Tutto il poemetto, a partire dalle didascalie in linguaggio trecentesco, è un pastiche di reminiscenze francescane.
Questo francescanesimo misticheggiante ed evangelico può assumere casalinghe perversità decadentistiche («Anche vidi la carne di Francesco, / affocata dal dèmone carnale, / sanguinar su le spine delle rose», Le laudi; «Assisi») in un D’Annunzio che amava confondere porziuncole e ritiri amorosi, saio e vestaglia, ed esprimeva con dei «Laudato sii...» i suoi afflati panici. Se nella Pisanella egli rimaneggia le Laudi delle creature, al popolo di Fiume, durante la spedizione di Zara, declama il 15 novembre 1919: «Lo spettacolo di ieri fu un miracolo. Quando san Francesco e santa Chiara s’incontrarono a colloquio, la leggenda [cioè Fioretti XV] racconta che tutta l’Umbria vide il luogo ardere e risplendere di lontano. Jeri tutta la Dalmazia, certo, vide Zara ardere e risplendere». Non solo. D’Annunzio progettò un dramma su san Francesco, e annunciava dei «nuovi fioretti» nell’indice dell’Opera omnia del 1927.
Episodi di questo genere se ne potrebbero raccogliere in abbondanza: ne verrebbe, tenendo anche conto del lato figurativo, tra preraffaellismo e liberty, la storia di un curioso revival che, forse partendo dall’Ozanam dei Poëtes franciscains (1852), e giù giù sino a Jørgensen, attraversa, assumendo nuove patine, tardo romanticismo, decadentismo e modernismo (fu modernista uno dei più «ispirati» «biografi» di Francesco, il Sabatier; la fermata ai luoghi francescani è del resto di prammatica anche per Il santo di Fogazzaro), si estende in un’Europa che va dalla Spagna di Valle Inclán alla Francia di Francis Jammes al Belgio, per non parlare di misticismi più boreali, affratella cattolici e protestanti, credenti e agnostici.
La fortuna dei Fioretti (incessante, come dice il numero delle edizioni) aveva precedentemente mantenuto livelli più discreti. Se qualcuno vi cercava «le più eleganti e leggiadre forme del dir toscano», «la purezza de’ vocaboli e l’evidenza e grazia delle frasi», insieme però con «una cara e soave poesia che l’animo dolcemente accende all’amor de’ prossimi e di Dio» (Puoti), c’era chi, come il Foscolo nelle note al Viaggio sentimentale, mostrava di coglierne l’affabulazione. Il De Sanctis teneva un maggior distacco e, accomunandoli imprudentemente («il più amabile e caro di questi libri fanciulleschi») con le opere di Cavalca, Passavanti, ecc., parlava di autori che «hanno l’ingenuità di un fanciullo che sta con gli occhi aperti a sentire, e più i fatti sono straordinari e maravigliosi, più tende l’orecchio e tutto si beve». Non è ingenuo però il critico, quando getta là l’idea che in un autore come questi «l’affetto è tanto più vivace e impetuoso e lirico, quanto la sua vita è più astinente e compressa; quasi vendetta della natura, che grida più alto, dove ha più contrasto».
Anche le interpretazioni più tendenziose ci hanno comunque scoperto qualcosa delle potenzialità dei Fioretti: dobbiamo far tesoro del plusvalore semantico pur respingendo con garbo le armoniche surrettizie. Del resto, non è tanto per loro intrinseca robustezza che i Fioretti hanno retto all’aggressione di tante letture: è grazie all’appartenenza (in posizione, a ben guardare, periferica) alla ricca e varia produzione di scritti francescani. In questa produzione i Fioretti stanno a una data piuttosto bassa (fra 1370 e 1390), né hanno altra autorità che quella attribuibile agli Actus beati Francisci (a cavallo fra XIII e XIV secolo), di cui sono, com’è venuto apparendo sempre più chiaramente, un volgarizzamento tutt’altro che libero.
Tuttavia chi decise di riproporre in volgare toscano un’opera che, in latino, avrebbe potuto circolare solo tra i confratelli, e nemmeno fra tutti, produsse una spinta decisiva per la sua fortuna, perché offrì alla gente del mondo questi quadri della vita di san Francesco e dei suoi primi seguaci, e istituì un modello di letteratura edificante, molto diverso da quelli in circolazione, che presto fu seguito da uno sciame di testi affini. Anche noi qui parleremo dei Fioretti senza sviluppare un raffronto con gli Actus, che metterebbe i primi quasi completamente nell’ombra dei secondi.
I Fioretti sono una serie di episodi della vita di san Francesco e dei suoi compagni, oltre che di frati della «seconda generazione». L’ambiente, umbro all’inizio, è prevalentemente marchigiano a partire dal fioretto XLII: è possibile che lo spostamento del punto di vista corrisponda a fasi redazionali della fonte. L’andamento non è biografico, sicché mancano episodi anche tra i più significativi della vita del santo, e la successione degli avvenimenti non è cronologica. La struttura proposta nel fioretto I è quella dell’«imitazione di Cristo»: di cui si riscontrano tracce in molti fioretti: VII, XIII, XXV, ecc. Tuttavia neanche questa pare determinante. Sola partizione netta è quella tra i fioretti in cui opera, o comunque risulta ancor vivo san Francesco (I-XXXVIII), e quelli che narrano fatti occorsi dopo la sua morte (XXXIX-LIII): essa è pressoché coincidente con la partizione geografica appena ricordata, dato che i fioretti XXXIX-XLI costituiscono una zona a sé, consacrata a sant’Antonio e a frate Simone.
La prospettiva umilmente provinciale si apre spesso per balzi in regioni lontane: Santiago di Compostela (IV), la Francia, Roma (XIII), persino Babilonia (l’Egitto) col suo Soldano (XXIV); frequenti le menzioni di Bologna (V, XXVII). Ma invano si cercherà qualunque notazione ambientale: il santo e i suoi frati sono tutti chiusi nella loro interiorità, e il cambiamento di scenario vuol essere soltanto un allargamento dell’impegno di predicazione e di proselitismo.
Potremmo parlare di introversione. La cerchia quasi autonoma degli scambi di idee e dei contatti umani è quella dei confratelli; tutti gli altri sono un esterno da edificare e, se possibile, convertire alla penitenza. È questa una delle differenze più vistose tra i Fioretti e le novelle di altri autori religiosi dell’epoca, come il Passavanti e il Cavalca (domenicani): in queste novelle, o meglio exempla, appare di scorcio tutta la vita civile, formazioni sociali, rapporti quotidiani, situazioni familiari. Questi exempla mostrano all’opera, tra gli uomini e le loro brighe, i rappresentanti della divinità, le offerte di salvazione.
Nei Fioretti la santità è a portata di mano, o già attiva nei protagonisti: visioni e sogni rivelatori, conversazioni con le ipostasi del divino sono un atto quotidiano; gli angeli bussano alle porte dei conventi e solo dei distratti possono non riconoscerli. Chi non è santo è aspirante santo e, in genere, futuro santo. Per portarsi nell’area di questa perfezione non bastano le virtù dei normali cataloghi, ma occorre una conversione eroica, un cambiamento radicale di vita.
Per tutto questo non direi che i fioretti siano degli exempla. Essi svolgono un discorso più complesso, a doppio destinatario. C’è un discorso ai confratelli, per i quali davvero si può puntare sull’esemplarità (sia pure l’esemplarità di un limite più vagheggiabile che raggiungibile). Entro il discorso ai confratelli può anche inserirsi una presa di posizione confessionale, dal momento che i Fioretti sembrano propugnare le posizioni degli Spirituali contro quelle dei Conventuali (cioè quelle ascetiche e pauperistiche contro quelle più gerarchizzanti e moderate: molto chiaro in questo senso il fioretto XXXVI). C’è poi un discorso ai lettori laici, che se eccezionalmente possono precipitarsi verso la santità, in ogni caso, saranno «consolati di letizia spirituale», come si dice più volte. Ai lettori insomma deve succedere come agli assisiati accorsi a spegnere quello che credevano un incendio, ed era invece «il fuoco del divino amore» acceso dalla vicinanza di san Francesco e di santa Chiara: essi «si partirono con grande consolazione nei cuori loro e con santa edificazione» (XV).
I Fioretti sono dunque un libro di letture devote, un breviario o una leggenda aurea per laici. Non ingiustificatamente, i compilatori possono aver contato sugli effetti beatifici, sulle suggestioni di serena, lieta perfezione, operate da questo paradiso terrestre messo in opera e tenuto in ordine dalla purezza e altezza di intendimenti del Santo e dei suoi fraticelli. Se non si offre un agevole modello, si suggerisce, e si colora delle tinte più vivaci, un paradigma.
Riportare i Fioretti al corpus della letteratura francescana non vuol dire solo inserirli nel loro contesto storico e teoretico, ma rendere evidente l’inevitabile potatura operata su molti aspetti innovatori della predicazione di san Francesco. All’epoca degli Actus, e...