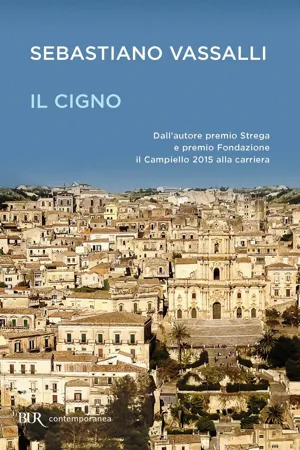![]()
Scena seconda
Purgatorio (1896-1899)
![]()
1
Palermo, 25 ottobre 1896
Filicetta piangeva. Da mezz’ora, forse addirittura da un’ora, se ne stava rannicchiata in un angolo del divano con il viso nascosto nell’incavo del braccio, e piangendo provava un senso di sollievo, di cui lei stessa non avrebbe saputo darsi ragione. Non piangeva per un motivo preciso. Lo spavento che aveva provato poc’anzi, quando aveva aperto la porta di casa e si era trovata di fronte una persona che non avrebbe voluto rivedere, né in quel luogo né altrove, Filicetta ormai non lo ricordava più; e così anche si erano dileguati, nella sua memoria, i ricordi che la vista di quell’uomo era bastata a evocare, e che per un istante l’avevano assalita con la forza delle sensazioni fisiche. Piangeva l’infanzia e l’adolescenza di una ragazza di campagna che per caso si era trovata coinvolta nei tumulti dei Fasci e che poi aveva cessato di esistere, perché era diventata un’altra persona. Piangeva il passato di quella Filicetta che non era più lei: il marito morto, i figli Saro e Nuzzu che ora stavano con i nonni, i parenti, le amiche, i conoscenti d’un tempo. Piangeva il paese sotto la rupe, e le montagne dov’era vissuta la ragazza che per vent’anni aveva portato il suo nome…
Filicetta, ora, era una donna di città, nel suo appartamentino al terzo piano di via dei Biscottari, con la gabbia dei pappagallini sul balcone ed il vaso di basilico davanti all’ingresso; ma la trasformazione aveva richiesto del tempo. Era arrivata a Palermo una mattina di gennaio d’un anno che ormai le sembrava lontanissimo, il 1894, battendo i denti per il freddo e per la febbre causata dalla ferita alla spalla, e aveva dovuto nascondersi in casa di due anziani coniugi, due «compagni» che si erano offerti spontaneamente di ospitarla perché il suo nome figurava tra quelli degli insorti che il generale Morra faceva cercare in tutta l’isola, e che venivano processati dalle Corti marziali. Quelle brave persone l’avevano accolta come se fosse stata una loro figlia; e soltanto dopo molti mesi, quando lei era guarita e la situazione, a Palermo, aveva incominciato a normalizzarsi, le avevano consigliato di rivolgersi all’onorevole Raffaele Palizzolo, deputato del quartiere palermitano dell’Albergaria, per chiedergli di aiutarla a chiarire la sua posizione di fronte alla giustizia. «Palizzolo» le avevano detto i suoi benefattori «è un politico molto vicino all’attuale presidente del consiglio Francesco Crispi, ed è anche un grandissimo mafioso e amico di mafiosi; ma se ti riesce d’impietosirlo, è l’unica persona a Palermo che può davvero tirarti fuori da questo guaio!» L’onorevole riceveva i postulanti nella sede del suo «Comitato elettorale», che era un ufficio a pianoterra in piazza del Carmine; Filicetta c’era andata, s’era messa in fila con gli altri e quando era venuto il suo turno d’essere sentita dal grand’uomo gli aveva raccontato tutte le sue disgrazie, dalla morte di Saro fino alle miserie presenti: lei non poteva continuare – gli aveva detto piangendo – a vivere in quel modo, nascondendosi e facendosi mantenere da due vecchi che avevano a malapena di che mantenere se stessi, e che rischiavano di finire in prigione per causa sua! Era un giorno molto caldo di fine giugno e Palizzolo aveva ascoltato Filicetta senza mai interromperla, corrugando di tanto in tanto la fronte e guardandole con insistenza un punto della camicia all’altezza del seno, dove lei continuava a prendere e a rimettere il fazzolettino con cui si asciugava le lacrime. La ragazza naturalmente non ne aveva colpa, ma madre natura l’aveva dotata di due grandi poppe che l’onorevole contemplava incantato, e di un viso dai lineamenti dolci e regolari, con gli occhi neri come i capelli. Quando poi lei aveva finito di raccontare la sua storia ed era rimasta a guardarlo con gli occhi pieni di lacrime, il Cigno aveva fatto segno di sì per due o tre volte, con il viso e con tutta la persona; s’era arrotolato le punte dei baffi tra le dita e le aveva subito assicurato il suo interessamento, le aveva dato ragione senza mezzi termini. «Non è giusto» aveva detto con forza, alzando il dito, «che una signora così giovane e così bella debba soffrire per causa di un equivoco, e di una colpa che non ha commesso!» Aveva preso nota del nome e del cognome di Filicetta e anche dell’indirizzo di chi la ospitava, per poterla rintracciare non appena avesse avuto qualcosa da comunicarle. Si era alzato per accompagnarla alla porta e soltanto allora Filicetta si era resa conto che il grand’uomo, in realtà, era un uomo molto piccolo, più piccolo di lei di una mezza spanna. Sulla soglia si era inchinato; le aveva preso la mano e l’aveva tenuta a lungo premuta contro le labbra, mentre gli occhi guardavano in viso la ragazza, in un certo modo che doveva significare: «Stai tranquilla! Le tue sofferenze sono finite, perché adesso ci penso io a toglierti dai guai!».
La mattina del giorno successivo, erano trascorse poche ore da quel primo incontro e si era presentata in casa dei coniugi che ospitavano Filicetta una gna Ancila, decana di tutte le mezzane dell’Albergaria, che aveva esordito dicendo alla ragazza: «Beata te! Ti è capitata una grande fortuna, cocca mia, e se non saprai approfittarne sarai proprio stupida!». E poi le aveva spiegato che «sua eccellenza» l’onorevole («Un uomo d’oro, Filicetta: dai retta a me che lo conosco fino da quando portava i calzoni corti! Uno che gli basta dire una parola, a Palermo e a Roma, e ottiene tutto quello che vuole!») avrebbe parlato del suo caso al generale Morra non appena gli fosse stato possibile, ma che intanto era rimasto abbagliato dai suoi occhi, e non era giusto che lei lo lasciasse spasimare mentre poteva fare la felicità di entrambi! L’onorevole – aveva detto la gna Ancila – era fatto così: a quarantacinque anni si innamorava ancora come un ragazzino, e l’avrebbe aspettata quella sera stessa, alle nove in punto, nel «Comitato elettorale» di piazza del Carmine. Non le prometteva né gioielli né soldi, perché sapeva di avere a che fare con una donna onesta e non voleva rischiare di offenderla; ma lei, Ancila, poteva garantirle che se fosse andata all’appuntamento non se ne sarebbe pentita. Che aspettava a mostrarsi allegra e a ringraziare il cielo di averle mandato una simile fortuna? Filicetta, mentre la gna Ancila le parlava, era rimasta imbambolata a guardarla e la mezzana allora l’aveva ammonita: «Stai attenta a quello che fai e non essere stupida, perché la fortuna, dal cielo, scende solo una volta!» («Na vota scinni fortuna di lu celu!»).
La ragazza era rimasta seduta tutto il pomeriggio nella parte in ombra del cortile d’una casa di poveri, a guardare i bambini che giocavano a nascondersi, a chi sta sotto e a morsi Sanzuni («morì Sansone»), e a domandarsi: “Devo andare? Cosa devo fare?”; ma dentro di sé già sapeva che sarebbe andata all’appuntamento con l’onorevole, perché era stanca di farsi mantenere da persone che accettavano di dividere con lei la loro miseria per amore d’un ideale – il socialismo – in cui lei non credeva più; era stanca di continuare a nascondersi e di dover vivere nel timore di essere processata e condannata a dieci o a vent’anni di carcere… Che cosa aveva ancora da perdere, una come lei? La sua vita onesta, i suoi sogni, il suo decoro erano morti lassù, davanti al municipio di quel paese dove non poteva tornare perché sarebbe stata arrestata, ma dove, soprattutto, non desiderava tornare! (Per la prima volta dopo la morte del marito Filicetta si rendeva conto che qualcosa, in lei, era definitivamente cambiato, e che non sarebbe ritornata a Marineo nemmeno per i figli. Inoltre – ed era questo, forse, ciò che più la stupiva di quei suoi strani e riprovevoli pensieri – la prospettiva di diventare l’amante di un uomo ricco e autorevole non le ispirava tutta quella ripugnanza che avrebbe dovuto ispirarle, anzi a dire il vero le appariva come l’unica via d’uscita da una situazione che altrimenti avrebbe potuto diventare veramente drammatica… Una fortuna, proprio come le aveva detto la gna Ancila! In quanto a Palizzolo, le sembrava un omino buffo e abbastanza innocuo, con la sua faccina rotonda, la sua pancia e la sua voce in bemì, cioè in falsetto: forse, aveva pensato quel giorno la ragazza, andare a letto con un ominicchio come quello era un atto di carità, più che un vero peccato…) Quando poi il sole aveva incominciato a declinare, Filicetta si era vestita come meglio le era stato possibile e di vicolo in vicolo, per evitare i soldati che avrebbero potuto fermarla e chiederle chi fosse, dalla Porta Carini era scesa fino in piazza del Carmine. L’onorevole l’attendeva in vestaglia e l’aveva fatta entrare in un salotto accanto al suo ufficio, dove di tanto in tanto riceveva qualche visita femminile e dove anche aveva predisposto tutto il necessario per accogliere lei. C’erano un vassoio pieno di paste e di biscotti in bella vista sopra un tavolino, una bottiglia di champagne dentro un secchio di ghiaccio, e, in un angolo della stanza, un incensiere acceso. Guardandosi attorno, la ragazza si era accorta che il Crocifisso alla parete e due piccoli quadri – forse immagini di Santi o fotografie di defunti – erano stati ricoperti con dei fazzoletti perché non potessero assistere alle umane debolezze dell’onorevole, e ne aveva tratto conferma alla sua idea che Palizzolo fosse un bigotto e un ominicchio, più noioso che pericoloso. S’era seduta davanti alle paste, che in quella circostanza e in quel luogo erano l’unica cosa che potessero rincuorarla; e mentre il Cigno si saziava e la saziava di chiacchiere, aveva vuotato il vassoio praticamente da sola, fino all’ultima pasta e all’ultimo biscotto. Anche lo champagne l’aveva aiutata a stare bene, e a sentirsi in pace con se stessa e col mondo. Per la prima volta dopo mesi di stenti aveva provato in tutte le sue membra il torpore della sazietà e aveva pensato che se il vizio dava sensazioni di quel genere, era di gran lunga preferibile a qualsiasi virtù. Quando poi Palizzolo si era spogliato e le era venuto addosso, Filicetta aveva dovuto sforzarsi per non ridere: l’omettino, infatti, era roseo e rotondo come un porcellino da latte, e s’era attaccato alle sue poppe; aveva voluto essere allattato e tenuto in grembo, aveva voluto perfino essere sculacciato… Il maggior timore della ragazza, prima di andare a quell’appuntamento con uno sconosciuto, era stato di dover provare repulsione quando lui l’avrebbe toccata, ma era rimasta indifferente: a stomaco pieno – così, almeno, le era sembrato quella prima volta – poteva farsi toccare da chiunque, senza troppi problemi. Alla fine, il Cigno s’era addormentato succhiandole un capezzolo e la mattina del giorno successivo le aveva dato cento lire e un nuovo appuntamento per la sera di sabato. Le aveva detto che il suo seno era più luminoso della Via Lattea e le aveva chiesto, anzi: le aveva ordinato, di non parlare di quei loro incontri con nessuno al mondo…
Da quel giorno, Palizzolo non aveva più saputo rinunciare alle poppe di Filicetta e tutto il resto era venuto da sé, nel breve volgere d’un’estate: l’appartamento con il vaso di basilico e i pappagallini, i vestiti di seta, i cappelli e le borsette e la biancheria intima da venticinque e anche da trentacinque lire il capo, che arrivava da Parigi e la vendeva un solo negozio in tutta Palermo, o, forse, in tutta la Sicilia: il Cigno, però, era un appassionato di biancheria intima per signora e Filicetta non aveva difficoltà ad accontentarlo, visto che era lui che pagava! Aveva anche un’altra stranezza, l’onorevole, e la ragazza se ne era resa conto quando aveva incominciato a declamarle certe poesie che diceva di avere scritto apposta per lei e che non si capiva nemmeno di cosa parlassero, tanto erano infarcite di parole che nessuno usava: ma guai a mostrarsi annoiati o infastiditi! Palizzolo, come poeta, era implacabile e bisognava ascoltare le sue tiritere fingendo d’esserne entusiasti, altrimenti metteva il broncio e non si faceva più vedere per molti giorni; a parte questo, però, e a parte la mania di succhiare le poppe delle donne, sembrava un essere assolutamente innocuo, incapace di fare del male perfino a una mosca. Con Filicetta era molto gentile; le dava dei soldi ogni volta che veniva a trovarla, e le portava anche dei piccoli regali: un’immagine della Madonna del Carmelo dentro una cornice d’argento, una scatola di fazzolettini di seta, un vassoio di paste…
Questa dunque era stata la prima svolta nella vita di Filicetta e poi, una sera d’ottobre di quell’anno 1894 in cui lei era diventata un’altra persona, il Cigno le aveva messo cento lire sul tavolo di cucina ma le aveva anche detto che non avrebbe potuto continuare a mantenerla come stava facendo, per lo meno da solo. I suoi impegni di parlamentare – le aveva spiegato – lo costringevano a vivere a Roma una parte dell’anno e Filicetta, durante le sue assenze, doveva adattarsi a ricevere qualche altro uomo: qualche buon amico, che per farsi riconoscere alla porta le avrebbe detto «mi manda l’onorevole» e l’avrebbe trattata con lo stesso riguardo e la stessa generosità con cui la trattava lui, perché gli amici di Palizzolo erano tutti uomini d’onore… Mentre il Cigno parlava, Filicetta aveva pensato che la sua condizione agli occhi del mondo stava per subire un nuovo cambiamento, da mantenuta a puttana, e aveva anche provato paura, si era chiesta: “Con che razza di gente avrò a che fare? Cosa mi succederà?”. Ma ormai era arrivata fino a quel punto e se si fosse tirata indietro avrebbe perso tutto: la casa, la protezione dell’onorevole, il benessere… «Naturalmente» le aveva detto il Cigno «anch’io verrò a trovarti ogni volta che ritornerò a Palermo; anzi in quei giorni dovrai essere soltanto a mia disposizione, perché non intendo dividerti con nessuno e se permetto ad altri uomini d’incontrarti mentre sono via lo faccio solo per te, che resteresti a corto di soldi o ti annoieresti e finiresti comunque per tradirmi.» E poi, prima di partire, le aveva ripetuto ancora una volta quelle storie che le ripeteva sempre e di cui anche si serviva per scrivere le sue poesie: delle antiche sacerdotesse dell’Amore che custodivano il fuoco sacro, delle sue poppe che risplendevano più della luna e del sole, della maga Circe che trasformava gli uomini in porci, delle Ninfe e dei Satiri e di Frine, che aveva abbagliato i giudici con la sua nudità…
Erano arrivati i nuovi clienti. Un ex deputato, un agente di Borsa, due avvocati, un fratello del Cigno, un commerciante e altri due uomini taciturni di cui Filicetta avrebbe saputo dire soltanto che erano uomini d’onore, cioè mafiosi, costituivano la clientela abituale; e poi, di tanto in tanto, c’erano gli sconosciuti che bussavano di notte e dicevano «mi manda l’onorevole»… Con loro, Filicetta era diventata una vera puttana, e la faccenda era stata così normale, così facile, che lei stessa ne era rimasta sorpresa. Le era tornata alla memoria una frase che aveva sentito dire qualche anno prima, a proposito di una ragazza di Marineo andata a vivere con un protettore di Palermo: «Certe donne il puttanesimo ce l’hanno nel sangue!». Quella frase, ascoltata per caso, le era entrata in testa e non voleva più uscirne. “È proprio vero” pensava Filicetta “che puttane si nasce! Se non fosse così, come potrei vivere tranquilla e senza rimorsi per quello che faccio? Come potrei provare piacere, a volte, con i miei clienti, se facessi la puttana soltanto per necessità?” Andava a messa tutte le domeniche, da sola, nella chiesa di San Niccolò. Spesso anche si confessava e si comunicava, perché considerava la confessione alla stregua della pulizia del corpo, una pulizia dello spirito; ma per quanto promettesse al confessore di cambiare vita, sapeva che non l’avrebbe cambiata e che il prete avrebbe continuato a perdonarla ogni volta che fosse tornata a confessarsi: che cos’altro ci stavano a fare, al mondo, i preti, se non perdonavano i peccati della gente? A volte, le sembrava di essere due persone, la ragazza per bene e la madre di due figli che era stata un tempo e la donnaccia che era adesso; altre volte, invece, era assolutamente certa che la sua vera identità fosse quella presente, e che tutto ciò che aveva fatto prima di venire a Palermo l’aveva fatto perché, pur avendo il puttanesimo nel sangue, a Marineo non aveva avuto modo di manifestarlo…
Le piaceva Palermo. Le piaceva sentirsi intorno quella città così dolce e così misteriosa, così sguaiata e piena di rumore in alcuni luoghi e così silenziosa e sontuosa in alcuni altri… Le piaceva sedersi alla sorbetteria del Messinese, alla Marina, per farsi guardare dai donninnari, cioè dai giovanotti che cercavano la fidanzata, e anche da certi altri bellimbusti che non erano più né giovani né scapoli ma passavano lì gran parte del loro inutile tempo, cercando un’avventura che non trovavano quasi mai. Le piaceva veder sfilare le carrozze dei nobili con i loro pittoreschi equipaggi, e ascoltare la gente del popolo che sussurrava i nomi dei proprietari di quelle carrozze, a mezza voce perché certe cose mica si può gridarle per strada!; bisogna dirle con discrezione. «Ecco, l’hai visto?» mormoravano i mariti alle mogli e i fidanzati alle zite. «È passato il conte di Toledo», oppure: «È passato il principe di Trabia, è passata la duchessa di Pietratagliata, è passato il principe di Mirto…». Le piaceva passeggiare sul Càssaro, nelle mattine d’inverno o di primavera quando il sole ancora non brucia e non arrossa la pelle, curiosando tra le vetrine dei negozi o guardando i passanti; le piaceva salire su una vettura da nolo e farsi portare fuori città nelle sere d’estate, ai Quattro Canti di Campagna o più lontano ancora, al santuario di Santa Rosalia sul monte Pellegrino. Era diventata amica della sua sarta, una giovane signora che aveva lasciato il marito per diventare l’amante di un principe, e andava con lei tutte le domeniche al campo della Favorita a veder correre i cavalli del principe; ma poi il principe aveva mandato a dire alle due donne che per favore la smettessero di venire all’ippodromo, perché la loro presenza era stata notata e poteva far nascere chiacchiere sul suo conto. Le amiche, allora, avevano incominciato ad andare ai bagni dell’Acquasanta e ai sabati della Flora, ad ammirare le luminarie di Villa Giulia e ad assistere alle esibizioni dei pupari nei viali del parco…
Aveva anche uno spasimante, Filicetta: uno studente alto e magro e rosso di capelli che veniva da Girgenti, si chiamava Antonio ed era già fidanzato al suo paese – ma questo, lei lo sapeva soltanto da pochissimi giorni! – con una pronipote di Crispi: con quell’Angela, che aveva raccolto i ciuri de maju del 1894 per se stessa e per la figlia di sua eccellenza. A Palermo, Antonio abitava con due compagni d’università nella stessa casa di via dei Biscottari dove abitava anche Filicetta, e s’era messo in testa di arrivare a sedurla; pur sapendo benissimo, come tutti, che era la mantenuta dell’onorevole Palizzolo e dei suoi amici mafiosi, e che, a scherzare con lei, si scherzava col fuoco… Quel pericolo, anziché spaventarlo, lo eccitava. A qualunque costo, continuava a ripetersi, mentre si preparava a sostenere l’esame di laurea, lui doveva riuscire ad infilarsi nell’appartamento e nel letto di Filicetta, prima di tornare a Girgenti; e le faceva dichiarazioni d’amore sulle scale, la tempestava di bigliettini e di poesie che la ragazza leggeva ridendo («Chi l’avrebbe mai detto» mormorava, «quando ancora ero una contadina al mio paese, che sarei diventata una di quelle donne che ispirano i poeti!»), le metteva sulla porta certi mazzolini di fiori che raccoglieva tornando dall’università, ai giardini pubblici quando non c’erano le guardie. Per vincere le resistenze della bella vicina era perfino arrivato a chiederle di sposarlo, e Filicetta ne era rimasta sorpresa. “Deve essere proprio un ingenuo” si era detta “se non sa cosa faccio per vivere!” Ma poi aveva pensato che anche la richiesta di matrimonio fosse soltanto uno stratagemma per portarla a letto. Aveva pregato l’amica sarta di prendere qualche informazione, senza dar nell’occhio, su quel giovanotto così innamorato di lei, e aveva saputo la verità: subito dopo la laurea, il bell’Antonio avrebbe celebrato le sue giuste e sospirate nozze con una signorina della buona borghesia di Girgenti, pronipote di Crispi…
A Palermo, Filicetta era quasi felice. Viveva giorno per giorno, stava bene, e, dopo l’amnistia per i moti dei Fasci, non aveva più nemmeno il timore di poter essere perseguitata per quello che le era capitato al paese. Anche il ricordo dei figli, col passar del tempo, aveva smesso di assillarla. Saro e Nuzzu, pensava la ragazza, erano nati per fare i contadini e nessuno più avrebbe potuto cambiare il loro destino, così come nessuno più avrebbe potuto cambiare il suo. La sua vita precedente, il suo passato le sembravano definitivamente passati; ma quando, un’ora prima, aveva aperto la porta di casa ad uno sconosciuto e si era trovata davanti don Piddu Facci di lignu, il passato le era ripiombato addosso con il fragore del tuono, e le due persone che convivevano in lei come due estranee, la contadinella d’un tempo e la donna di oggi, si erano ritrovate strette insieme in un abbraccio d’orrore, o forse erano ritornate per un momento ad essere una sola persona. Don Piddu aveva ripetuto: «Mi manda l’onorevole», e poi, siccome Filicetta non diceva niente e continuava a fissarlo con gli occhi spalancati, aveva fatto il gesto di scostarla per entrare in casa. Lei, allora, s’era messa le mani nei capelli e aveva incominciato a gridare: «Aiuto! Aiuto!», così forte che alla fine erano usciti i vicini. Aveva intimato a quell’uomo: «Andate via!».
Facci di lignu era rimasto impassibile; ma, se pure il suo viso non lo dava a vedere, anche lui era stupito e imbarazzato per quell’accoglienza. Si era chiesto chi fosse quella ragazza, che non ricordava d’avere visto prima d’allora, ed era arrivato a concludere che certamente era la vedova o la figlia di uno dei tanti morti ammazzati per mano sua: di chi, non aveva i...