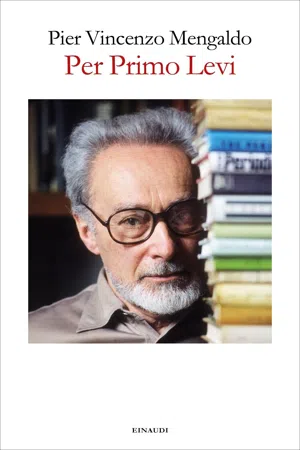Levi ha scritto una volta: «quanto è gradevole [...] pacificante, rasserenante, il caso [...] dell’uomo che si conserva uguale a se stesso attraverso quello che scrive!»1. Tutta la sua opera ci indica che questo caso era, se altro mai, il suo; ma purtroppo io, pur avendolo molto desiderato, non ho fatto a tempo a conoscerlo. Potrò dunque parlare solo della sua opera, quest’opera che ora, assieme alla vita di Levi, è conclusa per sempre. E il destino ha voluto che l’una e l’altra si siano chiuse ad anello, sotto il segno della compiutezza, con quell’I sommersi e i salvati che dopo quarant’anni ha saldato il conto aperto da Se questo è un uomo, e anche per questo ha finito per essere veramente il testamento dello scrittore: sigillo della capacità che è stata sua, e che è data a pochi, di trasformare la propria vita individuale in destino e necessità, significativi per tutti.
Sarebbe stato meglio dirlo ad alta voce quando Levi era ancora vivo, ma ciò che colpisce anzitutto, ripensando alla sua opera, è il contrasto che esiste, nei confronti di questa, fra pubblico e critica specializzata. Pochi scrittori del nostro tempo sono letti altrettanto e con altrettanto consenso – non solo in Italia – di Levi, uno dei rarissimi oggi che i lettori non ammirano soltanto, ma amano. Di fronte a questo successo di pubblico, sta la relativa indifferenza della critica, che non l’ha affatto collocato al posto che merita. Prendiamo per esempio Il piacere della letteratura di Angelo Guglielmi2, antologia “ragionata” della prosa italiana degli anni Settanta. È vero che si tratta di un libro particolarmente sciagurato e fazioso, ma insomma vi sono antologizzati prosatori del tutto irrilevanti, che è carità non nominare, e non c’è neppure una riga di Levi. Eppure in quel decennio egli ha scritto, se non altro, la mirabile rievocazione del mondo ebraico piemontese, «Argon», che apre Il sistema periodico.
Il fatto è che Levi non era uno scrittore-letterato. Lui stesso ha sempre insistito sulla priorità, anche agli effetti della propria vocazione letteraria, della formazione e pratica di chimico («scrivo proprio perché sono un chimico»3). I letterati italiani, che sono molto corporativi, hanno sentito questo suo essere «d’un’altra spece» (come si esprimeva Saba) e l’hanno tenuto a distanza.
Ma al di là di ciò direi che ci sono almeno due condizioni necessarie per comprendere Levi, ed entrambe, oggi, sono piuttosto fuori corso presso i cosiddetti specialisti. L’una è la simpatia – che non significa necessariamente totale consenso – per la forma mentale intrepidamente illuministica, empirica e razionale che è stata la sua. In Levi incredibilmente rimase sempre, nonostante le terribili smentite che la vita s’incaricò di dargli, un atteggiamento leibniziano verso la realtà, vale a dire il senso della razionalità, se non della storia, della natura, e la fiducia nella funzione ordinatrice della ragione umana: in una pagina della Ricerca delle radici si parla appunto del «misterioso parallelismo fra la propria ragione e l’universo4». Levi ha sempre visto il nazismo e le altre grandi aberrazioni della storia moderna come perversioni della ragione, non come prodotto dell’estrema razionalizzazione che l’uomo moderno ha imposto alla propria attività e al mondo; e certo la fortunata teoria di Horkheimer e Adorno di una dialettica negativa dell’illuminismo, che capovolge in barbarie i suoi presupposti razionalistici, doveva essergli del tutto ostica.
La seconda condizione indispensabile ad entrare in sintonia con Levi mi sembra quella di mettere fra parentesi le inclinazioni eccessive del nostro gusto verso le soluzioni linguistiche di tipo espressionistico, plurilingue e «macaronico», insomma verso la “linea Gadda”. Accanto a Calvino (tuttavia piú virtuosistico di lui, nel bene e nel male) Levi è stato la prova vivente che con la lingua italiana si può costruire uno stile ricco ed efficace anche senza manipolarla e violentarla, ma restando rigorosamente entro i suoi limiti costituiti, e lavorando piuttosto per sottrazione che per addizione. Perché se per pura ipotesi noi volessimo astrarre dalle qualità che lo scrittore possedeva in abbondanza, scienza della vita e capacità di osservazione, inventiva, arte nativa del raccontare, resterebbe pur sempre la sua scrittura elegantemente sobria, trasparente e sostanziosa, mai se cosí posso dire maleodorante, a garantirne l’alto rango. Senso delle gradazioni e sfumature sinonimiche e precisione nell’aggettivare ne sono gli indici piú vistosi (quasi a caso, l’episodio del vecchio comunista Thylle nella Tregua: «Gli dissi che soffrivo di nostalgia; e lui, che aveva smesso di piangere, “dieci anni”, mi disse, “dieci anni!”: e dopo dieci anni di silenzio, con un filo di voce stridula, grottesco e solenne ad un tempo, prese a cantare l’Internazionale, lasciandomi turbato, diffidente e commosso»5). E che rapporto corra fra questo tipo di stile e l’atteggiamento illuministico dello scrittore, non ha bisogno di essere dimostrato. Si può aggiungere che fra le tante curiosità intellettuali di cui Levi era ricco c’era quella per i meccanismi delle lingue. In particolare per l’etimologia in quanto traccia del processo di significazione, per gli scambi tra nome proprio e nome comune, per i linguaggi tecnici, per l’ibridazione linguistica, che egli ha osservato al vivo nello yiddisch e nel giudeo-piemontese. E anche qui prevaleva, accanto all’interesse tutto suo per il vario e il diverso e l’imprevisto, un gusto che direi cratiliano per la razionalità del linguaggio, per la rispondenza esatta e insieme fantasiosa del nome alla cosa.
Vorrei anche insistere sul fatto che, nella sua grande linearità e coerenza di sviluppo, Levi è però scrittore piú complesso di quanto di solito si creda. Certo, egli è nato scrittore con Se questo è un uomo, è il Lager che gli ha armato la penna, per quel bisogno primario di raccontare agli altri l’incredibile su cui egli ha tanto insistito (l’incubo di narrare agli altri, dopo, la propria esperienza e non essere creduti era, lo sappiamo anche da altre fonti, comune fra gli internati). E cosí è evidente che il nazismo e la condizione ebraica sono stati i grandi temi ricorrenti della sua opera. In questo c’era probabilmente molto del carattere dell’uomo, che una volta ha descritto sé stesso come un tarlo paziente (ricordate la talpa marxiana?) che rosicchia per tutta la vita entro il suo legno6. E c’era naturalmente il sentimento della rilevanza oggettiva di quei temi, e qualcosa di piú, l’impegno a tenerne viva la memoria e la riflessione che al superstite pareva un dovere quasi religioso: per mettere in guardia l’umanità di fronte al pericolo tutt’altro che remoto che quelle infamie si ripetessero o addirittura fossero già fra noi senza che noi lo sapessimo, e come forma di risarcimento delle vittime, di tutti coloro che non hanno potuto parlare (a me Levi ha scritto che compiere I sommersi e i salvati era stato per lui «un “adempimento”, una specie di voto»). C’è infine nella Tregua un episodio fulminante, di cui è protagonista l’ebreo greco Mordo Nahum, uno dei personaggi piú straordinari di quel libro straordinario (proprio lui Levi ha collocato, solo fra i suoi, negli Elisi dei personaggi letterari che ha immaginato in un racconto di Vizio di forma, Nel Parco). A Mordo che gli spiega quanto anche ora sia indispensabile possedere un buon paio di scarpe, perché con le scarpe ci si procura da mangiare, ma non viceversa, Levi che dopo la liberazione ha abbassato la guardia replica che «La guerra è finita». Al che il greco: «Guerra è sempre».
Tuttavia io considero grande merito di Levi, e segno della sua statura di scrittore, aver saputo cercare altre vie dopo La tregua, uscita nel ’63. La via è stata soprattutto quella del racconto breve, di cui egli si è rivelato un autentico maestro, certo anche in virtú della sua sobrietà e precisione di scrittura (ricordo che il primo volume di racconti Levi lo pubblicò, quasi per timore e pudore, con uno pseudonimo). Attraverso quattro raccolte, da Storie naturali e da Vizio di forma al Sistema periodico e a Lilít e altri racconti, lo scrittore ha sperimentato varie maniere e possibilità di racconto, accostandole e intrecciandole suggestivamente e per cosí dire facendole reagire le une sulle altre: sicché sul realismo delle narrazioni di vita vissuta e di memoria si proietta lo sghimbescio “arbitrario” di quelle di fantasia, ma queste ultime a loro volta traggono dalle prime il loro limite. S’alternano dunque racconti realistici e autobiografici e, maggiore novità, racconti fantastici o fanta-scientifici, non lontani da quelli contemporanei dello scrittore che per tanti aspetti è piú affine a Levi, e anche l’ha influenzato, Calvino. (Ne voglio menzionare nominalmente almeno uno che a me pare un capolavoro, la quasi lucreziana Quaestio de Centauris, nelle Storie naturali, dove Levi eccezionalmente costeggiò le atmosfere mitologiche “decadenti” tentate ad esempio, da noi, da un Tomasi di Lampedusa). In questi racconti fantastici giocano un ruolo essenziale, legando sottilmente invenzione ed esperienza biografica, gli spunti forniti dalla scienza, e in particolare dalla chimica che Levi praticava per appassionato mestiere, i quali assolvono, mi pare, una doppia funzione: di pretesto e quasi propellente alla fantasia, ma anche di coibente o freno razionale, di indicazione che anche le piú sbrigliate avventure immaginative non sono che sviluppi delle possibilità razionali dell’uomo, e che scienza e fantasia, lungi dall’escludersi, si implicano e potenziano a vicenda. Al di qua dei contenuti, lo svolgimento quasi teorematico di molti di essi dimostra questo nesso.
Nell’una e nell’altra serie sono fitti i rapporti col filone principale dell’opera di Levi. Rapporti espliciti, cosicché alcuni racconti vanno visti come veri e propri complementi di Se questo è un uomo e della Tregua o come prolegòmeni dei Sommersi e i salvati. Tale per esempio «Vanadio», nel Sistema periodico, narrazione del difficile rapporto epistolare con un ingegnere tedesco conosciuto nel laboratorio chimico annesso al Campo di Buna-Monowitz, tipico rappresentante di quella che piú tardi Levi chiamerà, indagandone implacabilmente le forme, la «zona grigia», intermedia e fluttuante fra persecutori e complici attivi da una parte, vittime e oppositori dall’altra (e vi si esprime quello che fu un assillo di Levi, il contatto coi tedeschi di allora e di oggi). Oppure, in Lilít, Il re dei giudei, potente rievocazione di Chaim Rumkowski, l’ebreo megalomane e delirante di potenza che collaborò coi nazisti in qualità di presidente e quasi dittatore del ghetto di Łódź, battendo moneta, facendo stampare francobolli con la propria effigie, viaggiando per il ghetto su una scassata carrozza personale e infine ottenendo dai persecutori di essere trasportato ad Auschwitz, per esservi liquidato, su un vagone speciale agganciato al merci dei suoi “sudditi”. Ma in altri casi i rapporti con le opere dedicate ai campi di sterminio sono nascosti e impliciti, specie laddove Levi esplora fantasiosamente le vertiginose possibilità della scienza e della tecnica (come nell’ipotesi del riproduttore di esseri umani, il mimete), non di rado anticipando con le sue immaginazioni, come ricorderà nella prefazione alla ristampa di Vizio di forma7, quelle che dovevano di lí a poco essere effettive scoperte tecnico-scientifiche: il che tra parentesi la dice lunga sulle sue intenzioni.
A me sembra che il legame che unisce molti di questi racconti ai temi del nazismo e della persecuzione razziale (e che può anche salire alla luce piena, come nel terribile racconto sullo scienziato nazista che trasforma esseri umani fatti schiavi in uccellacci appollaiati sui trespoli8) non riveli solo l’instanza che quei temi avevano nell’animo di Levi, ma qualcos’altro ancora di piú profondo. E cioè che per quanto riguarda l’interpretazione del nazismo e della sua programmata follia razzistica, Levi oscillò sempre fra due possibilità: quella, a cui per la verità si sforzò di attenersi rigorosamente tutte le volte che parlò ex professo del fenomeno e lo giudicò, che vi vedeva un episodio spaventoso ma circoscritto nel suo tempo e nella sua catena di cause specifiche; e quella invece, che egli probabilmente tendeva a seppellire sotto la sua coscienza, che individuava in esso l’espressione conseguente e quasi necessaria dello sviluppo tecnico e della vocazione totalitaria del mondo moderno.
Anche La chiave a stella, piú che un vero e proprio romanzo (tra l’altro perché vi manca uno sviluppo del personaggio, troppo paradigmatico, e perché le varie situazioni che vi si susseguono non sono che variazioni di una situazione-base), è una collana di racconti tenuti assieme da un filo conduttore, il personaggio dell’operaio specializzato Faussone che narra a ruota libera le vicende legate alle proprie occasioni di lavoro. Dico la verità: quando il libro uscí, mi lasciò perplesso e un po’ mi deluse. Mi parve che ci fosse qualcosa di troppo programmatico e diciamo pure di troppo ideologico nell’esaltazione che l’autore faceva, attraverso il suo protagonista per il quale ogni lavoro è come il primo amore e gli uomini si dividono in galantuomini e lavativi, dell’etica del lavoro in quanto tale, quasi scisso dalle condizioni sociali e produttive in cui avviene, e della soddisfazione del lavoro fatto con abilità e competenza (anzi, con fantasia): giungendo per esempio ad affermare che «l’amore o rispettivamente l’odio per l’opera sono un dato interno, originario, che dipende molto dalla storia dell’individuo, e meno di quanto si creda dalle strutture produttive entro cui il lavoro si svolge». Oggi io mantengo queste riserve, ma devo riconoscere che assumere posizioni simili nell’anno di grazia 1978 era un atto di indipendenza e di coraggio; non posso che ammirare la precisione e vivezza, molto rare, con cui Levi descrive il lavoro tecnico e i s...