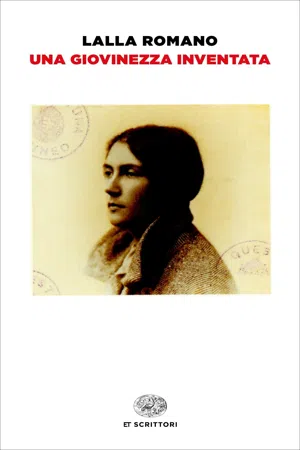Gli esami si davano in un’aula a terreno, grande e semibuia, preceduta da un’altra pure semibuia. Sull’uscio di passaggio tra le due aule avvenne il mio primo incontro – e scontro – con Giovanni Oneglia.
L’esame era quello di filosofia teoretica, e noi cominciammo a discutere sull’argomento, che riguardava Kant; diventammo presto accaniti, cosicché fu una specie di litigio.
La mia famosa dichiarazione, che per me l’uomo fatale doveva essere un filosofo, purché pulito, avrebbe dovuto predispormi a riconoscerlo in Giovanni Oneglia. E il fatto che avessimo litigato a prima vista poteva essere ugualmente un segno. Con Zoe S., la mia grande amica al ginnasio – amicizia un po’ amorosa – l’inizio era stato appunto uno scontro.
A me non interessava quello che uno faceva, a che punto fosse degli studi e cosí via; comunque fui informata da lui che si era laureato in legge. Arricciai il naso per l’uggia dell’argomento; ma lui disse che la creazione del Diritto, cioè il tentativo degli uomini di dare una forma alla vita, era una cosa grande. Ora intendeva laurearsi in filosofia; perciò lo considerai molto piú vecchio di me.
Non litigammo piú; ma se su qualche questione non eravamo d’accordo, ciascuno ribatteva con ostinazione il suo punto di vista: come era stato con Andrée. Lui mi dava un po’ soggezione, non molto.
Era piuttosto bello: i suoi capelli erano ruvidi, corti e ricci, i suoi occhi azzurri, seri. Il suo viso era fine, di disegno fermo eppure dolce, con una certa aria austera (monastica?), privo assolutamente di malizia, di sottintesi sensuali.
Ciò garantiva la possibilità di un’amicizia, quella da me «sognata invano» (come diceva dell’amore mio cugino Nino). Non provai mai esaltazione, al pensiero di lui, ma un senso di sicurezza, come per un’affinità di fondo, che era una garanzia in piú. Ci voleva un «piú».
La sua alta statura avrebbe dovuto ricordarmi Corrado Péllice, ma non lo pensai. Non c’era stato l’incantesimo degli sguardi; anzi, non guardavo mai Giovanni Oneglia negli occhi, che pure erano belli. Consideravo il nostro un rapporto «virile».
Parlava della sua famiglia con una specie di venerazione. Questa venerazione mi irritava, e mi faceva supporre una qualche grandezza, per la quale non provavo nessun interesse. Detestavo le grandi famiglie.
La leggenda della sua famiglia nacque da un’immagine. Parlavamo di montagna, e lui uscí a dire: – Quando si ritorna dai rifugi, come sembra bella la casa, i rubinetti lucenti... – Di colpo mi figurai la sua casa: grande, lussuosa, scintillante. Ma non avevo nessuna curiosità intorno alla situazione sociale delle persone.
Del resto Giovanni Oneglia parlava anche dei professori con troppa riverenza, per me; specie di Pastore che pure io amavo molto. Secondo me bisognava anche ridere, delle persone importanti.
Invece, quando usava il tono reverenziale parlando della montagna, mi piaceva. Le montagne non erano persone.
Giovanni Oneglia era cosí: non era possibile separare in lui le sue scoperte, i suoi attaccamenti della vita e della letteratura, nella natura e nei libri. E la religione: in lui non c’era, come in me, problematicità, provvisorietà. Evitavo l’argomento.
I suoi discorsi sulle montagne mi coinvolgevano. Lui era di Porto Maurizio, e come tanti liguri che avevo incontrato nei rifugi, conosceva bene le Marittime. Mi insegnò a considerarle qualcosa di speciale, di unico. Anch’io le amavo, gelosamente; ma io avevo avuto un culto per le valli lontane e piú grandiose: avevo letto con passione Il Cervino di Guido Rey, avevo appeso nella mia camera una fotografia dell’Aiguille Noire. Naturalmente non era l’alpinismo che mi interessava; vedevo nelle montagne un simbolo di orgogliosa solitudine.
Giovanni Oneglia mi insegnò a privilegiare proprio la «povertà» delle Marittime. Nelle vacanze mi mandava cartoline, di quelle dai colori acquerellati sopra le scialbe fotografie vecchie: azzurro incredibile per il cielo e il lago (il «mio» Lago delle Rovine!), grigio un po’ rosato per le rocce, le pietraie; altitudine modesta, nulla di eroico.
Una volta mi portò – eravamo già molto amici, e del resto lo fummo ben presto – una serie di piccole cartoline un po’ vecchie, nitide ma pallide. C’erano esquimesi, cani da slitta, barche: immagini chiare, senza ombre: e la gente misteriosamente serena. In una cartolina campeggiava un iceberg che aveva la forma di nave con una grande vela bianca. Illustravano la Groenlandia.
La predilezione per il Nord era una coincidenza tra noi. Al ginnasio avevo composto una canzoncina:
Se una terra lontana
sogna la mia finzione
è nei freddi paesi
del settentrione.
Là dove tra i pini
crescono le betulle
bianche i poeti
sognano le fanciulle.
Ora mi vergognavo di quella facilità, e non ne parlai con Giovanni.
Il Nord poteva fondere la montagna (mia) e il mare (suo).
Al liceo avevo scovato un piccolo libro, una cinquantina di pagine, che conteneva due poemi (in prosa) di Ibsen, il primo titolo era un nome norvegese che mi suonò bellissimo: Terje Vigen. Cominciava: «Lontano, nel mare, sulla piú alta rocca, viveva un vecchio, amante della solitudine». Tanto bastava.
L’altro era intitolato In alto, titolo che ricordava Excelsior o La piccozza, cose che ritenevo ridicole; ma qui nulla mi pareva ridicolo. Frasi come «Io salgo verso l’immensità» mi suonavano esaltanti; e il finale: «Io non obbedisco piú che alla voce che mi comanda di vivere sulle cime delle Alpi. Per sempre ho abbandonato la vita della valle. Qui sopra con Dio e la libertà. Laggiú striscino pur gli altri!»
Nemmeno di questo parlai con Giovanni, perché avrei dovuto confessargli che non avevo mai restituito il libretto alla biblioteca del liceo; non che mi rimordesse la coscienza – sentivo di avere il diritto di tenere per me il libretto – ma non volevo scandalizzare lui.
Io già riconoscevo come paese «mio» la Sardegna, da quando avevo letto negli anni del ginnasio Grazia Deledda. Il primo romanzo era stato Marianna Sirca (scoperto su La lettura); poi L’incendio nell’uliveto, Elias Portolu. Era la Sardegna delle montagne. La luna azzurra ai vetri delle camere imbiancate a calce, il sole rosso nel bosco, pastori, cacciatori, maestre, preti; case di pietra, balconi di legno e muri a secco come nella mia valle. Ma ormai mi vergognavo della Deledda.
Giovanni mi portò i Canti Barbaricini di Sebastiano Satta. Anche lí banditi, pastori, veglie di caccia, boschi di soveri. E i nomi: Montespada, Monte Gonare. Le poesie erano magari sonetti di fattura carducciana, ma mi parevano tutt’altra cosa. C’erano perfino ditirambi (D’Annunzio!) Non importava. Anzi, la preferita di Giovanni era appunto intitolata Ditirambo:
Date l’acquavite alle mani
prendete la tasca e lo schioppo
. . . . . . . . . . . . . . . .
Versatemi il vin di Marreri
. . . . . . . . . . . . . . . .
e p oi... hutalabí al corridore
(hutalabí era un «grido di gioia selvaggia»).
Io preferivo le poesie piú assorte, piú misteriose:
... tra i radi
ginepri, volgendosi ai guadi
notturni, passò la bardana.
(la bardana era una spedizione di rapina).
E anche:
. . . . . . . . . . . . . .
solo un pastore, immobile
col manto e con la tasca,
guarda quel regno gelido
di tenebra e burrasca.
Queste poesie non mi facevano soffrire – come Baudelaire e a suo tempo Leopardi –, partiva da esse una eco quasi reale: struggente, ma non letteraria. Mi facevano sognare, come la natura stessa.
Giovanni aveva un modo di nominare i posti del suo retroterra ligure (Baiardo...) che mi incantava, cosí che li coinvolgevo nel mondo dei Canti Barbaricini e della mia valle.
Lui amava molto i poeti liguri (Boine...) e qui non lo seguivo tanto. C’era però una poesia, che aveva un bel titolo: Albero inclinato, e incominciava:
Il villico t’insidia alber morente
e terminava con due versi bellissimi:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nel tempo alberi ed uomini uguagliando
con la malinconia, magra sorella.
Il nome strano del poeta che piaceva a Giovanni m’intrigava: Ceccardo Rocca tagliata Ceccardi. Giovanni mi portò Ceccardo di Lorenzo Viani: mi colpí il tema anarchico-socialista. Ma del Viani preferii Parigi. Gustavo come novità estreme le sue frasi e parole cosí personali, come: «è andato ad aberintarsi a Parigi». Che era poi una Parigi spettrale, piena di freddo e di fame.
Sui miei fogli di appunti, scritti a varie riprese con caratteri sempre differenti e sempre minutissimi, fra i vari, improvvisi disegni fantastici, cominciarono a comparire, prima contorni, poi immagini piú precise: sempre di tre facce, con occhi naso e bocca. Il titolo scritto sotto a ognuna era: vagabondo – intellettuale – borghese.
Il «vagabondo» aveva una fronte non troppo alta, la larghezza maggiore era la distanza degli zigomi, occhi lunghi, naso sottile; l’«intellettuale» aveva la fronte vasta, gli occhiali, la bocca sottile, il mento appuntito; la faccia del «borghese» era un po’ a pera, larga in fondo, le labbra grosse, gli occhi piccoli.
Questi schemi volevano verificare una scoperta confidatami da Giovanni (fatta chissà come): i caratteri di tre tipi umani. La sua – e la mia, lui lo sapeva – fraternità era per il «vagabondo»: l’essere libero, imprevedibile, anarchico. Io potevo aspirare a incarnarlo, coi miei zigomi; Giovanni aveva invece il viso ovale, lungo e stretto; gli occhi erano però certamente accettabili: lunghi, sotto la fronte forse troppo alta: troppo per lo schema, che tendeva al triangolo.
Giovanni mi confidava queste cose con aria insieme semplice e miracolistica, che mi rammentava le fiabe raccontate da papà.
Gli scrittori che amavamo avevano qualcosa del vagabondo. O meglio, l’avevano i personaggi scelti da essi. Oppure erano gli ultimi, i «vinti» della storia. Era una scelta di contenuto? Per la poesia, forse lo era stato; ma nella narrativa veniva prima la forma.
Amavamo molto I Malavoglia. L’impassibilità del Verga era stile, non indifferenza. A noi comunicava una dolorosa ma esaltante fraternità per i suoi personaggi.
Allo stesso modo, e anche di piú amavamo Tre croci. Vedevamo, nel calarsi in quelle misere vite, un po’ vili, non compassione: pietà.
C’era quel fratello sopravvissuto, all’Ospizio, che «pensava sempre alle nipoti: – Se io muoio presto, vi prego di dire alle mie due nipoti, che io mi ero messo a lavorare». E l’ultima frase: «in mezzo a loro il morto doventava sempre piú buono». Era sublime.
Il «doventava» non era un’intrusione, era una conferma di verità, insieme umile e superba. Come, secondo noi, la poesia doveva essere.
Era come inteso che avremmo scritto.
Nel suo primo racconto che Giovanni mi fece leggere c’era una «contessina povera» (antipatica) che innaffiava i fiori, e una strana immagine del personaggio uomo, sdraiato sulla spiaggia, «forbicione nero» (mi pareva un insetto, come dicesse «formicone»).
Vita mi sembrò bello. Un vecchio, seduto al sole, guardava bambini giocare. Da questi giochi e dalle canzoncine dei bambini apprese che c’era la guerra. Una ragazza veniva a prendere il nonno e lo riaccompagnava a casa. Mi piacque molto la frase «parlavano poco perché si volevano molto bene».
La ragazza aveva un nome molto strano: «Grumi». Giovanni mi spiegò che Grumi derivava da Noemi: nome che mi era sempre parso antico e misterioso. Lui aveva una cugina che si chiamava cosí. Quando diceva «mia cugina Noemi», oltre alla solita uggia per la sua famiglia – per l’importanza che lui le dava – provavo anche un po’ di gelosia.
Mi parlava di un altro racconto che si doveva intitolare Auscultazione.
Non avevo mai inteso quel termine, e lui – aveva un fratello medico – me lo spiegò. Un titolo cosí non usava allora, e mi parve una scoperta importante. Ma il racconto non fu scritto.
Un altro racconto non scritto era intitolato La danza araba. Qualcuno cercava il protagonista, chiuso nella sua camera: accostò l’occhio alla serratura e vide l’amico, drappeggiato in un lenzuolo, eseguire una selvaggia e frenetica danza, appunto «araba». Era un periodo molto doloroso per Giovanni, e io capii che quella danza significava disperazione, ma anche ribellione.
Facevamo il gioco di inventare titoli, magari usando titoli già esistenti, da fiabe per esempio. A tutti e due piaceva moltissimo, piú di tutti, un titolo preso da una fiaba di Ander...