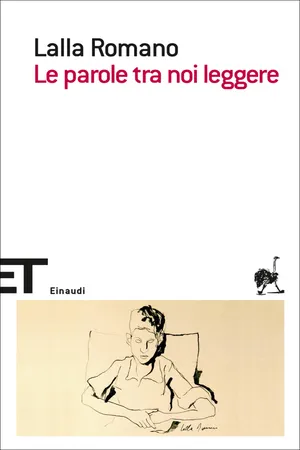1906
Lalla (Graziella) Romano nasce a Demonte (Cuneo) l’11 novembre, da genitori cuneesi, primogenita di altre due sorelle, Silvia e Luciana. Il padre Roberto, geometra, capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Demonte, era amante della pittura e della musica e un buon «dilettante fotografo». La madre, Giuseppina Peano, era nipote del famoso logico-matematico Giuseppe Peano, che tanto influsso poi ebbe sulla giovane Lalla.
1912-16
Frequenta le scuole elementari a Demonte.
1916-24
Frequenta il ginnasio e il liceo classico «Silvio Pellico» a Cuneo, dove la famiglia si era trasferita.
1924
Conseguita la maturità classica, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino. Frequenta soprattutto le lezioni di Filosofia teoretica di Annibale Pastore, di Letteratura francese di Ferdinando Neri e di Storia dell’arte di Lionello Venturi. Ha già iniziato a dipingere: i primi autoritratti sono datati 1923.
1925-28
Frequenta lo studio del pittore Giovanni Guarlotti. In questi anni compie numerosi viaggi con lunghi soggiorni a Parigi: scopre gli impressionisti e post-impressionisti, spesso guidata da Venturi nei musei e nelle gallerie parigine. Incontra Sborowsky, Menzio, Severini.
A Torino è compagna d’università di Cesare Pavese; conosce Mario Soldati, Arnaldo Momigliano, Carlo Dionisotti; stringe amicizia con Franco Antonicelli e Giovanni Ermiglia.
1928
Si laurea in Lettere, con una tesi su Cino da Pistoia. Su consiglio di Lionello Venturi, entra nella scuola di pittura di Felice Casorati, dove incontra – fra gli altri – Daphne Maughan, Nella Marchesini, Paola Levi Montalcini, Giorgina Lattes.
1929
Insegna Italiano e Storia alle Magistrali di Cuneo, continuando a frequentare la scuola di Casorati a Torino, dove espone alcuni quadri in una mostra collettiva.
1930
Insegna Storia dell’arte al liceo di Cuneo.
Partecipa a varie mostre collettive a Torino.
Su invito di Lionello Venturi, scrive per «L’Arte» un saggio su La scuola di Casorati. Scrive anche racconti, fra cui Le cronache della sartoria, pubblicati nel 1975 ne La villeggiante.
Diventa direttrice della Biblioteca Civica di Cuneo: compila il catalogo degli Incunaboli.
1932
Sposa a Cuneo Innocenzo Monti, impiegato di banca, il quale in seguito, scoperto da Raffaele Mattioli, farà un’importante carriera fino a diventare presidente della Banca Commerciale Italiana.
1933
Nasce l’unico figlio Pietro, detto Piero.
1935
Raggiunge il marito a Torino; insegna Lettere all’Istituto Magistrale «Regina Margherita» e poi al ginnasio-liceo «Cavour».
1937
Continua a dipingere e ad esporre: una «personale» a Palazzo Lascaris di Torino e altre mostre collettive a Cuneo, Napoli e Milano. Conosce Ardengo Soffici e lo frequenta a Forte dei Marmi.
1938-40
Su invito di Soffici, scrive tre racconti sulla vita degli artisti e sul mondo dell’arte in quegli anni a Torino (Una cena di artisti, Visita al collezionista, Inaugurazione di una «personale»), pubblicati nel 1993 in Lalla Romano pittrice. Espone in varie mostre collettive. Scrive altri racconti, fra cui L’aria di Roma, pubblicati ne La villeggiante.
1941
Pubblica la raccolta di poesie Fiore. Recensendola su «La Stampa», Ferdinando Neri loda «un’arte schietta, che si accorda con un dono nativo di sensibilità, [...] cosa nuova per un’intima forza, scevra d’ogni maniera». In una lettera all’autrice, Gianfranco Contini nota: «In piú momenti par di trovarsi nel clima dei frammenti saffici o di certe poetesse del cinquecento».
Partecipa a mostre collettive a Milano e Torino.
1943
Durante la guerra, danneggiato in un bombardamento l’alloggio di Torino, si rifugia a Cuneo col figlio presso i genitori, continuando a insegnare a Torino; l’anno dopo viene trasferita all’Istituto Tecnico di Cuneo. Amica di Dante Livio Bianco, aderisce al Partito d’Azione e partecipa alla Resistenza come incaricata dei «Gruppi di difesa della donna» (poi U.D.I.).
1944
Su invito di Cesare Pavese, traduce i Trois contes di Flaubert, avvenimento decisivo per il suo passaggio dalla pittura alla scrittura. «La traduzione di questa prosa semplice ed essenziale, – ha dichiarato, – mi consentí la straordinaria scoperta che la prosa può essere altrettanto rigorosa della poesia, che prosa e poesia, anzi, sono la stessa cosa. Dovevo a Flaubert il mio passaggio dalla pittura alla narrativa. Un cuore semplice per me era stato decisivo, la fine del pregiudizio che nutrivo verso il romanzo».
1945
Cura la traduzione e una scelta del Journal di Delacroix.
Tiene a Cuneo una mostra «personale». Scrive il racconto Pomeriggio sul fiume, pubblicato poi ne La villeggiante.
1946
Con altri artisti partecipa a Cuneo a una mostra a favore del Partito d’Azione. Ritorna a Torino, dove vive col figlio; intanto il marito si è trasferito a Milano. Matura l’abbandono dell’attività pittorica. Scrive d’arte su «Agorà» e per due anni «recensisce» le mostre di pittura di Torino per «Il Mondo» (poi «Il Mondo Europeo») di Firenze: lavoro critico incoraggiato anche da Eugenio Montale. Questi articoli sono ripubblicati in Lalla Romano pittrice.
1947
Si trasferisce a Milano. Insegna alla scuola media «Arconati» dove resterà fino al 1959, anno del congedo. Scrive il racconto Il congresso, pubblicato ne La villeggiante. A partire da quest’anno la sua attività intellettuale si svilupperà progressivamente con collaborazioni alle riviste «La Rassegna d’Italia», «Il Verri», «La Fiera letteraria», «Il Caffè», «L’Approdo», «Paragone», «Nuovi Argomenti». Via via nel tempo frequenterà Montale, Bacchelli, Solmi, Sereni, Bo, Vittorini, Paci, Rognoni; e avrà contatti con Anna Banti, Pietro Citati, Elsa Morante. Proseguiranno i rapporti con la casa editrice Einaudi, in particolare con lo stesso editore Giulio Einaudi, con Cesare Pavese, Natalia Ginzburg, Italo Calvino, Giulio Bollati.
1948
Scrive il racconto La Signora, pubblicato poi ne La villeggiante.
1951
Con Le metamorfosi inizia la lunga serie di opere in prosa. Questo primo libro, composto di sogni, era piaciuto a Pavese e poi a Vittorini che lo inserisce come secondo testo nella sua collana «I gettoni» e ne scrive la presentazione.
1953
Pubblica Maria, sempre nei «Gettoni»: nel risvolto Vittorini presenta il romanzo come «una storia di rapporti umani che si realizzano come rapporti ritmici e che tuttavia tendono a mostrare, malgrado il loro ripetersi, quanto di unico e di insostituibile, di dato una volta per tutte, vi sia in ogni individuo». Nella recensione sul «Corriere della Sera» Montale pone all’attenzione generale la «poesia dei petits riens» insita nel libro, la sua «semplice perfezione».
1954
Vince a Lugano il Premio Internazionale Veillon per Maria. Traduce il romanzo di Béatrix Beck Léon Morin, prêtre.
1955
Pubblica la raccolta di poesie L’Autunno.
1957
Esce il romanzo Tetto Murato, ambientato negli anni della Resistenza: il manoscritto aveva vinto lo stesso anno il Primo Premio Pavese riservato agli inediti.
1960
Pubblica Diario di Grecia, relazione di un viaggio che diventa una scoperta della Grecia come «modo di vivere nell’eternità» (Montale).
1961
Pubblica il romanzo L’uomo che parlava solo, unico suo libro in cui l’io narrante è un personaggio maschile.
1964
Pubblica il romanzo La penombra che abbiamo attraversato. Calvino nel risvolto scrive: «L’immagine proustiana del titolo significa qui l’infanzia, età in sé folgorante, ma ombrosa, oscura per chi la guarda dall’altra sponda, quella della maturità; ma è anche la vita stessa, lo spazio che deve essere riattraversato per ritrovare la tormentosa età, nella quale a nostra insaputa tutto era stato giocato una volta per tutte». Elsa Morante definisce il libro «incantata poesia». Vince il Premio dei Librai milanesi, ma fa scalpore la non attribuzione del Premio Viareggio, nonostante l’appoggio – fra gli altri – di Bobbio, Longhi, Piovene, Sapegno, Ungaretti e Montale il quale, per protesta, si dimette dalla giuria.
1967
Esce una nuova edizione – rinnovata nella struttura e con un saggio sul sogno – de Le metamorfosi, che nel 1968 vince il Premio Soroptimist: alla premiazione l’autrice è presentata da Montale.
1969
Pubblica Le parole tra noi leggere, con cui vince il Premio Strega. Montale sul «Corriere della Sera» osserva: «Se c’è ancora qualche lettore capace di amare una poesia incapace di esibirsi come tale, questo è un libro che può fare per lui».
1970
Esce in Giappone la traduzione de Le parole tra noi leggere.
1971
Scrive il saggio Didone ritrovata come introduzione all’edizione scolastica, curata da Lidia Storoni Mazzolani, del libro IV dell’Eneide di Virgilio.
1973
Pubblica L’ospite, che ha per protagonista il nipote Emiliano, nato nel 1970. Recensendolo su «Tempo Illustrato», Pier Paolo Pasolini parla di «lingua pura, eletta e selettiva [...]: lo spirito, un cert...