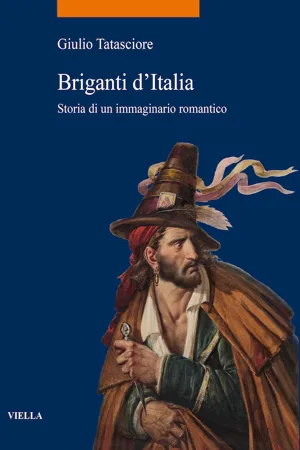![]()
Introduzione. I misteri del brigantaggio
Si impara sempre qualcosa con i ladri.
Honoré de Balzac
1. Fuorilegge e bassifondi
In una scena di Narcos, la serie televisiva che racconta l’ascesa e il declino del più celebre criminale del nostro tempo, Pablo Escobar, si ascolta una frase di sicuro effetto. La pronuncia il personaggio di Gustavo Gaviria, cugino e braccio destro del sanguinario leader del cartello di Medellín. Dice più o meno così: nosotros somos bandidos. Non sapos, “rospi”, spie. Ma banditi. Fuorilegge. Il contesto in cui si situa la frase è un classico. Si tratta del drammatico e violento pestaggio con cui i poliziotti del Bloque de Búsqueda, l’unità di operazioni speciali deputata alla cattura dead or alive del temibile narcotrafficante, cercano di ottenerne la consegna o, almeno, informazioni utili a stanarlo. L’ambiguo gioco di specchi che ne risulta è altrettanto tipico del genere. Il fedele Gustavo non sopravvivrà, ma morirà con fierezza seguendo il codice d’onore non scritto di quel mondo a parte in cui riveste un ruolo centrale, il mondo dei criminali. Di contro, lo spettatore farà molta fatica a distinguere il bene dal male, confuso dall’apparente integrità morale del fuorilegge e orripilato dall’assassinio, a sangue freddo, con cui le autorità chiudono la faccenda e la scena, in un crescendo mozzafiato.
C’è un altro elemento di interesse che fa da sfondo alla vicenda. E cioè il ritorno in grande stile, all’interno del repertorio seriale della crime fiction, di un problema di per sé antico, eppure indagato con particolare coinvolgimento dalle narrazioni letterarie o dalle indagini sociali che si sviluppano nel tardo Settecento e accompagnano tutto l’Ottocento. Mi riferisco al rapporto instabile, ambivalente e per certi versi enigmatico tra le identità criminali e le identità popolari. La pregnanza del tema e anche la sua attualità sono state certificate, in Italia, dal dibattito che si è sviluppato intorno a grandi affreschi della delinquenza popolare e del crimine organizzato così come delineati in prodotti di successo come Suburra, ambientata tra Roma e dintorni, o la celebrata Gomorra. Dopo la versione cinematografica, in questa ulteriore trasmigrazione del dirompente romanzo-inchiesta sulla camorra di Napoli, firmato a suo tempo da Roberto Saviano, diventa esplicito il problema della difficoltosa identificazione del confine tra pratiche delinquenziali e cultura popolare. Anche in altri titoli straordinariamente moderni ma insieme tradizionali – come la britannica Peaky Blinders, che narra gli affari della famiglia Shelby nei cupi sobborghi di Birmingham subito dopo la Prima guerra mondiale, tra sbirri senza scrupoli e pittoreschi clan gitani – sembra di ripiombare in una sensibilità che con un termine forse un po’ vago, ma pertinente, potremmo definire romantica. Una sensibilità nella quale domina la dimensione tragica, popolata com’è di eroi sublimi in senso proprio, capaci cioè di sedurre e di spaventare, di attrarre e di repellere, portatori di una verità che non è mai bianca o nera, ma che vive di contraddizioni e che si incarna in un «male grandioso», pronto a insinuarsi tra gli ingranaggi di una società piena di storture, squilibri, profonde ingiustizie.
Questo impianto generale segue almeno in una certa misura la traccia dei grandi capolavori del romanzo-feuilleton. Già in prodotti dal forte impatto sul piano estetico e al tempo stesso commerciale, in una linea che va dall’Oliver Twist di Charles Dickens fino ai Miserabili di Victor Hugo e passa per la sua espressione più compiuta, i Misteri di Parigi di Eugène Sue, la plebaglia (soprattutto urbana, ma non solo) assume i tratti della vittima incolpevole di un meccanismo sociale strutturalmente iniquo, individuato in un’ottica sia umanitaria sia stigmatizzante come la vera origine della degenerazione, insieme fisica e morale, dei bassifondi. I motivi e gli stilemi della narrativa di denuncia, che spazia dal realismo dickensiano ai toni socialisteggianti di Sue, sono noti. Tuttavia bisogna richiamare la straordinaria capacità del romanzo sociale di fornire a schiere commosse o scandalizzate di lettrici e lettori gli strumenti per osservare – dalla giusta distanza – il fantasmatico, raccapricciante e seducente universo dei margini. Il protagonismo assoluto delle figure della devianza, l’indagine sulle vite miserande dell’emergente proletariato o sui cupi intrighi delle alte sfere dei benpensanti, in altre parole, hanno marcato nel profondo la percezione collettiva del crimine, dei suoi molteplici stili, delle sue infinite varianti.
Al fosco ritratto delle “classi pericolose”, descritte un po’ da tutta la letteratura dei mystères come una specie di rovescio maledetto e sotterraneo del “bel mondo”, si accompagna un’altra idea decisiva. Sarebbe a dire l’idea, in embrione sul finire del XVIII secolo ma diventata un autentico luogo comune intorno agli anni Venti e Trenta dell’Ottocento, che tra i variopinti demoni dei bassifondi si celi un gruppo sociale inesorabilmente altro, una “classe criminale” caratterizzata, secondo l’elaborazione romantica del concetto di popolo, da costumi propri e tradizioni autonome, da abitudini comportamentali e infine da un particolare linguaggio, il terribile argot, in francese, jargon in inglese: il “gergo truffaldino” dei malfattori. La concezione diffusa a più livelli dell’esistenza di una criminal class – di una contro-società delimitata, localizzata e in parte naturalizzata, con la sua aristocrazia, la sua borghesia e il suo proletariato, in qualche modo separata, eppure pericolosamente vicina agli ambienti degradati dei ceti popolari e dei circoli sovversivi – costituisce un tratto essenziale della cultura ottocentesca. Nel tempo la centralità della questione sociale, il forte realismo descrittivo, l’indagine approfondita su classi popolari assunte come una società parallela rispetto alla buona società borghese avrebbero cementato la concezione del criminale come soggetto “altro”. Lo sguardo riservato a questo mondo non è solo quello compassionevole di certi letterati e delle sempre più diffuse società di filantropi. Le popolazioni instabili, sfuggendo all’ordine sociale, possono rappresentare un elemento di raccordo tra la sfera delinquenziale e la sfera dell’eversione politica, entrambi microcosmi da classificare, isolare e tenere a bada, poiché sempre pronti a mobilitarsi per il più temibile dei pericoli: l’insorgenza plebea. La metropoli è la vera cornice, certo, ma anche la protagonista di questa dinamica. Lo sono specialmente i suoi margini sociali, la cui criminalizzazione si fa generalizzata durante la prima metà secolo, ben prima dell’arrivo dell’antropologia positivista. Come nelle metropoli delle classes dangereuses, però, anche in luoghi apparentemente lontani o magari esotici e rurali sembrano proliferare associazioni di briganti, ladri, assassini, depositari non di generici atteggiamenti, ma di usi e credenze, di metodi, gerarchie, specializzazioni.
Ed è significativo che qualcosa di simile torni a connotare, dopo un periodo di latenza, il panorama di una serialità contemporanea imbevuta del messaggio che essere un criminale sia diverso dal fare il criminale. Questa percezione, tornando a Narcos, è ribadita ripetutamente nel corso delle puntate che si susseguono a un ritmo incalzante. Non a caso è di grande conforto all’Escobar finzionale, personaggio feroce eppure titanico, spietato ma malinconico, al quale il cugino Gustavo ricorda sempre le comuni origini di strada. Essere bandidos, in altre parole, significa far parte di una comunità. Significa che fuorilegge si nasce e, se necessario, si muore. Significa, anche, rappresentare una figura liminare. Differenti per loro stessa natura, costitutivamente in guerra con la società regolare, i criminali si mescolano e si confondono in quel disordinato, babelico sottobosco che sono i barrios di Medellín, laddove gli infiltrati americani si scoprono storditi e gli stessi borghesi colombiani appaiono di fatto estranei. Con il risultato che si sbiadisce la linea di demarcazione tra ciò che è irredimibile – i famigerati narcos, quasi destinati al crimine – e ciò che viceversa è circostanziale, un serbatoio inesauribile di canaglie e di miserabili dediti al piccolo delitto e alla lotta quotidiana per la sopravvivenza. Ma che, nondimeno, conoscono i valori positivi della lealtà, della dedizione, della dignità. Il ritorno di repertori simbolici che, distribuiti orizzontalmente tramite i supporti mediatici più vari (dai romanzi ai social, passando per le popolari piattaforme audiovisive), si articola lungo assi non solo consolidati, ma assai risalenti nel tempo. Si assiste così all’affascinata riscoperta del brigante tragicamente romantico, una sorta di modello polisemico che racchiude il bene e il male, l’osservazione simpatetica e i sentimenti di ripulsa, in un ossimorico impasto ad alta intensità che si riscontra nei narcotrafficanti come nei più tradizionali fuorilegge dei boschi. Ogni epoca sceglie i suoi miti. Anche se può capitare che siano dei miti di terza mano, magari rattoppati per un mondo post-moderno dove a dominare è la sfumatura; e dove le emozioni contrastanti del criminale reso tale dalle ingiustizie della società si prestano bene a descrivere in modalità accattivanti l’eclissi dei paradigmi novecenteschi del progresso e poi del lieto fine rassicurante, caratteristico del mainstream e della cultura di massa.
Ora spostiamoci nel tempo e nello spazio. E nei media. Collochiamoci nel mezzo. È infatti l’autunno del 1930, e il filosofo e intellettuale tedesco Walter Benjamin si trova impegnato in una serie di conferenze radiofoniche destinate al pubblico giovanile e ai ragazzi in età scolare. Benjamin, è risaputo, crede fortemente nel potere pedagogico della radio e dell’aneddoto. Così imposta un ciclo ricco di personaggi ed eventi memorabili. Spesso attinge al repertorio di episodi e figure che fanno parte di un bagaglio culturale condiviso, stratificato, quello che le scienze sociali sono abituate a definire nei termini di immaginario sociale. Un catalogo, un orizzonte fatto di idee ricevute e poi reiterate, che con il mutare dei contesti mutano di senso. Rappresentazioni collettive, coerenti e insieme dinamic...