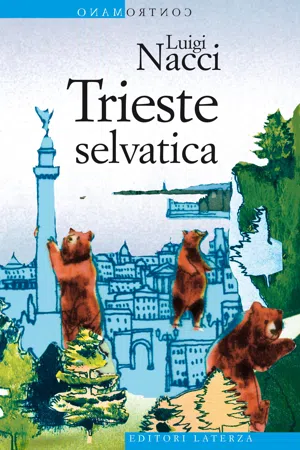1.
Le case si muovono
Vorrei dirti, caro lettore: sono nato in Carso tra gli scotani che fiammeggiano a novembre, partorito in una dolina in un giorno di bora scura che squassa le rocce e gli spiriti, da madre slava, padre italiano, e che in me scorre il sangue impuro di avi germanici e balcanici e levantini. Vorrei dirti che parlo lingue con grammatiche secolari e dialetti che si tramandano di bocca in bocca sull’altipiano calcareo, che sono una inafferrabile creatura mitteleuropea, cielo basso e sguardo sfuggente, lineamenti duri dell’Est e postura elegante di marinaio adriatico. Vorrei dirti che se c’è un triestino, un figlio di questa città senza identità, quello sono io. Ma ti ingannerei.
Se anche lo facessi, se tentassi di mentirti, molto presto capiresti che sono solo un povero italiano, cresciuto in un grattacielo dell’edilizia popolare, periferia proletaria di Trieste, tra italiani e rom, nemmeno l’ombra di uno slavo, o un tedesco, nessuna parentela con viaggiatori mitteleuropei, sangue del Sud il mio, faccia di taralli e ulivi, corpo tarchiato di contadino senza averne le mani forti, e che mi sono trovato a nascere in questo limite per caso. Sì, perché è un limite quello di cui mi accingo a parlarti. Non una città, non una terra, ma l’estrema frontiera di ogni città e di ogni terra.
Immagina un impero, dirigiti verso le sue propaggini, giorno dopo giorno, a cavallo, a dorso di mulo, su un carro annerito dal fumo di carbonaia, in barca e in bicicletta e con ogni mezzo la sorte ti provveda, infine a piedi, e fermati dinnanzi alle ultime case. Osservale bene: sono case ma non del tutto, hanno finestre piccole, come se nessuno dovesse guardarci dentro, e le porte sono chiuse, non c’è vecchio sull’uscio che osservi passare i treni, perché non ci sono treni, né binari, e non si sente voce provenire dall’interno. Fermati una notte e vedrai quelle case spostarsi. Per andare dove?
Credimi, a Trieste le case si spostano per davvero. A volte responsabile è la bora che viene dalla Porta di Postumia, cuore di Carniola, Slovenia centrale, valico tra la Selva di Tarnova e quella del Monte Nevoso. Selve oscure, dove sei costretto a scendere a patti con l’orso, il lupo, la lince e il cervo. Tutti e quattro assieme, non uno di meno, i sovrani con i quali non puoi negoziare. Anch’essi abitano il limite, ne sono cittadini fondatori e onorari, nonostante in nessuna guida della città si parli di loro. Non è un vento la massa d’aria sferzante che proviene da laggiù. Venti sono i soffi che vengono dal meridione, scirocco e libeccio, forieri di pioggia, mareggiate, aria umida che impesta i pensieri. Venticelli sono le brezze, quella di mare, che ama i mesi caldi e le ore del giorno, e risale l’altipiano fino alle pendici occidentali del Monte Carso, in Val Rosandra, o la brezza di terra, che si cala lungo le valli nelle ore più cupe della notte. Sono sospiri, poco più che ansimi.
La bora invece è un dio che non ha fedeli. Non si fa adulare, non esige tributi, manda in frantumi gli altari di chi fosse così ingenuo da dedicarle un tempio. La bora è la voce potente del limite, un coro di confini che risuona all’unisono e distrugge le cose vive e le cose morte. Viene da est-nord-est dicono i meteorologi, dicono anche che a Trieste soffia per circa ottanta giorni all’anno e che in un anno il suo percorso supera la lunghezza dell’equatore. Ama i mesi freddi, le ore notturne e ha un ciclo cinquantennale. Ora ci troviamo nella fase discendente, per cui non siamo più costretti a piombarci le suole delle scarpe o ad attaccarci ferri da stiro alle caviglie o arpionarci coi moschettoni alle funi. Qualche volta supera i 180 km/h, molte volte no.
Ma nessun meteorologo ti dirà, caro lettore, che la bora soffia dalle boccacce storpie delle streghe che vivono in fondo alle grotte carsiche, soprattutto nessuno ti dirà che la bora è il dio che ci ricorda, con la sua turbolenza imprevedibile, che i confini esistono solo sulla carta. Ogni frontiera ha un vento che la assilla. Ogni refolo, prima di aprirci la testa in due e fare uscire le nostre nevrastenie, ci ricorda che possiamo disegnare linee sulle mappe e mettere fili spinati nei boschi, ma non potremo mai dividere in due parti un vento.
Quando non è per la bora, le case si spostano da sole, per cercare una patria o qualcosa che le assomigli. Qui da noi, lo sai, le bandiere sono state piantate da tutti. Tanti, nel secolo scorso, hanno cambiato nazionalità senza avere mai cambiato letto. Di romanzi e saggi che narrano questa schizofrenia ne hai in quantità, non altrettanti che descrivano con minuzia la millimetrica e quotidiana migrazione delle case. In città non lo noterai, perché le case del centro si sono imborghesite, facciate liberty o neoclassiche, segno dell’opulenza della Trieste nuova, edifici che non hanno intenzione di perdere il proprio potere. Restano nel salotto buono, godono nel vedere gli uomini consumarsi nel rito dell’aperitivo tra piazza Unità e Ponterosso, ascoltando gli assoli dei cantanti lirici del Teatro Verdi. Sono case figlie della città ricca, sono squadrate e pulite, austroungariche, si compiacciono di ospitare caffè storici e negozi di abiti firmati. Sono case immobili.
Immobili, salde, con fondamenta come radici sono le case dei villaggi del Carso, ma per altre ragioni. Pietra per tirare su i muri, lastre di pietra per i tetti, pietra per il grande focolare attorno al quale riunirsi e pietra per i portali sui quali venivano scalpellati i nomi degli sposi, pietra per il pozzo. Case spartane che resistono, nelle quali vivono le stesse famiglie anche da centinaia di anni. Sloveni tutti o quasi, gli abitanti del Carso. Di generazione in generazione si sono trasmessi le pietre. Sono case che non migrano perché affermano un’identità granitica. Il minimo spostamento rischierebbe di far spazio ad altri.
Ma ci sono altre case, fuori dai borghi abitati, là dove comincia il bosco e i cinghiali scavano con foga rivoltando le zolle, i cartelli del vecchio confine arrugginiscono stritolati dall’edera e dalla vitalba. Pochissimi ci passano, di rado si soffermano ad osservarle. Non ne misurano il perimetro e la distanza dalla linea immaginaria di frontiera. Sono camminatori della domenica, sono soprappensiero. Eppure sono quelle le case che ci parlano di un’altra Trieste. Sono abitate da ghiri, caprioli, civette, i ginepri le colonizzano, le zecche le infestano e di notte, con la bora, puoi sentire le voci di chi vi abitava o di chi, a pochi passi da lì, ha combattuto in una guerra, la Prima, la Seconda guerra mondiale, o ha pianificato attentati, ha elaborato fughe, si è mimetizzato nella vegetazione per non farsi rastrellare, ha gettato altri uomini negli abissi o lì giace, dopo esservi stato gettato. Sono case che migrano per dimenticare, per cercare pace. Non sono stregate, semmai stregano.
C’è un’altra Trieste. Diversa da quella che ti hanno raccontato. Poco a che vedere con Maria Teresa, le regate veliche, i moli audaci che si incuneano nel mare con un misto di boria e imponenza, le piazze affacciate sulla linea di orizzonte e l’aroma di caffè che ti inebria le narici. Non c’entra con Sissi o il castello di Miramar. Il luogo di cui vorrei parlarti è una città e non lo è. È qualcosa che sta sul limite tra centro e periferia, periferia e bosco, bosco e foresta, Italia e Slovenia e Slovenia e Croazia, Ovest e Est, tra domestico e ignoto. Ti ci porterò, però pazienta. Cercare il selvatico nei vicoli prima di inseguirlo nel reame dell’orso, questa è la prima cosa che faremo assieme.
2.
Non basta una guida
Siamo in cima al Molo Audace. Umberto Saba scrisse: «Per me al mondo non v’ha un più caro e fido / luogo di questo. Dove mai più solo / mi sento e in buona compagnia che al molo / San Carlo, e più mi piace l’onda e il lido?». Non farti deconcentrare dal brusio intorno a noi. Ci sono alcune coppie, alcune decine di baci, una famiglia con cane al seguito, il cane punta un gabbiano reale, qualche fotografo amatoriale che non vede niente al di là dell’obiettivo. Forse c’è un tramonto. Tutto è prevedibile, dal litigio tra innamorati alla proposta di matrimonio, fino al compulsivo scattare foto che non verranno mai stampate. Tutto intorno a noi è addomesticato. Anche per Saba era un luogo domestico: un cantuccio in cui venire a farsi pensoso, una stanza della sua casa. Guarda il cane che risponde ai comandi del padrone e il gabbiano che fa a pezzi un colombo. Chi tra i due è l’addomesticato, chi il selvatico?
Siamo appoggiati alla rosa dei venti, di fronte a noi il golfo. Sulla rosa sta scritto: “fusa nel bronzo nemico 3 novembre MCMXXV”. 1925, il fascismo vuole ricordare il nemico della Prima guerra, l’Austria. Cambia il nome al molo, da San Carlo ad Audace, in memoria dell’omonimo cacciatorpediniere che il 3 novembre 1918 vi attraccò. San Carlo, invece, era il nome della nave che qui affondò a metà Settecento e sul cui relitto fu costruito il primo basamento, poi allungato. Un nome ricorda un naufragio, l’altro una vittoria. La nave sì che affondò, la vittoria non ci fu, perché Trieste non fu presa in combattimento, le forze italiane non riuscirono mai a sfondare le difese austriache del Monte Hermada, nei pressi di Duino. Non ci siamo ancora mossi e già la Storia ci mette pressione. Ce ne metterà ad ogni passo. Potrà essere dura da sopportare.
Alla nostra destra l’inizio del Porto Vecchio. Ha trecento anni, compiuti nel marzo 2019, mentre più giovane è quel gigante che svetta oltre il profilo dei magazzini. Si chiama Ursus, figlio dello Stabilimento Tecnico Triestino, alto più di settanta metri, pesante più di 2 mila tonnellate. Veniva al mondo nel 1913 ed era già la gru galleggiante, o meglio, il pontone galleggiante più grande del Mediterraneo. Nel 1945 i partigiani del IX Korpus, Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, volevano portarselo via come bottino di guerra, ma gli inglesi glielo impedirono. Nel 2011 invece è stato lui, Ursus, quasi centenario, a rompere gli ormeggi e a tentare la fuga in golfo, in alleanza temporanea con una bora apocalittica, e solo dopo cinque ore di lotta con raffiche oltre i 150 km/h i rimorchiatori Uran, Deneb e Taur sono riusciti a far fallire l’evasione.
Un rottame fuori tempo che non serve più a niente, un pugile a fine carriera che si solleva dalla sua carrozzella e si tuffa nel ring per l’ultimo combattimento. È il custode del Porto Vecchio, ossia di ciò che rimane del fu glorioso Porto Franco, voluto da Carlo VI, padre di Maria Teresa. Fino ai primi del Settecento Trieste non era che un villaggio arroccato sul colle di San Giusto nel quale si parlava un dialetto friulano. Nel giro di decenni si trasformò in una metropoli in cui si parlava un dialetto veneto, perché la lingua dell’Adriatico e del Mediterraneo è stata a lungo quella dei suoi padroni incontrastati, i veneziani. A Trieste non c’è giorno in cui non si parli del porto e della vocazione internazionale della città. Guardalo ora e da questo punto: non percepisci la decadenza?
Solleva lo sguardo, lassù sul costone di roccia c’è una piramide, o un’astronave, se avessi un cannocchiale potresti contare file composte di pellegrini alieni, una processione galattica, una processionaria interstellare. È il santuario mariano di Monte Grisa. Prima pietra posata nel 1959 come ex voto del monsignor Santin, che aveva promesso alla Madonna un tempio in suo onore se avesse risparmiato la città dai bombardamenti. Sarebbe dovuto divenire meta di pellegrinaggio mondiale, la nuova Lourdes, la Fatima della cortina di ferro, invece lo spropositato parcheggio è quasi perennemente vuoto, pochi pullman di fedeli, senza dubbio qualche macchina in cui scambiarsi effusioni. La M di Maria doveva essere visibile da ogni angolo, in primo luogo dai credenti rimasti nella Jugoslavia di Tito. I triestini per lo più lo detestano o lo snobbano. Ci vanno la seconda domenica di ottobre per vedere dall’alto la Barcolana, la regata velica più partecipata al mondo. Però tu sospendi il giudizio, quel blocco di calcestruzzo piantato nelle grize (pietraie carsiche) a picco sul mare ti servirà quando sarai disperso nella macchia fitta senza punti di riferimento.
Poco più a sinistra il castello di Miramare, dimora di Massimiliano d’Asburgo e Carlotta del Belgio, stile eclettico che a quel tempo, metà Ottocento, andava di moda da queste parti. Non c’è turista che non ne rimanga incantato. Lo sfarzo degli arredi, la vastità del parco, la maledizione che cade sulla coppia, lui fucilato in Messico e lei impazzita. Eppure, se fai attenzione, ti rendi conto che potrebbe essere perfetto sulla riva di un lago alpino, non su un mare. Paesaggi romantici su tela, trofei di caccia, armi, c’è un ritratto di Carlotta avvolta nell’ermellino imperiale, alberi genealogici, antenati e parenti dappertutto. Certo, l’azzurro delle tappezzerie, e la stanza di lui che ricorda la cabina di una nave, ma è un azzurro confinato al piano degli alloggi privati, non ai saloni di rappresentanza dove regna il rosso.
È un mare controllato il loro, fondali bassi. Il loro immaginario è di terra e fronde, foreste che producono legname gestite con oculatezza. Grandi forestali gli austriaci. Massimiliano è appassionato di botanica. Maria Teresa non è mai scesa a Trieste, non si è mai bagnata nel suo mare. Chi rimane sfocata, fuori quadro, è Sissi, la cognata di Carlotta che qui viene spesso, che fa ginnastica per diverse ore al giorno nel parco e sul lungomare di Barcola, senza scorta, tatuata, anoressica, capace di trovare un’amante al marito. Se c’è un’onda anomala, è lei.
Poco più in là, in lontananza, su un altro promontorio puoi scorgere la sagoma del castello di Duino. Costruito nel 1389 in sostituzione del Castelvecchio, le cui rovine ancora campeggiano su uno sperone di roccia poco distante. Proprietà del casato Thurm und Taxis, gli inventori del servizio postale. Storia analoga: saloni imponenti, Asburgo, nobili tedeschi e italiani che si incrociano tra di loro. I nazisti, durante gli anni dell’occupazione, costruiscono nei suoi sotterranei un bunker, ma non è una novità, dal momento che fortificano tutta la costa. Due fatti esulano dall’ordinario: la permanenza di Rainer Maria Rilke, che vi scriverà le Elegie Duinesi, e il tentativo dannunziano di issare il tricolore sui bastioni. A Rilke è dedicato il sentiero che attraversa la riserva naturale delle falesie di Duino. Qualcuno ti dirà che su quelle pietre aguzze ha trovato ispirazione passeggiando, non è così. Preferiva la tranquillità del Bosco Cernizza, la riserva di caccia dei conti che si estende fino alle risorgive del fiume Timavo.
La storia del tricolore merita di essere ricordata. Durante la decima battaglia dell’Isonzo Gabriele D’Annunzio ordinò una sortita impossibile: raggiungere il castello sotto il fuoco nemico per issare la bandiera. I triestini l’avrebbero vista e l’impeto patriottico li avrebbe mossi alla rivolta. Finì in una pozza di sangue, ma ne parleremo più avanti. Insomma, pensi al sommo poeta che compone le sue elegie camminando sul baratro, con la bora in faccia, e non è vero. Pensi al tricolore sul castello e vedi un fallimento. Gli avanzi di nobiltà da dare in pasto ai turisti, quelli non mancano. Dimmi: secondo te da questo molo sarebbe possibile intravedere una bandiera sventolante? Sono diciotto chilometri in linea d’aria. Aguzza la vista.
Diamo le spalle al mare: alla nostra sinistra il Borgo Teresiano, alla destra il Borgo Giuseppino, costruiti entrambi sulle saline interrate. Linee ortogonali, canali dove far attraccare i velieri commerciali, ponti mobili, palazzi con i magazzini al piano terra, gli uffici al primo e ai piani alti le residenze dei proprietari. Guadagnavano con il mare, ma il mare lo vedevano dalla finestra. Non solo esenzioni da dazi, la gente fu attirata a Trieste con la concessione di privilegi, tra i quali la facoltà di parlare la propria lingua ed erigere i propri edifici di culto. Ecco perché di fronte a te la chiesa greco-ortodossa di San Nicola, poco più dietro la serbo-ortodossa di San Spiridione, la sinagoga, la chiesa protestante e così via, a ciascuno il suo, anche in cimitero, loculi per tutti. L’importante era che la religione non intralciasse l’oleata macchina statale e gli affari. A dimenare le sue cento lingue, diceva l’autore del Dizionario della lingua italiana, l’eminente Niccolò Tommaseo da Sebenico, è il commercio.
Il Borgo Teresiano prende il nome da Maria Teresa, figlia di Carlo VI, colei che fece abbattere le antiche mura medievali e ridisegnò la città, mentre suo figlio, l’imperatore Giuseppe II, dà il nome al borgo che da piazza Unità si estende verso Campo Marzio, dove un tempo si trovava uno dei tre lazzaretti, il San Carlo. Una piazza, quattro nomi: San Pietro, Francesco Giuseppe, Grande, Unità. Secondo alcuni la più grande piazza d’Europa affacciata sul mare. Il gran salotto della Trieste da bere, con una pavimentazione costituita da blocchi di pietra che rimandano alle antiche lastre di arenaria (masegni), illuminata da lucine blu dopo il tramonto. Per evocare il mare, dicono i progettisti.
Sono riproduzioni, come d’altronde i lampioni sulle rive, e piacciono molto ai triestini, danno loro la sensazione che il tempo non sia passato, che da un momento all’altro potrebbe spuntare la carrozza imperiale con Francesco Ferdinando vivo e nel pieno delle sue forze asburgiche. All’alba del 2 luglio 1914 la piazza era gremita per accogliere i sacri feretri di Sofia Chotek, duchessa di Hohenberg, e di suo marito Francesco Ferdinando Carlo Luigi Giuseppe d’Asburgo-Este, arciduca erede al trono, assassinato il 28 giugno a Sarajevo, nelle cui vene scorreva il sangue di più di un centinaio di nobili famiglie europee. Era la vecchia Europa che moriva con loro, e a Trieste il momento era solenne: plotoni di guardie a cavallo, fanteria, vescovo, luogotenenti, ammiragli, guardie municipali, funzionari, funerei colpi di cannone.
Caffè degli Specchi: ordina una sacher, siediti all’aperto. Sei un cittadino del regio impero, le punte dei tuoi baffi trafiggono il cielo come abeti affamati di luce, o i riccioli ti scendono ...